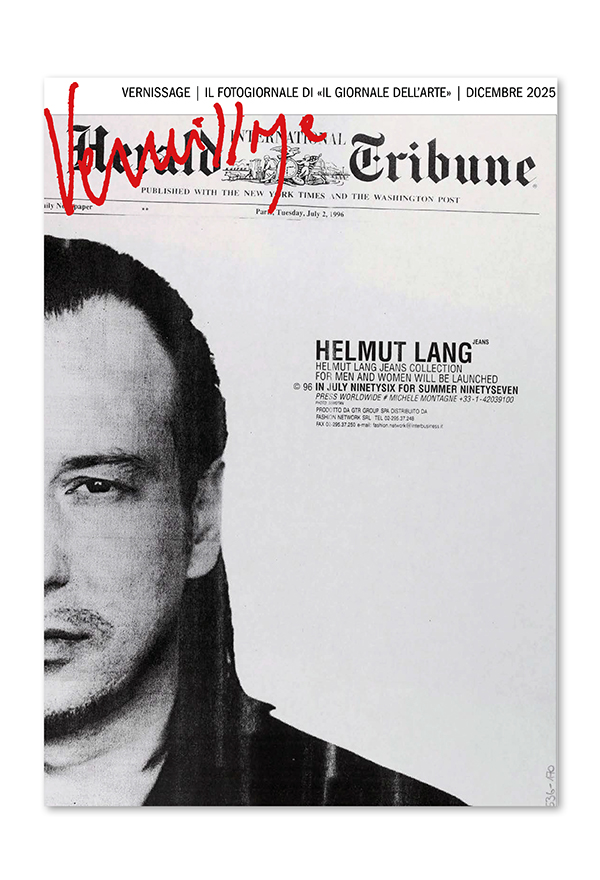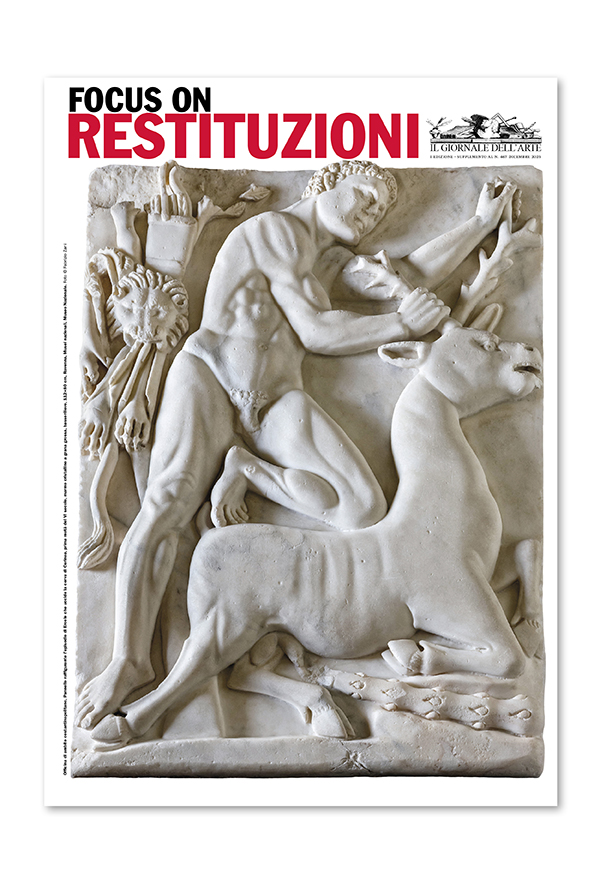Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Daniela Fonti
Leggi i suoi articoliAlla Fondazione Carlo Levi di Roma si registra con grande soddisfazione l’apertura di una nuova, anche se non apertamente dichiarata, stagione celebrativa della figura del grande intellettuale pittore del ’900 di cui nel 2022 ricorrono i 120 anni dalla nascita (Torino, 1902-Roma, 1975). Aperta a ridosso della chiusura per la pandemia da una mostra a Villa Torlonia a Roma, dedicata ai suoi disegni politici, questa felice ripresa di interessi per la pittura di Levi registra nella sua città natale ben due mostre (alla Fondazione Amendola, «I volti del ’900 nei ritratti di Carlo Levi», fino al 28 febbraio; alla Gam «Carlo Levi. Viaggio in Italia. Luoghi e volti», 10 febbraio-8 maggio) integrate da altri due importanti appuntamenti: «Levi e Ragghianti. Un’amicizia fra pittura, politica e letteratura»,aperto alla Fondazione Ragghianti di Lucca fino al 20 marzo, e infine «Carlo Levi. Tutto il miele è finito» al Man di Nuoro (11 febbraio-19 giugno).
Se non si tratta solo di una felice coincidenza c’è da chiedersi come mai si torni a riproporre la figura di un artista-scrittore che in questi anni non ha mai cessato di stimolare la curiosità di letterati, storici e politologi ma la cui pittura, come ebbe a scrivere Renato Guttuso era «assai nota ma poco conosciuta». Probabilmente una delle ragioni risiede proprio in quel formidabile intreccio di motivazioni creative ed etiche che la sostiene, che ne fa una pittura «impegnata» non solo nel versante delle contingenze storico-politiche (aspetto questo chiarissimo negli anni 1950-70 dominati dagli schieramenti ideologici), ma in quello esistenziale di una incessante ricerca di senso nell’inesausta esplorazione della realtà.
Pittura non banalmente sovrapponibile alla letteratura, come risposta alle sfide lanciate dalla Storia (prima fra tutte nella sua biografia, la lotta per la riconquista della libertà durante l’oppressione fascista), ma anche come incessante interrogazione del presente, come testimonianza attiva del vivere e dell’agire. Carlo Levi non ha cessato mai di porre in discussione la società nella quale viveva, e che ha attraversato talvolta da protagonista con la volontà di renderne esemplare testimonianza.
Né ha accettato passivamente, del resto come lo stesso Ragghianti, il diffondersi nell’arte del Novecento di correnti di pensiero mainstream che soprattutto nel secondo dopoguerra avevano decretato la fine della pittura d’ispirazione naturalista, ritenuta intellettualmente regressiva, per sostenere i linguaggi dell’astrazione, del Neodada, dell’Informale; movimenti invece da lui già denunciati nel 1942, nel celebre pamphlet Paura della Pittura, come il riflesso delle tendenze irrazionalistiche e involutive, quelle sì politicamente regressive e pericolose, che minavano la struttura delle libere società democratiche.
La sua pittura, come del resto la scrittura alla quale è così intimamente connessa, non è mai artificiosa, non si adagia su formule compiaciute ma rischia talvolta la caduta per eccesso di autenticità e il lungo racconto di autoanalisi riversato nelle decine di autoritratti (dipinti in tutte le stagioni) sta a dimostrarlo. Forse è proprio questa voluttà di mettersi a nudo che lo rende interessante in questa nostra frigida stagione di compiacimenti concettuali e di mascheramenti.
Confinato dal fascismo nel 1935-36 ad Aliano in Basilicata, «quell’altro mondo, negato alla Storia e allo Stato» trasforma la dura esperienza esistenziale d’isolamento, non solo fisico ma morale ed emotivo, in due distinti percorsi creativi; dapprima dipinge quadri asciutti e antiretorici nei quali tenta di captare tutta la sofferta forza ma anche la potenza magica di quelle esistenze «eternamente pazienti» che sembrano vivere fuori dalla storia, poi, a Firenze nei giorni del rifugio clandestino in piazza Pitti, si affida alle pagine del romanzo-diario tradotto in tutto il mondo che lo ha reso famoso, Cristo si è fermato a Eboli. Un autoritratto del 1945 lo ritrae febbrile con lo sguardo quasi perso, con le labbra serrate di fronte alla tragedia che ha sconvolto l’Europa.
Nonostante le fughe continue in quei primi anni Quaranta, non cessa di dipingere perché la pittura ancor prima della scrittura è un modo per sentirsi vivo; sconcerta quasi pensare a quanto sia stata ricca la produzione pittorica di un uomo costretto a vagare in fuga in Europa, il che ci dà la reale misura di quanto l’esercizio dell’arte gli fosse indispensabile per la sopravvivenza: complessivamente 115 quadri nel breve periodo 1940-45! Forse tenuto a bada dalla pagina scritta, il confronto quotidiano con l’abisso esistenziale della paura suscitata dalle cronache dell’orrore nazifascista non sembra toccare il compatto racconto della sua pittura, fatto di nature morte, ma soprattutto di ritratti, moltissimi, nei quali riconosciamo i volti noti e meno noti dell’intellighenzia italiana resistente alla dittatura.
Proprio a partire dall’inizio del quarto decennio, Levi aveva messo finalmente a punto un linguaggio espressivo originale e assai personale nel quale precipitano, come in un sulfureo crogiolo, tutte le impressioni e le suggestioni che aveva tratto in precedenza dai lunghi soggiorni parigini, dalla frequentazione dei musei, ma più ancora delle gallerie e degli artisti dell’École de Paris che animavano quella irripetibile stagione.
Anche se nelle sue accensioni cromatiche ne è stilisticamente lontana, la pittura leviana del quarto e quinto decennio condivide con la produzione dei primi anni Venti, dalle composite ascendenze (da Felice Casorati ai postimpressionisti), lo stesso imperativo etico: prima che una scelta estetica dipingere è un atto di testimonianza ed espressione di un giudizio morale.
Non c’è dubbio che, nonostante l’apparente continuità stilistica, la pittura di Levi, mai assente dalla scena delle grandi mostre dedicate al ’900, sia stata esposta e commentata negli ultimi decenni per comparti cronologici; prediletta in queste ultime stagioni anche dal mercato, la produzione assimilabile al «Realismo magico», molto apprezzata e richiesta quella legata al confino in Basilicata (dal 1934 al ’39 ca), dove si raggiunge un ammirabile equilibrio fra contenuto lirico e sguardo sociale; criticamente più trascurata, anche se molto diffusa nel mercato, quella degli ultimi due decenni di attività nella quale prevale un’iconografia neorealistica d’immediata presa (soggetti meridionalistici) o di facile comunicatività (la ripetuta serie degli «amanti»).
Ci si augura che queste partecipi riletture, oltre a confermare per Levi la statura di un vero interlocutore dell’arte europea del ’900, portino alla luce valori autenticamente pittorici restati un po’ nell’ombra: come la serie dei grandi «Carrubi» degli ultimi anni (nei quali sembra volersi arrischiare fino alle soglie dell’Informale) o le splendide nature morte degli anni Quaranta, dove la tragedia della guerra appare sublimata, ma non rimossa, nella desolazione delle spiagge livide del nord, disseminate di animali scuoiati, di conchiglie vuote, contro l’orizzonte nascosto allo sguardo.
L'autore è Presidentessa della Fondazione Carlo Levi, Roma

Un particolare di «Autoritratto» (1945) di Carlo Levi. Foto Riccardo Lodovici

«La madre e la sorella» (1926) di Carlo Levi