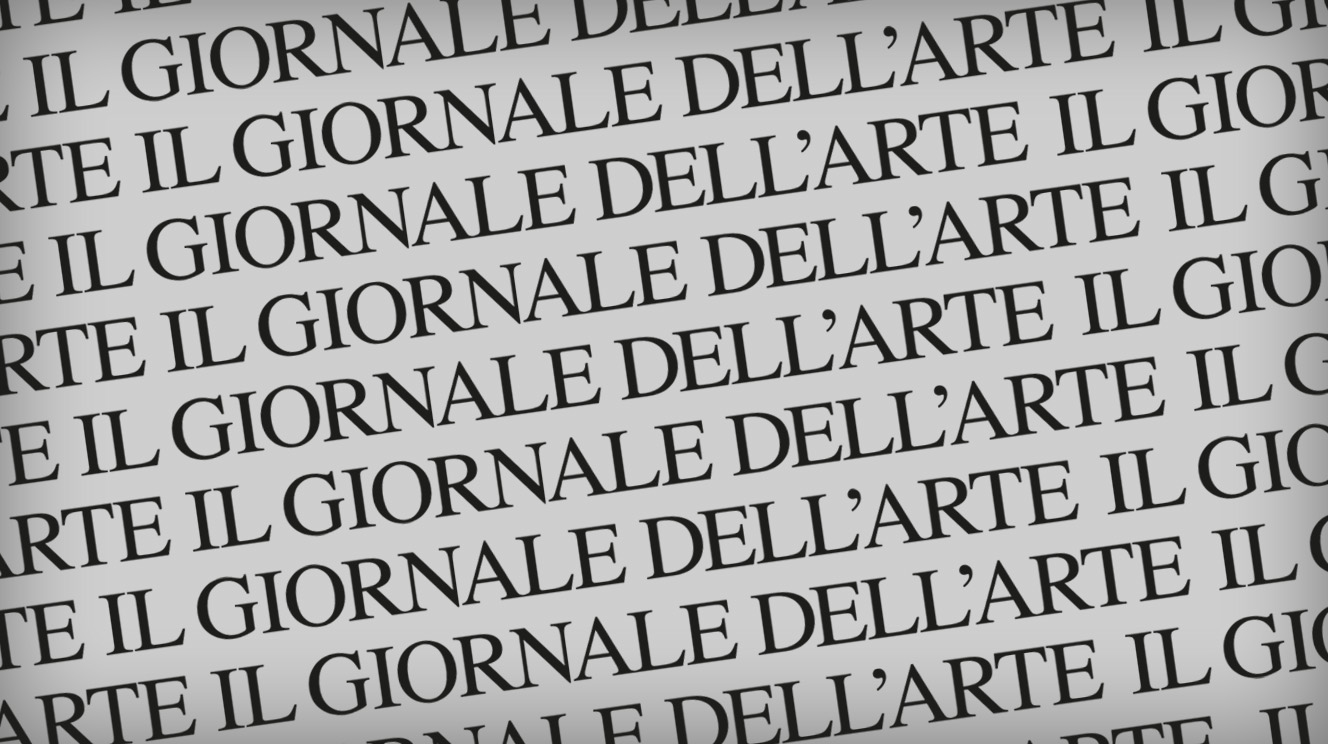Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Federico Florian
Leggi i suoi articoliNon fu un’insana mania biblioclasta a spingere John Latham (Livingstone, Zambia, 1921 - Peckham, Gran Bretagna, 2006), nel 1966, a masticare le autorevoli pagine del saggio Arte e cultura del critico d’arte americano Clement Greenberg. L’artista britannico, ingoiando uno dei fondamenti della recente critica d’arte, piuttosto, intendeva ripudiare le presunte «verità» in esso contenute. Così come, appiccando il fuoco a torri fatte di libri (da lui chiamate «skoob towers»), non faceva altro che parodiare e disconoscere ogni sistema di conoscenza razionale. Equipaggiato di minore furia distruttiva ma di spirito altrettanto rivoluzionario, Gianfranco Baruchello (Livorno, 1924), negli stessi anni, s’impegnava a decostruire il linguaggio del film e della pittura: il primo attraverso inquadrature prevalentemente fisse e un montaggio anti narrativo, la seconda mediante assemblaggi di oggetti tridimensionali, selezionati sulla base di arbitrari principi combinatori. Quelle di Latham e Baruchello sono pratiche complesse, fuori da correnti artistiche riconosciute, in cui convergono pittura, scultura, performance e video. La Triennale di Milano, fino al 22 febbraio, ospita una doppia mostra dedicata ai due artisti, a cura di Alessandro Rabottini e sotto la direzione artistica di Edoardo Bonaspetti. La personale di Baruchello, intitolata «Cold Cinema», si concentra soprattutto sulla sua produzione filmica e video (tra le chicche in mostra, «Verifica Incerta», 1964-65, film composto da oltre 150mila metri di pellicola commerciale americana rimontata e riassemblata con del nastro adesivo, e «Tre lettere a Raymond Roussel», 1969, una grande videoinstallazione a tre canali dedicata al tema del sogno e dell’inconscio). Accompagnano il percorso del visitatore dipinti, materiale documentario e oltre cento disegni, simili a tortuosi diagrammi figurativi, popolati da microscopici elementi visuali interconnessi e ispirati a un’estetica meccanico-combinatoria. «Great Noit», la prima antologica di Latham in un’istituzione pubblica italiana, raccoglie 40 opere dell’artista ideatore della «time-based theory», realizzate tra il 1955 e il 1998. Immancabili i «book reliefs», tele che si espandono tridimensionalmente inglobando libri, oggetti e componenti metallici: immediato è il confronto con «La prise de conscience II», un dipinto-scultura di Baruchello composto da una pila di quotidiani su tavola ed esposto nella sala adiacente. Geniale la ricostruzione della personale che Latham tenne alla Lisson Gallery di Londra nel 1992: un «long painting», eccezionalmente ricreato per l’esposizione milanese, attraversa diagonalmente l’intera stanza, il cui spazio è costellato dai «Cluster», conglomerazioni planetarie di libri e detriti sospesi al soffitto. Infine, da non perdere lo straordinario «The Story of the RIO» (1983), una sequenza di 17 pannelli su muro che illustrano la storia della conoscenza dell’uomo: un’opera biblica, summa del pensiero e della filosofia dell’artista britannico.
Altri articoli dell'autore
In occasione del centenario della nascita del maestro cinetico più celebre al mondo, anche un convegno internazionale, oltre a mostre in tutta Europa
La prima edizione della Triennale di arte contemporanea della città francese è un prototipo per una rassegna alternativa: attenta a una dimensione locale più che globale, nasce dal desiderio di relazionarsi attivamente e genuinamente con il tessuto urbano e la comunità dei cittadini
All’Eye Museum di Amsterdam la personale della raffinata artista e filmmaker greca
La sua prima retrospettiva istituzionale negli Stati Uniti, al MoCA di Los Angeles, è una profonda riflessione del rapporto tra verità, spettacolo e rappresentazione