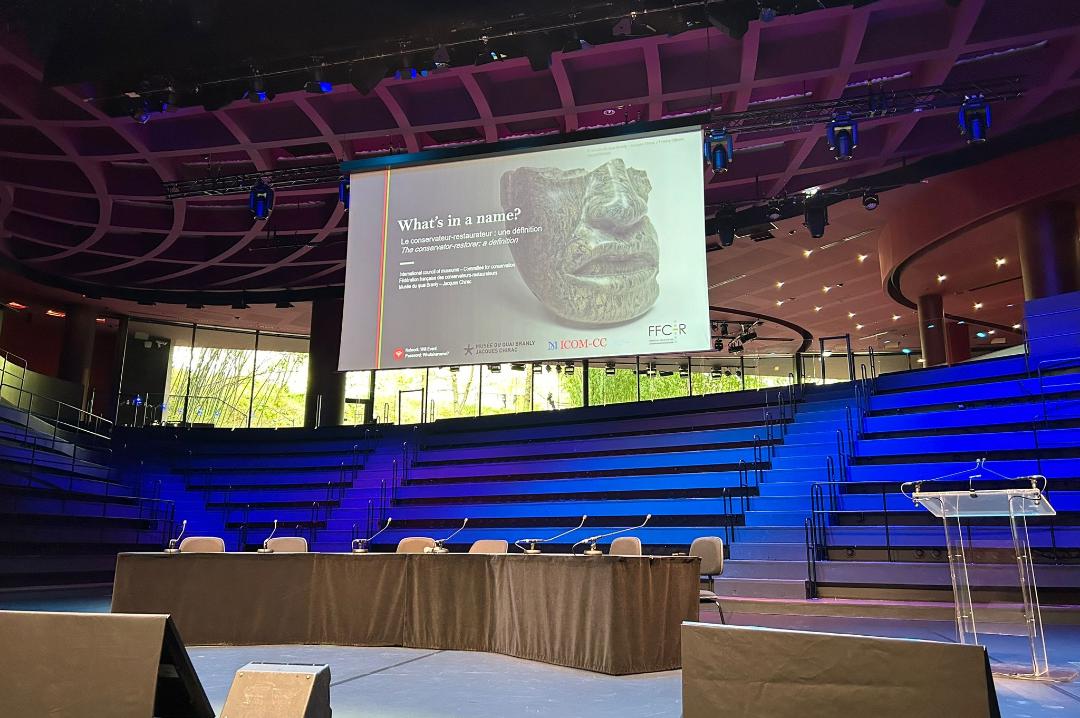Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Simona Sajeva
Leggi i suoi articoliTra il 20 e il 22 febbraio, presso l’Università Politecnica di Valencia, si è svolta «Exciss» (Extreme Conditions Innovative & Sustainable Solutions In Mural Painting Conservation), conferenza internazionale sulla conservazione delle pitture murali.
Inizialmente programmata a novembre 2024, era nata dalla constatazione che nulla, o quasi, esiste in materia di preparazione e gestione delle emergenze che possono verificarsi in condizioni estreme, specificatamente per la conservazione delle pitture murali. Rinviata a causa dell’alluvione che ha travolto la città, Exciss non soltanto è stata riorganizzata, ma anche rielaborata nei suoi intenti, contenuti e prospettive, assumendo così nuove importanti responsabilità.
L’Università Politecnica di Valencia, a capo di una lunga cordata di istituzioni nazionali, ha esteso il programma e le sessioni, concepite in modo da accogliere prospettive e esperienze diverse, per fasi e approcci. Alle quattro sessioni principali («Protocolli di attuazione prima delle emergenze e dei disastri»; «Conservazione preventiva nell’ottica del cambiamento climatico e delle emergenze»; «Revisione degli interventi passati, inadeguati in condizione di emergenza»; «Trattamenti e soluzioni per opere affette da eventi estremi»), ne è stata aggiunta una quinta («Dana-Depresión Aislada en Niveles Altos-El Arca de Noè: Riada Valencia 2024»), tenuta presso il Salone Alfonso il Magnanimo del Centro Cultural La Beneficencia de Valencia, dedicata proprio alla mobilitazione e alle azioni delle istituzioni locali durante e post alluvione.
Proprio quest’ultima sessione, particolarmente toccante, ha fatto emergere quanto, nella gestione di un’emergenza di tale portata, entri in gioco il fattore umano e la conoscenza profonda del territorio, non soltanto tecnica, ma anche socio-antropologica. La nozione stessa di patrimonio, inteso come memoria, ha rivelato connotati istintivi e pragmatici. Istituzioni competenti in conservazione si sono immediatamente mobilitate per patrimoni ordinariamente dati per scontati, come gli archivi civici, le memorie e le fotografie familiari (per citarne uno: «Salvem les fotos», progetto guidato dal Culture Network of Public Valencian Universities, la GE-IIC, l’Icom e l’Etno), contribuendo a rafforzare il senso di comunità e, così facendo, la partecipazione collettiva. Gli stimoli sono stati innumerevoli, riguardanti condizioni estreme sia di origine naturale sia di origine antropica, come quelle originate da inopportuni interventi sul territorio e da eventi bellici.
È stato interessate osservare, contributo dopo contributo, come alcuni aspetti, che potrebbero convergere verso un obiettivo comune, sono invece affrontati in maniera generalmente polarizzata. Ad esempio, il ruolo della tecnologia spesso proposto come quasi alternativo alla capacità organizzativa comunitaria. Oppure, il presentare la conservazione ordinaria e quella in emergenza come profondamente distinte.
Se da un canto la polarizzazione può essere un esercizio teorico utile per identificare aspetti altrimenti poco apparenti, nel concreto è più utile lasciare da parte posizioni di interesse, qualunque esso sia, per concentrarsi sul significato della conservazione. Che cosa è, quale ne è il senso, chi l’oggetto e chi il soggetto. Tornando a questi pochi, elementari interrogativi, si ritrova la bussola, che sia in condizioni estreme o no.
Le tecnologie d’avanguardia, sia per strumentazione sia per capacità computazionali dei dati acquisiti, sono sicuramente utili, in quanto strumenti messi a servizio delle capacità operazionali e organizzative degli operatori della conservazione e delle amministrazioni delle comunità. Entrambe hanno avuto modo durante Exciss di mostrare i propri apporti e i propri limiti, ma soprattutto i propri ruoli. Com’è evidente come per chi opera in questo settore, la capacità umana di settore è in cima a ogni intervento di gestione delle emergenze perché ad essa fa capo l’organizzazione, basata sulla conoscenza del territorio e delle risorse locali.
Da questo consegue l’altro aspetto oggetto di polarizzazione, ovvero conservazione in condizioni ordinarie versus situazioni emergenziali. Ciò che accade in situazione emergenziale riflette, in maniera enfatizzata, ciò che avviene nella pratica ordinaria della conservazione delle pitture murali, così anche di ogni bene culturale connesso al sistema architetturale. Ovvero, nonostante la condizione fisica di connessione all’edificio richieda un approccio integrato, tecnico ma anche e soprattutto decisionale, nella realtà si assiste ancora ad una compartimentazione. Da una parte l’edificio e poi tutto il resto, considerato quasi accessorio.
Con la conseguenza che l’attuale strutturazione del processo conservativo in ambito architettonico poco si presta alla gestione delle emergenze, poiché queste necessitano di circolarità. Ovvero, sia partecipazione al processo decisionale da parte di tutte le figure che intervengono nella conservazione, sia una visione ciclica degli eventi, che si tratti di una catastrofe o di un intervento di restauro. Una strada verso la condivisione di responsabilità e di contributo, con la consapevolezza che ogni situazione è mutevole, che lo sia con gradualità, ovvero in condizioni ordinarie, che con imprevedibile accelerazione, come in situazione emergenziale.
Purtroppo, in emergenza, la coperta è quella preparata prima, nella fase di conoscenza dei rischi e organizzazione e pianificazione della gestione delle emergenze. Se la preparazione è inadeguata ai rischi, chi ne soffrirà sarà proprio l’atto di conservare.
Questo è stato il messaggio principale del discorso inaugurale, elaborato dai direttivi dell’International Scientific Committee for Mural Painting (Iscmp) e dell’International Scientific Committee on Risk Preparedness (Icorp), comitati scientifici internazionali di Icomos. Rohit Jigyasu ed io gli abbiamo dato voce, aprendo la conferenza esplorando le possibili convergenze dei punti di vista. Questo dialogo ha permesso di individuare complementarità tra i rispettivi approcci, sottolineando come un’emergenza non debba essere considerata un evento isolato, ma parte di un ciclo in cui le esperienze accumulate prima, durante e dopo arricchiscono continuamente la preparazione.
Da qui l’iniziativa degli organizzatori, l’Università Politecnica di Valencia in testa, di dare il via a un nuovo progetto, la Carta di Valencia, al quale l’Iscmp e l’Icorp continueranno a contribuire come parte attiva del comitato scientifico. Un documento di preparazione e gestione delle emergenze, specifico per la conservazione delle pitture murali, che faccia tesoro di tutto quanto emerso durante la conferenza. Un progetto che vedrà una prima tappa già a settembre 2025, con una comunicazione della strutturazione del progetto e si avvierà successivamente.
Altri articoli dell'autore
Il re nudo • Come la voce di Scarlett Johansson, anche lo stile (e il copyright) delle immagini a firma del duo nipponico Miyazaki e Takahata è stato adottato da OpenAI per implementare la prestazione di ChatGpt. Senza prima chiedere il consenso
A Lione quasi 2mila partecipanti al 36mo Congresso mondiale del CIHA, la più antica organizzazione internazionale di categoria
Intervista all’avvocato Pietro Celli che ha seguito la procedura presentando il ricorso che ha sbloccato la situazione di stallo, durata otto anni
A Parigi una conferenza sulla professione, codificata nel 1984, ma oggi