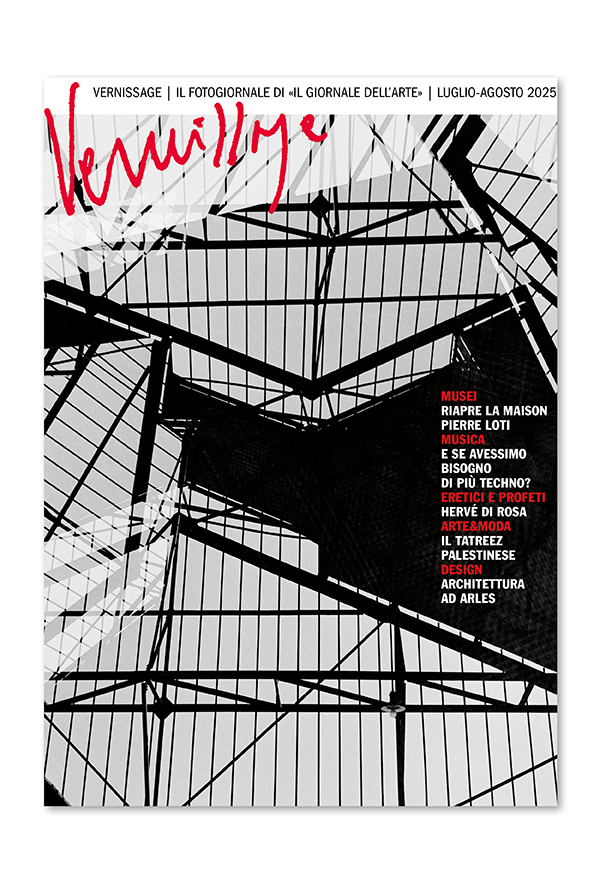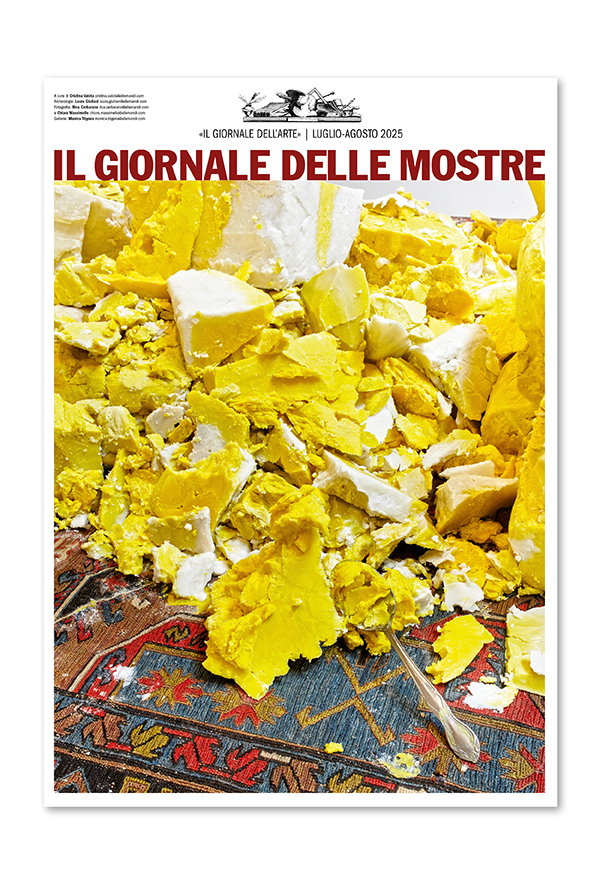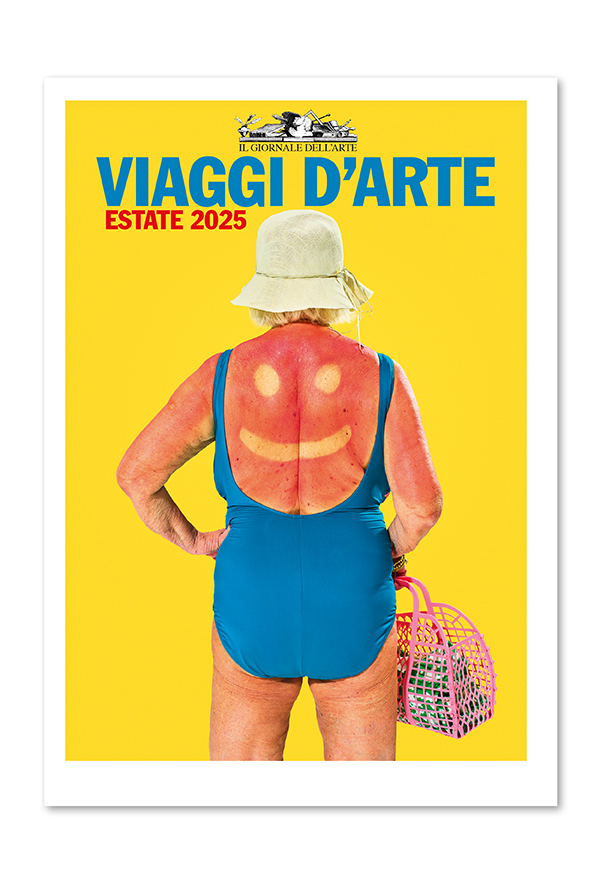Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Laura Lombardi
Leggi i suoi articoliDal 10 aprile al 9 settembre Palazzo Medici Riccardi ospita una grande mostra monografica, promossa da Città Metropolitana di Firenze e organizzata da Fondazione Mus.e, dedicata a «Giovan Battista Foggini (1652-1725) Architetto e scultore granducale», una delle figure più rilevanti della scena artistica fiorentina tra Seicento e Settecento. Ce ne parla il curatore, Riccardo Spinelli.
Per il grande pubblico, che forse di Firenze conosce soprattutto il Rinascimento, chi era Foggini?
Foggini è prima di tutto un architetto ma anche un eccellente scultore e decoratore d’interni, che lavora a cavallo del secolo e che godrà della protezione del granduca Cosimo III de Medici, con il quale darà vita a un sodalizio di grande livello, diventando l’interprete della magnificenza medicea, cara al sovrano. Foggini si forma a Roma dove trascorre un triennio e studia con Ercole Ferrata, ma anche il disegno con Ciro Ferri (il pittore che aveva portato a termine gli affreschi di Pietro da Cortona a Palazzo Pitti), declinando poi quegli insegnamenti in una forma molto originale, di un Barocco più temperato rispetto a Bernini. Tuttavia, proprio per la capacità di operare a tutto campo, progettare palazzi ma anche oggetti di minor impegno, lo sento come una sorta di Bernini fiorentino: non esiste quasi nulla a Firenze, in quei decenni, che non abbia avuto il suo placet, diretto o indiretto. È davvero sconcertante il numero di suoi progetti portati a termine.
Perché in Palazzo Medici Riccardi?
La mostra occupa sei sale del palazzo a piano terra, con la galleria che si affaccia sul giardino degli aranci stuccata proprio su disegno di Foggini. Il questo edificio l’artista sarà impegnato per quasi quarant’anni e sarà lui a salvare la Cappella dei Magi affrescata da Benozzo Gozzoli, che rischiava di essere sacrificata per la creazione di un nuovo scalone di accesso al piano nobile nel corso dei lavori di ampliamento del palazzo. Interventi poi svolti col prolungamento di sette finestre su via Larga (ora via Cavour) fatti in continuità con la facciata michelozziana, andando a ritrovare anche la pietra forte nelle cave a Fiesole, che vedranno però demolito lo studiolo di Piero il Gottoso, padre di Lorenzo il Magnifico. Per la Cappella dei Magi Foggini inventa una sorta di dente, che porta a una perdita minima dell’affresco di Benozzo. Una piccola sezione della mostra è ospitata nella Biblioteca Riccardiana, che vanta la sala di lettura più bella del mondo con l’affresco di Luca Giordano, poco nota.

Giovan Battista Foggini, «Atalanta e Ippomene», fine XVII secolo, Dresda, Skulpturensammlung, Staatliche Kunstsammlungen

Giovan Battista Foggini e Botteghe granducali, «Cassetta»,1720 ca, Minneapolis, Minneapolis Institute of Art, Gift of Bruce B. Dayton
La mostra si svolge in occasione del terzo centenario della morte di Foggini, con prestiti importanti da musei e da collezioni private. Com’è articolata?
Foggini muore il 12 aprile 1725, quindi la mostra si configura proprio come un omaggio «pieno»: il percorso è strutturato in sezioni perlopiù tematiche, ma si parte con i lavori del triennio romano, il rientro a Firenze e la partecipazione al decoro scultoreo della Cappella Corsini al Carmine. A questo periodo si riferiscono anche due ritrovamenti importanti: un bozzetto in terracotta per la «Crocifissione» conservata a Palazzo Pitti nel Tesoro dei Granduchi, che doveva essere realizzata in marmo ma che sarà poi gettata in bronzo, e un rilievo in terracotta con «Porsenna libera Clelia», realizzato «retour de Rome». La mostra è stata occasione di importanti restauri, in parte finanziati da Mus.e, in parte dall’Opificio delle Pietre Dure ma anche dai musei prestatori. Dal Louvre giungono, per la prima volta in Italia, le copie in marmo di due opere di scultura antica, una delle quali firmata, eseguite per il Re Sole, Luigi XIV, il quale le aveva ordinate tramite un suo fiduciario di passaggio a Firenze; spedite tra il 1684 e la fine del 1685 saranno destinate a Versailles. D’altronde il rapporto tra Foggini e l’antico, con le repliche in bronzo che fa di marmi classici, è importante anche per la storia del collezionismo mediceo.
Come restituire l’attività di Foggini architetto in una mostra?
La progettazione architettonica è un settore primario per Foggini, ma esporre per cinque mesi disegni è difficile. Il Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi presta eccezionalmente un taccuino, il «Giornale», quanto mai ricco di studi, che sarà visibile con il cambio periodico delle carte. Inoltre, per non penalizzare questo aspetto abbiamo deciso con l’architetto che cura l’allestimento, Luigi Cupellini, di riprodurre alcuni disegni realizzando delle gigantografie montate su telai che tappezzano alcune sale della mostra.
La mostra include sculture in bronzo ma anche realizzate in altri materiali.
Ci sono una decina di gruppi in bronzo, capolavori quali «Mercurio e Argo» dal Bargello, «Atalanta e Ippomene» dalle Staatliche Kunstsammlungen di Dresda, oppure «Apollo e Marsia» dal Bayerisches Nationalmuseum di Monaco di Baviera in una sezione dedicata alle sculture di piccolo formato. Laddove non abbiamo potuto avere gli originali in bronzo, abbiamo esposto delle versioni in cera oppure in porcellana della Manifattura di Doccia, realizzate a metà Settecento, quando il figlio di Giovan Battista, Vincenzo, vendette le forme del padre alla Manifattura che le riprodusse in maniera seriale in porcellana bianca che poteva emulare il marmo.
L’ultima sezione della mostra è dedicata a Foggini decoratore, dove la straordinaria fantasia dell’artista lascia a bocca aperta.
Sono esposte manifatture di vario genere, che danno idea del fasto della cultura medicea di quegli anni. Oggetti «bomba», tra cui il tavolo intarsiato realizzato nel 1714 per Cosimo III, prestito eccezionale delle Gallerie degli Uffizi, poi reliquiari provenienti dal Museo delle Cappelle Medicee e dal Tesoro dei Granduchi a Pitti, come quello della culla del Bambin Gesù, uno dei pezzi più originali in questo genere di oggetti. Poi si vedono altri manufatti d’eccellenza tra i quali una cassetta in ebano, pietre dure e bronzi proveniente dal Minneapolis Institute of Art. Infine si espone il già ricordato «Giornale» del Gabinetto degli Uffizi, un insieme di disegni della maturità di Foggini, databile tra il 1713 e il 1718, e che, a conclusione della mostra, conferma la genialità di questo artista, dalla creatività inesauribile, capace di adattarsi a tutte le situazioni, ma anche di «alleggerire», nel campo del rinnovamento architettonico, le strutture di chiese antiche quali furono San Giorgio alla Costa, Santa Maria di Candeli, San Jacopo sopr’Arno.

Giovan Battista Foggini, «Ritratto del cardinale Francesco Maria de’ Medici»,1683-86, Cerreto Guidi (Firenze), Villa medicea, Museo storico della Caccia e del Territorio, Direzione regionale Musei nazionali Toscana e le Ville e Residenze Monumentali Fiorentine

Giovan Battista Foggini, «Plutone rapisce Proserpina», 1703 -04, Roma, Gallerie Nazionali di Arte Antica, Palazzo Corsini