
Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Marta Cereda
Leggi i suoi articoliÈ il romanzo di un amore estremo. È la storia del massacro di Jeju. È una candela accesa negli abissi dell’umanità. Così Han Kang (1970), scrittrice coreana vincitrice del Premio Nobel per la Letteratura nel 2024, ha definito il suo ultimo romanzo, intitolato «Non dico addio», edito da Adelphi nella traduzione italiana di Lia Iovenitti. È anche un libro che parla di arte contemporanea, costantemente, sotto traccia, anzi, per utilizzare un riferimento caro all’autrice, sotto una coltre di neve leggerissima che cade per l’intero volume, dalla prima pagina, dalla prima riga addirittura, sino all’ultima, diventando sempre più fitta. La neve che «ha quasi sempre un che di irreale. Sarà il ritmo con cui cade? La sua bellezza? Di fronte a quella lentezza fuori dal tempo, le cose importanti e quelle che non lo sono all’improvviso si distinguono in modo netto».
C’è una scrittrice, c’è una regista, c’è un laboratorio di scultura, ci sono dei disegni su una parete, c’è un progetto per un’installazione. C’è molto altro, in questo libro: la storia vede protagonisti due donne, due pappagalli, una madre, tante ombre, un intero popolo, ma qui ci si vuole concentrare soltanto su come, all’interno di un romanzo così ricco e poco lineare, l’arte contemporanea possa essere un filo conduttore e una chiave di lettura per rappresentare, interpretare ed esorcizzare la realtà, come già nel caso di «La vegetariana» (Adeplhi, 2016). Han Kang, che nel suo curriculum ha una sezione dedicata alla produzione come artista visiva, con alcune performance (2016-18), un video a due canali dal titolo «I Do Not Bid Farewell» e la scultura «Funeral» (2018), non ha quindi soltanto una scrittura decisamente visiva, ma è in grado di inserire nella sua prosa riferimenti a opere d’arte potenziali, descritte con dettagli tanto precisi e puntuali da far domandare al lettore se esistano già nel reale o se mai verranno realizzate.
In «Non dico addio», c’è un’installazione che vorrebbe essere la resa tridimensionale di un sogno ricorrente che ossessiona una delle due protagoniste, la scrittrice Gyengong-ha. In una pianura ci sono migliaia di tronchi neri, senza rami o foglie, dalle cime recise, di altezze diverse, «inclinati e storti, sembravano migliaia di uomini, donne e bambini emaciati, curvi sotto la neve». Ricordano lapidi, richiamano un cimitero, perché dietro ogni tronco c’è un tumulo. Questo luogo si trova vicino all’acqua, vicino al mare, che lentamente sale e minaccia di strappare le ossa dalle loro sepolture. Ed è proprio questo che rende il paesaggio così angosciante. Come salvare i resti di chi è stato seppellito qui, se di un cimitero si tratta? Come conservarne la memoria? Come esorcizzare questo incubo?
Se nella scrittura di Han Kang l’onirico ha lo stesso valore del reale e i sogni proseguono altrove, poiché non c’è gerarchia tra vita onirica e vita vigile, allora per Gyengong-ha la soluzione per aver tregua da questo incubo è trasportarlo nella realtà, realizzare quello che si potrebbe definire un monumento, un memoriale, un’opera di arte pubblica: trovare un luogo adatto, piantare novantanove tronchi d’albero tinti di nero «come per rivestirli di un abito intessuto di notte fonda, perché il loro sonno rimanesse per sempre indisturbato», quindi aspettare non il crescere della marea, bensì il cadere della neve. «Filmiamo l’intera operazione e ricaviamone un corto», propone Gyengong-ha a In-Seon, amica fotografa e documentarista, che accetta con entusiasmo. Passano quattro anni, in cui «ogni tanto mi veniva da pensare che quel rimandare continuo stava diventando l’essenza stessa del progetto», quattro anni di solitudine crescente, di isolamento, in un appartamento nella periferia di Seoul per Gyengong-ha, in una casa nel bosco dell’isola di Jeju per In-Seon.
In-Seon, una laurea in fotografia, «aveva sviluppato un interesse per i documentari alle soglie dei trenta e l’aveva perseguito con caparbietà per dieci anni, nonostante non ci si mantenesse». La sua filmografia ha come filo conduttore il racconto di figure femminili le cui vite hanno attraversato la storia: ha realizzato prima un documentario nella giungla vietnamita, con interviste alle donne sopravvissute agli stupri dei militari coreani durante la guerra, quindi un video che racconta la quotidianità di un’anziana malata di Alzheimer che, negli anni Quaranta, era stata attiva nella resistenza armata in Manciuria. E se, solitamente, nel percorso artistico si parte dall’autobiografia per poi avere uno sguardo più universale, In-Seon spiazza pubblico e critica: il suo lavoro successivo è un video in cui intervista se stessa, come sagoma difficilmente distinguibile nell’oscurità, in un montaggio in cui le sue dichiarazioni si sovrappongono a immagini del massacro di Jeju nel 1948, quando l’esercito sudcoreano uccise un numero imprecisato di persone (Han Kang parla di 30mila civili uccisi, ma le fonti riportano numeri che vanno da 14mila a 100mila vittime).
In un racconto frammentato, in cui la voce narrante si modifica, in cui non c’è linearità, proprio come accade nei sogni, Gyengong-ha cambia idea e decide di non voler realizzare il suo progetto. Convinta che il sogno si riferisse al massacro di Gwangju del 1980, altro atroce episodio della storia coreana a cui sia Kang sia il suo alter ego Gyengong-ha hanno dedicato un romanzo, si rende conto che ciò che la perseguita è il destino di solitudine individuale, rivelato da «quegli incubi che, notte dopo notte, hanno saccheggiato la tomba della mia vita. Dicendomi che accanto non mi è rimasta una sola persona vivente». È troppo tardi, perché In-Seon ha già cominciato: ha accumulato 99 tronchi, li ha fatti asciugare, ha iniziato a lavorarli per creare quelle figure ingobbite e ritorte. Ha scelto di realizzarli non a grandezza naturale, bensì alti oltre due metri (contrariamente a quanto accade in «Funeral», la scultura realizzata da Han Kang nel 2018 in cui i tronchi sono affastellati in una piccola teca, in scala ridotta). L’artista si è impossessata del sogno di Gyengong-ha e l’ha trasformato, tanto che la loro visione sorprende l’amica scrittrice: «avevo immaginato che verniciarli di nero sarebbe stato come rivestirli di un sonno profondo; allora perché adesso rassomigliano a persone che si dibattono in un incubo?».
In questo stato di dormiveglia, in questo buio rischiarato solo dalla luce di una candela, In-Seon conduce Gyengong-ha fino al luogo prescelto, quella pianura da riempire di tronchi, quella pianura dove, se Kang sceglie «Non dico addio» come titolo del suo nuovo romanzo, Gyengong-ha decide che «Nessun addio» sarà il titolo dell’installazione: un addio incompiuto, un addio rimandato a un tempo da definire, a un tempo che non può essere determinato nel reale, mentre la neve dal «peso di una piuma, della punta di un pennello» continua a scendere.
Non dico addio
di Han Kang, traduzione di Lia Iovenitti e cura editoriale di Milena Zemira Ciccimarra, 265 pp., Adelphi, Milano 2024, € 20
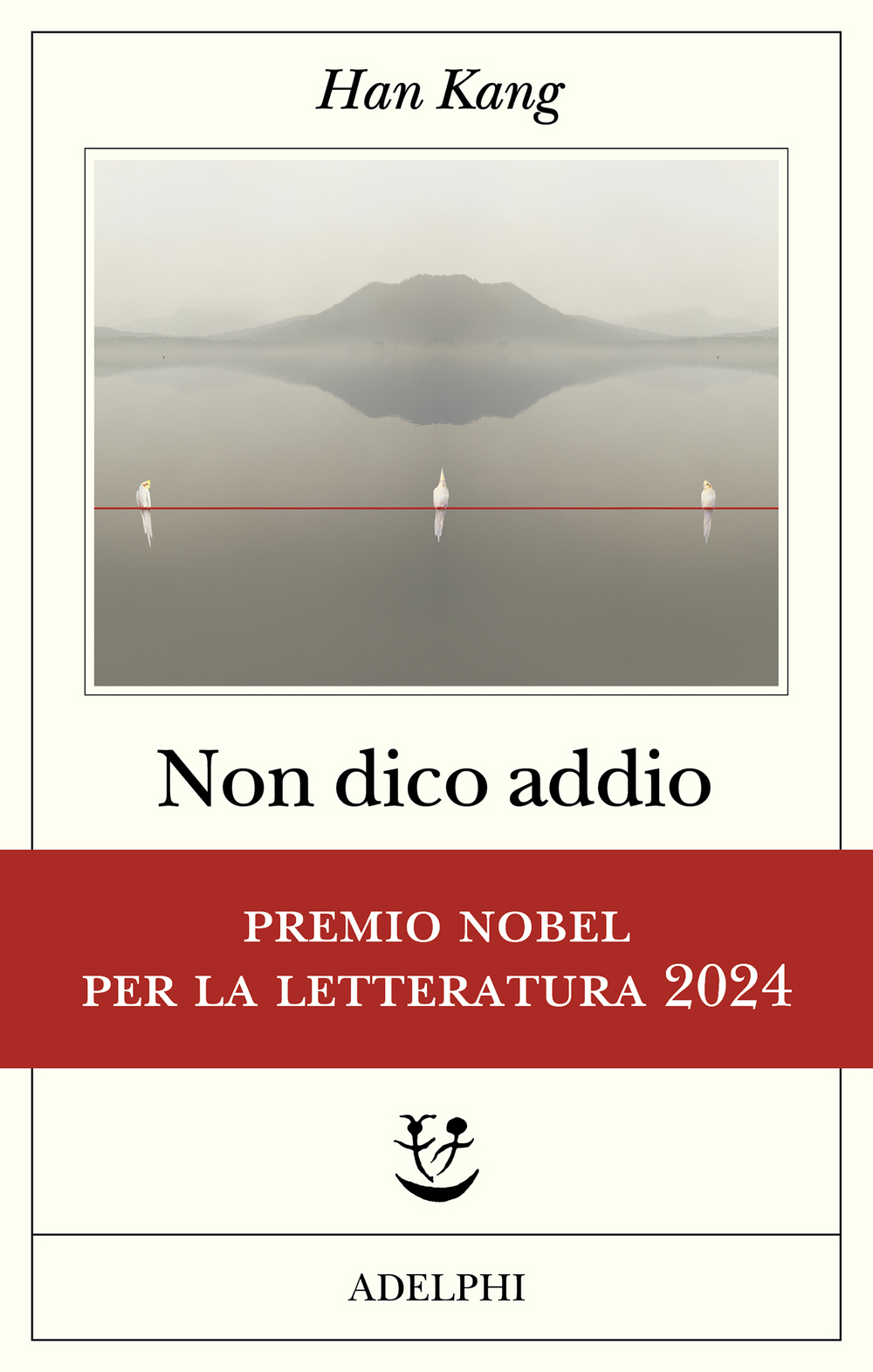
La copertina del volume
Altri articoli dell'autore
Identità capovolte e arte come specchio: il contemporaneo nell’ultimo libro della scrittrice canadese
Il nuovo ciclo del progetto di GAMeC in tre paesi nel bergamasco affida a tre video l’indagine della relazione tra umano e animale


















