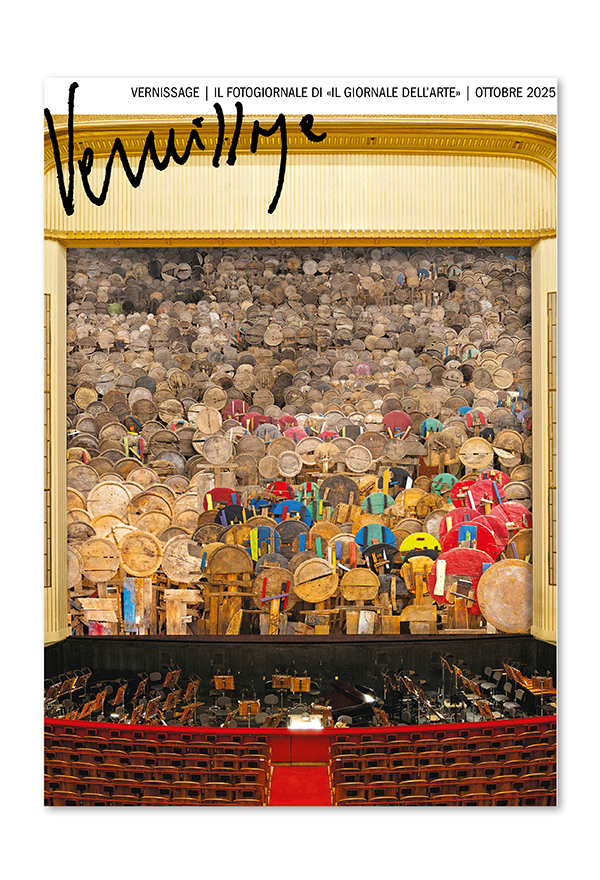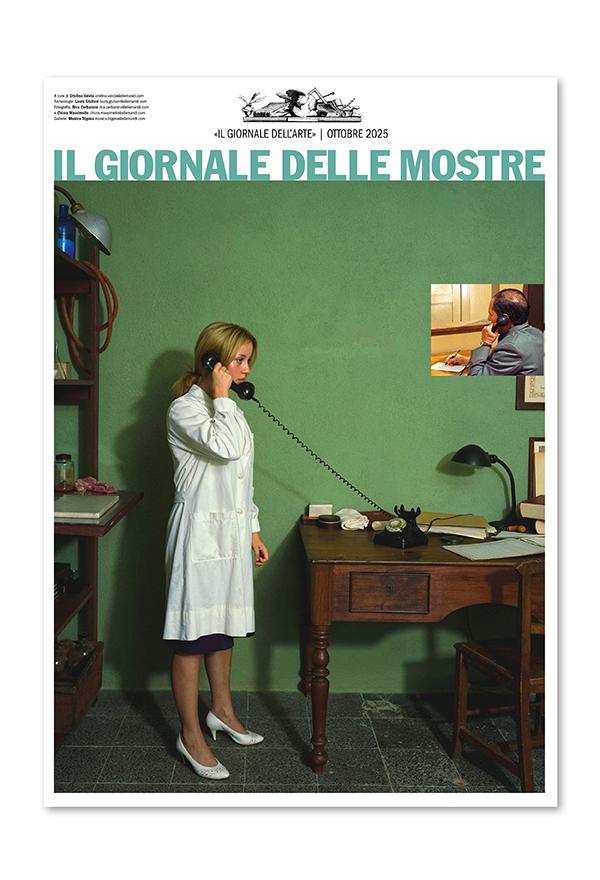Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Elena Franzoia
Leggi i suoi articoliIn occasione dei 45 anni di gemellaggio tra la città scozzese di Dundee e quella palestinese di Nablus, con la mostra «Thread Memory: ricami dalla Palestina» (fino al 5 aprile 2026) il Victoria and Albert Museum di Dundee esplora il mondo del tatreez, antica pratica di ricamo elaborata da ogni comunità palestinese con uno stile distinto e riconoscibile, tanto da renderlo una importante forma di comunicazione che riflette non solo la condizione femminile, ma anche il cambiamento politico ed economico della società palestinese dalla fine dell’800 ad oggi. Non a caso il tatreez è stato riconosciuto dall’Unesco Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità. Resa possibile dalla collaborazione tra Museo Palestinese di Birzeit, in Cisgiordania, Art Jameel di Gedda, V&A South Kensington e V&A Dundee, la mostra è curata da Rachel Dedman (ex curatrice del Museo Palestinese e tra le principali studiose internazionali del tatreez) che ha accostato a 30 abiti, copricapi, gioielli e accessori, sia tradizionali sia realizzati da stilisti palestinesi contemporanei, 100 immagini fotografiche d’archivio. Dedman ha lavorato insieme a Kirsty Hassard e Miriam Mallalieu, ampliando una mostra dallo stesso titolo tenutasi negli scorsi mesi all’Hayy Jameel di Gedda, in Arabia Saudita.
Dottoressa Dedman, che cos’è esattamente il tatreez e che significato ha l’abito, soprattutto quello femminile, nella cultura e nella società palestinesi?
Il tatreez è un’arte femminile rurale, radicata nella vita del villaggio. Tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, l’abbigliamento in Palestina era notevolmente vario. Ogni villaggio aveva il suo stile, ma il tatreez è noto soprattutto nella sua forma più spettacolare e cioè attraverso gli abiti festivi che le donne realizzavano per i loro matrimoni. Le bambine imparavano a ricamare fin da piccole secondo lo stile peculiare del villaggio. L’ispirazione proveniva dalla vita quotidiana: piante, animali, architettura ed eventi politici. Sebbene il punto croce sia il più comune, le donne utilizzavano una miriade di diverse tecniche decorative. Dalla Nakba (esodo) del 1948, il tatreez si è evoluto in simbolo della nazionalità palestinese e nella forma più importante di patrimonio culturale. Durante la Prima Intifada (1987-93) ha inoltre svolto un ruolo visibile nella resistenza all’occupazione, attraverso la creazione di abiti indossati durante le proteste. La mostra ripercorre la politicizzazione del ricamo e la sua trasformazione in emblema identitario. Raramente indossato quotidianamente, il tatreez è infatti oggi considerato una pratica di solidarietà. Per molte persone in tutto il mondo, imparare, realizzare e indossare il tatreez sono gesti che creano un legame con la Palestina, soprattutto in periodi di orribile violenza. I cerchi di tatreez, dove le persone cuciono insieme, in presenza oppure online, riecheggiano il modo in cui le donne palestinesi ricamavano intorno ai pozzi dei loro villaggi un secolo fa. Gli artisti-stilisti contemporanei si avvalgono del ricamo come potente mezzo narrativo, allo scopo di testimoniare la storia e gli effetti dell’esodo, con una forte componente critica.
Com’è nato il gemellaggio tra Dundee e Nablus?
Nel 1980, il gemellaggio di Dundee con una città palestinese fu considerato da molti un atto radicale, il primo caso del Regno Unito. Da allora la bandiera palestinese è stata esposta al Municipio di Dundee anche quando era vietata nella stessa Palestina. L’idea nacque in seguito a una visita di Bassam Shaka’a, sindaco di Nablus dal 1976 al 1982. Nel 1980, Shaka’a sopravvisse a un attentato con autobomba da parte della resistenza ebraica in cui perse entrambe le gambe e venne nel Regno Unito per farsi curare. In quel periodo fu invitato dal Consiglio comunale di Dundee e nacque l’idea di un gemellaggio. La mostra però punta i riflettori anche su Gaza, presentando spettacolari abiti storici provenienti da villaggi della regione, in omaggio alla creatività e resilienza del popolo palestinese in un momento di devastazione culturale e dolore incommensurabile.
Quali sono le nuove opere e quelle più significative presentate in mostra?
La mostra include le artiste contemporanee Leena Nammari, laureata al Duncan of Jordanstone College of Art and Design dell’Università di Dundee, che ha creato 626 tavolette d’argilla, ciascuna delle quali rappresenta una città o un villaggio palestinese distrutto, e Aya Haidar, la cui serie «Kiass» è composta da sacchetti di plastica su cui sono ricamati oggetti portati in Scozia dalle donne siriane durante la fuga dalle loro case. La mostra include anche gli stilisti Zeid Hijazi, che fonde tartan e tatreez, Ayham Hassan Musleh, che lavora sul significato simbolico del colore magenta per la cultura palestinese, Faissal El-Malak e Hazar Jawabra. Tra le opere tradizionali più significative segnalo l’abito blu da vedova (Bir al-Saba’, 1960-70) della Collezione del Museo Palestinese. Il blu è il colore del lutto in Palestina. In particolare nella cultura beduina, le donne in lutto usavano prevalentemente filo blu per i loro ricami, come si può vedere sulla gonna di questo abito. Il dolore lasciava il segno sugli abiti anche in altri modi: alcune donne si strappavano le fasce sul petto in preda alla disperazione, altre tingevano i loro vivaci ricami con l’indaco, e il periodo di lutto si considerava concluso quando la tinta sbiadiva e il filo colorato riappariva. Di grande interesse sono anche l’abito proveniente dal villaggio distrutto di Beit Nabala (1920-30 ca), precedente alla Nakba del 1948, e quello della Prima Intifada (1987-93), rivolta palestinese contro l’occupazione israeliana della Cisgiordania e di Gaza. Le bandiere palestinesi furono confiscate durante le proteste e i colori palestinesi vietati in pubblico. In risposta, le donne iniziarono a cucire «abiti dell’Intifada», che combinavano motivi tradizionali palestinesi nei colori nazionali con nuovi disegni associati alla nazionalità e alla resistenza. Questo abito in particolare raffigura uccelli che cantano sopra la sacra Cupola della Roccia a Gerusalemme. I corpi delle donne divennero quindi strumenti di politica attiva realizzati nei villaggi sotto assedio. La lenta lavorazione del tatreez, che richiede molti mesi, riflette anche la tenacia delle donne palestinesi e l’idea che la resistenza sia un processo, non un singolo evento. Una toccante testimonianza è poi rappresentata dall’abito (2000-10) proveniente dal Museo di Rafah a Gaza. Realizzato per una bambina, è stato danneggiato durante il bombardamento mirato del Museo di Rafah, in gran parte distrutte da Israele nel 2023. L’esplosione l’aveva scaraventato su un tetto, dov’è rimasto inaccessibile per 8 mesi. Un abito che reca i segni non solo della violenza del bombardamento, ma anche dell’esposizione agli agenti atmosferici.
Quali caratteristiche hanno gli abiti realizzati a Gaza?
Si riconoscono per i ricami geometrici e grafici dalla vivace palette, rosa e rosso. «Thread Memory» include abiti provenienti dalla più ampia regione di Gaza, sia all’interno sia all’esterno della Striscia: Asdud, Deir Al-Balah e Khan Younis. I thobe (abiti tradizionali) dell’area di Gaza sono notevoli per la luminosità dei ricami. Molti presentano un tessuto a righe realizzato localmente nell’importante centro tessile di Mejdel, sebbene le donne di Herbia utilizzassero insolite combinazioni di seta siriana, pizzo europeo e uncinetto. Gli abiti di Gaza inoltre spesso presentano una collana ricamata al posto dei gioielli, con valore talismanico di protezione.

Particolare di un abito proveniente da Ramallah, 1930-40