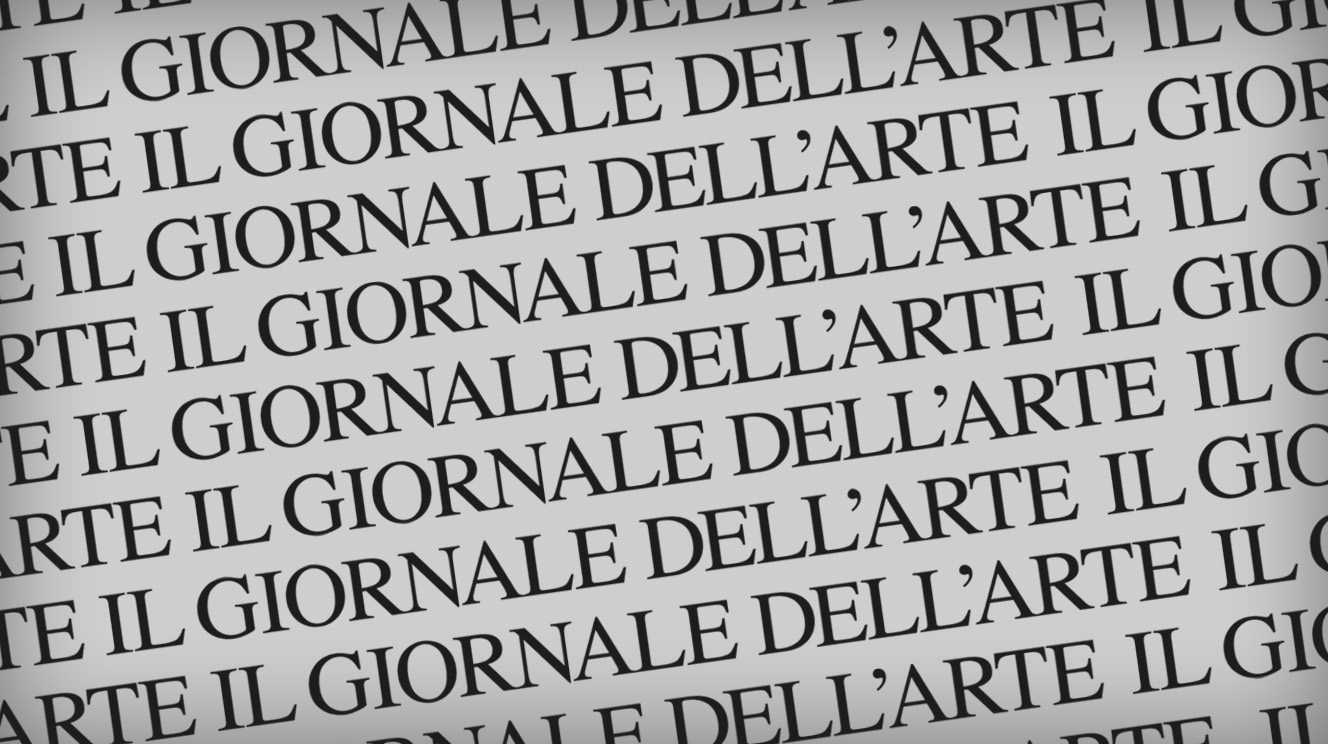Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Federico Florian
Leggi i suoi articoliSe i padiglioni ai Giardini e all’Arsenale, in questa Biennale, sono contenitori di progetti talora deludenti, diversi tra quelli sparsi in città, al contrario, ospitano mostre incisive e cariche di significato. Primo fra tutti il Padiglione della Repubblica di Armenia, Leone d’Oro per la miglior partecipazione nazionale, collocato in una sede straordinariamente suggestiva, il Monastero Mechitarista dell’Isola di San Lazzaro, dove Lord Byron soggiornò per studiare la lingua dei monaci che vi risiedevano. «Armenity», a cura di Adelina von Fürstenberg, raccoglie i lavori di 16 artisti di diverse nazionalità ma tutti accomunati da origini armene. Nipoti dei superstiti al Genocidio del 1915, gli artisti in mostra riflettono sul concetto di diaspora e dislocamento, sul rapporto tra memoria e identità. Da non perdere il Rotolo di Yervant Gianikian & Angela Ricci Lucchi, un acquarello lungo 17 metri che raffigura una serie di fiabe armene raccontate ai due artisti da Gianikian padre. L’Islanda, per il proprio Padiglione, ha invitato l’artista svizzero Christoph Büchel, noto per le sue taglienti provocazioni (nel 2010 trasformò gli spazi di Secession a Vienna in uno strip club), a realizzare un progetto site specific per Venezia. L’artista ha così tramutato il gioiello gotico di Santa Maria della Misericordia a Cannaregio (chiusa da oltre 40 anni) in una moschea temporanea, la prima nel centro storico di Venezia. Il fatto che la comunità islamica di Venezia utilizzi il padiglione come luogo di culto ha scatenato prevedibili polemiche. Per restare in ambito islamico, l’Iraq, nel suo Padiglione a Ca’ Dandolo, presenta una collettiva di artisti iracheni («Invisible Beauty») a cura di Philippe van Cauteren, direttore artistico dello Smak di Gand. Fotografie, video, acquerelli e disegni occupano le stanze del palazzo veneziano, tutte testimonianze di un Paese sconvolto da guerre, conflitti e ripetute oppressioni, l’ultima delle quali perpetrata dagli integralisti dell’Isis. Tra le opere in mostra i bei disegni di Salam Atta Sabri, disperato diario intimo della vita dell’autore a Baghdad. Notevoli i padiglioni di due Paesi baltici, Estonia e Lituania. Il primo ospita una coinvolgente installazione di Jaanus Samma ispirata alla vita di Juhan Ojaste detto il «Chairman», ex dirigente di un collettivo sovietico estone successivamente espulso dal Partito Comunista e condannato per omosessualità. I video nelle stanze di Palazzo Malipiero rievocano episodi della vita di Ojaste; immersi in un’atmosfera teatrale e decadente, i lavori innescano una toccante riflessione sul passato sovietico dell’Europa dell’Est e sulle discriminazioni a danno degli omosessuali. La memoria del regime sovietico è al centro del Padiglione della Lituania a Palazzo Zenobio. «Museum» è una piccola camera delle meraviglie ideata dall’artista lituano Dainius Likevicius: oggetti dal recente passato comunista (etichette di bevande prodotte in epoca socialista, modellini di edifici sovietici e pubblicazioni del periodo) sono accostati a opere dell’artista per dare forma a un (apparentemente) disordinato bric-à-brac. Likevicius s’interroga sul rapporto tra libertà artistica e regimi totalitari; fa da sfondo la figura di Jean-Paul Sartre, protagonista della videoproiezione «Free Time», mentre cammina sulle spiagge del Mar Baltico, durante la sua visita in Lituania nel ’69: simbolo di libertà in un’epoca di totalitarismo. «I’ll be your mirror», il progetto di João Louro per il Padiglione del Portogallo a Palazzo Loredan, esplora il ruolo dello spettatore nella creazione dell’opera d’arte. Scritte al neon, scale specchianti e copertine di libri oversized invadono gli spazi dell’Istituto Veneto; in mostra anche le «Blind Images» dell’artista portoghese (monocromi neri accompagnati da una didascalia descrittiva): vere e proprie indagini postminimaliste sui limiti espressivi e rappresentativi delle immagini. Sulla scia del concettualismo che pervade il Padiglione portoghese, i lavori di Christodoulos Panayiotou, esposti a Palazzo Malipiero nel Padiglione cipriota, rivelano un’estetica scarna e rigorosa. Interrogandosi sul significato di archeologia e sulla nozione di riappropriazione, l’artista dà forma a opere d’arte effimere, tra cui mosaici realizzati con antiche tessere prese in prestito dal Museo Archeologico di Nicosia e sculture-ready made create a partire dai materiali di scarto degli scavi archeologici. Se il vicino Padiglione del Montenegro, collocato al piano terra del medesimo edificio, ospita lavori di stampo socio-politico (all’ingresso, una delle opere dell’artista montenegrino Aleksandar Duravcevic recita: «Gli albanesi credevano fossi montenegrino, i montenegrini che fossi albanese, gli italiani che fossi uno slavo [...]»), quello della Nuova Zelanda (dislocato negli spazi della Biblioteca Marciana e dell’Aeroporto Marco Polo) travalica ogni riflessione sull’identità nazionale per abbracciare un approccio globale e transcontinentale. Qui Simon Denny realizza una complessa installazione fatta di server rack, vetrine contenenti elementi grafici e scultorei e oggetti disparati. Il tutto ispirato all’impatto generato dalla fuga di notizie da parte di Edward Snowden, ex collaboratore informatico della Nsa: una caotica e pittoresca messa in scena dell’iconografia del potere geopolitico. Il disordine giunge alla sua più completa «definizione» nel Padiglione del Lussemburgo a Ca’ del Duca: qui l’immersiva installazione pop di Filip Markiewicz offre un ritratto eccentrico e irriverente del granducato europeo. Dopo aver superato un karaoke, una stanza colma di banconote con la scritta «Sorry» (allusione ai paradisi fiscali?) e una mini discoteca, il visitatore s’imbatte in un neon che riporta una (più che mai attuale) citazione di Oscar Wilde: «Il mondo è come un palcoscenico ma le parti sono mal distribuite».
Altri articoli dell'autore
In occasione del centenario della nascita del maestro cinetico più celebre al mondo, anche un convegno internazionale, oltre a mostre in tutta Europa
La prima edizione della Triennale di arte contemporanea della città francese è un prototipo per una rassegna alternativa: attenta a una dimensione locale più che globale, nasce dal desiderio di relazionarsi attivamente e genuinamente con il tessuto urbano e la comunità dei cittadini
All’Eye Museum di Amsterdam la personale della raffinata artista e filmmaker greca
La sua prima retrospettiva istituzionale negli Stati Uniti, al MoCA di Los Angeles, è una profonda riflessione del rapporto tra verità, spettacolo e rappresentazione