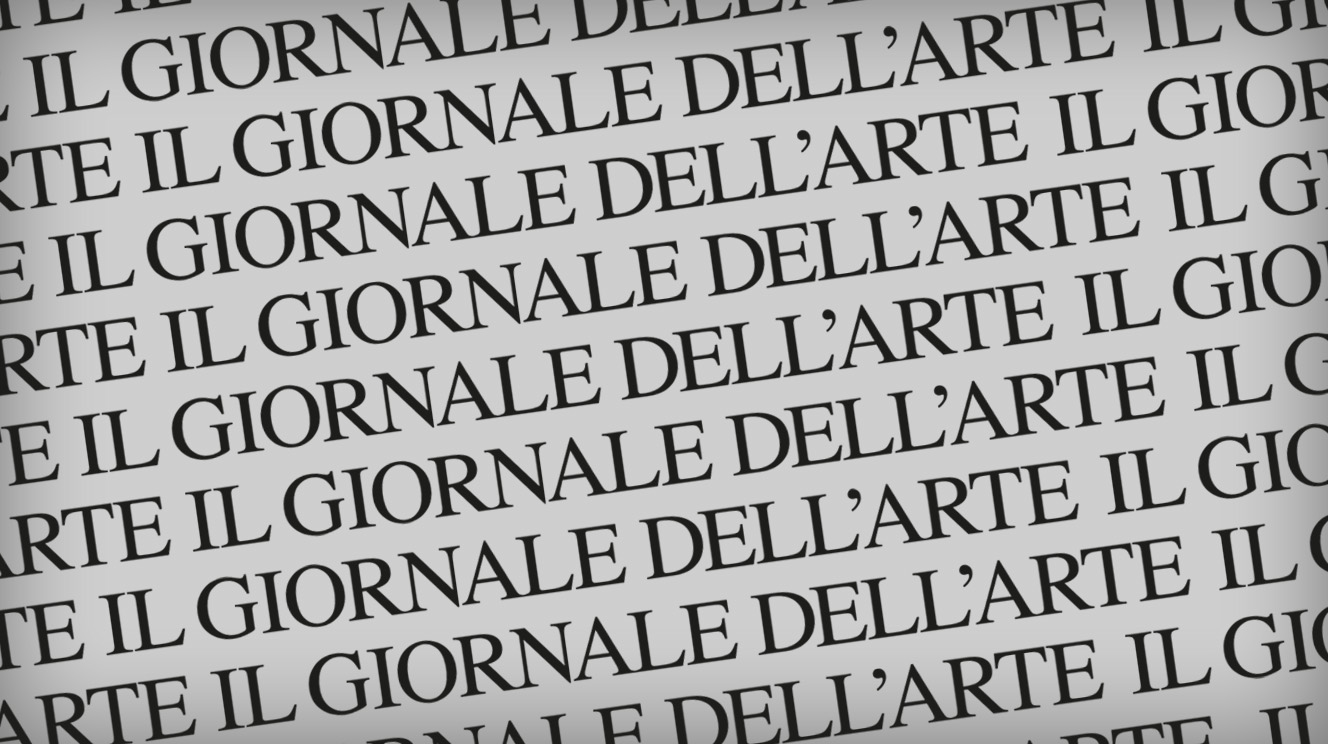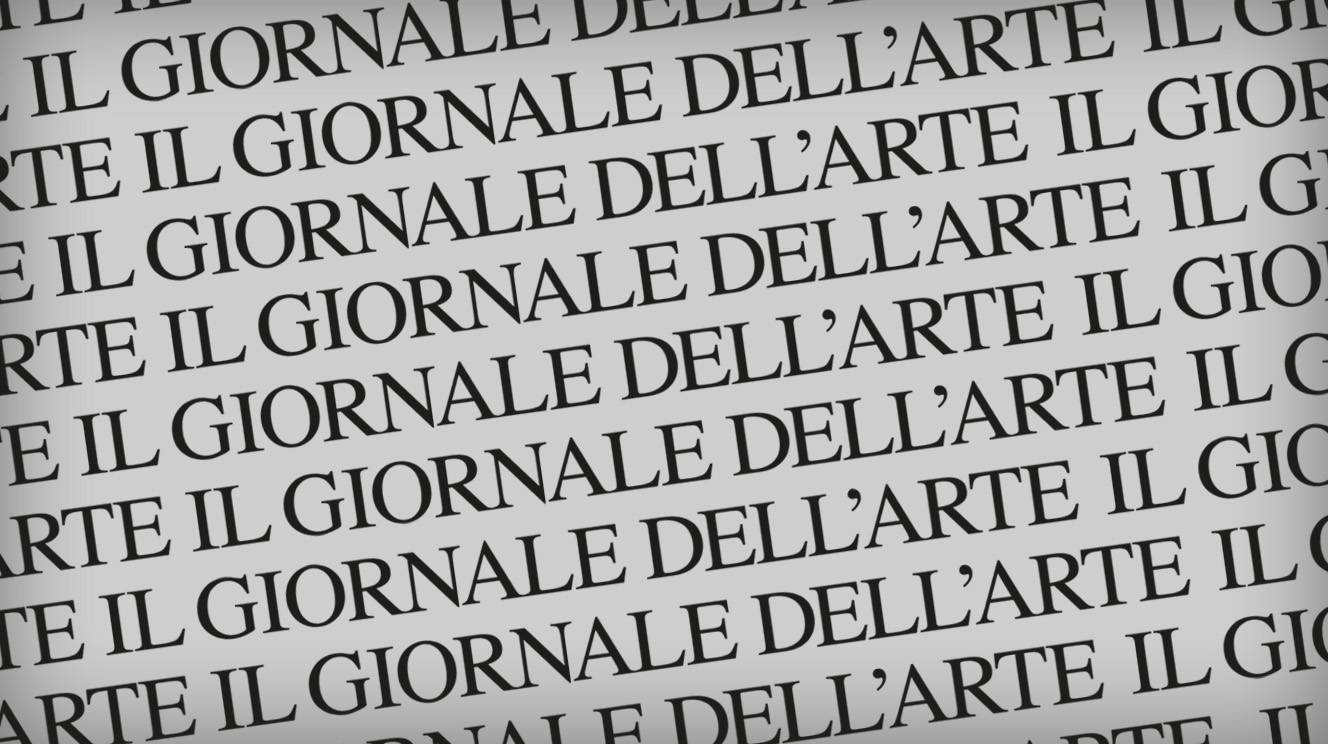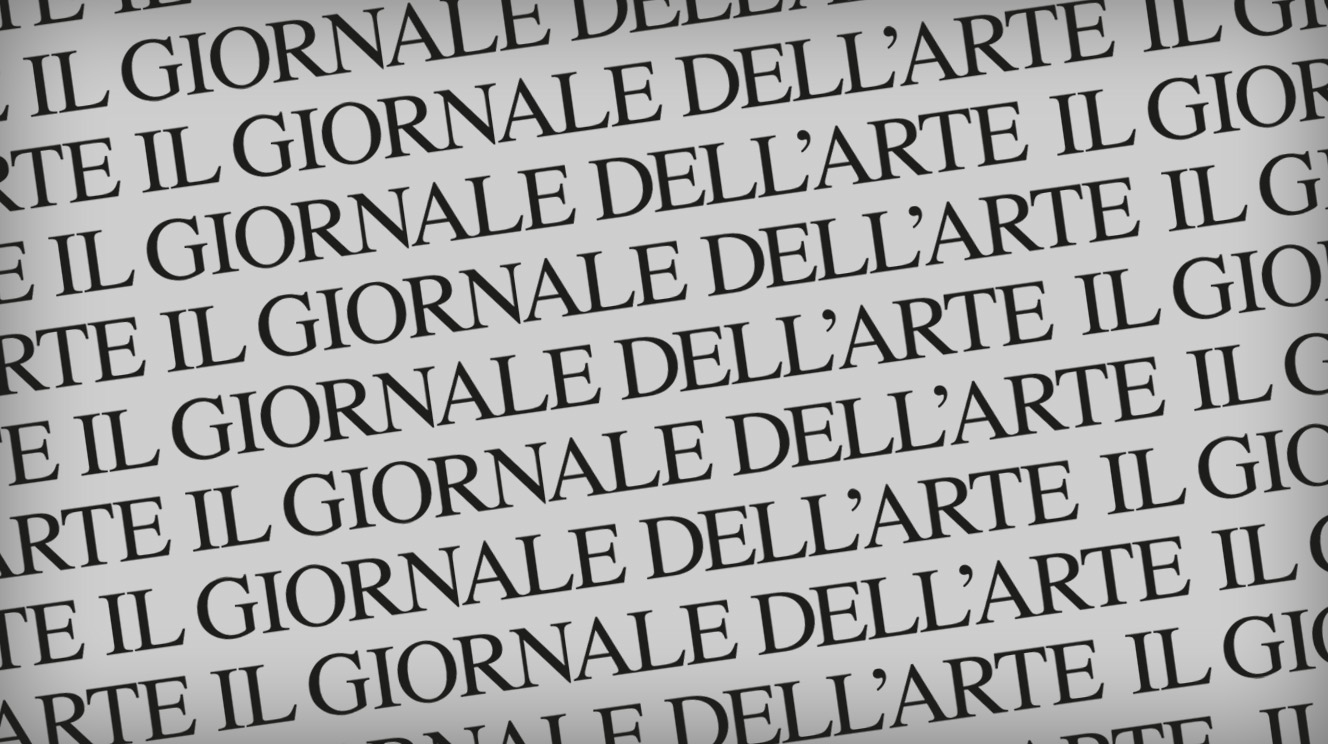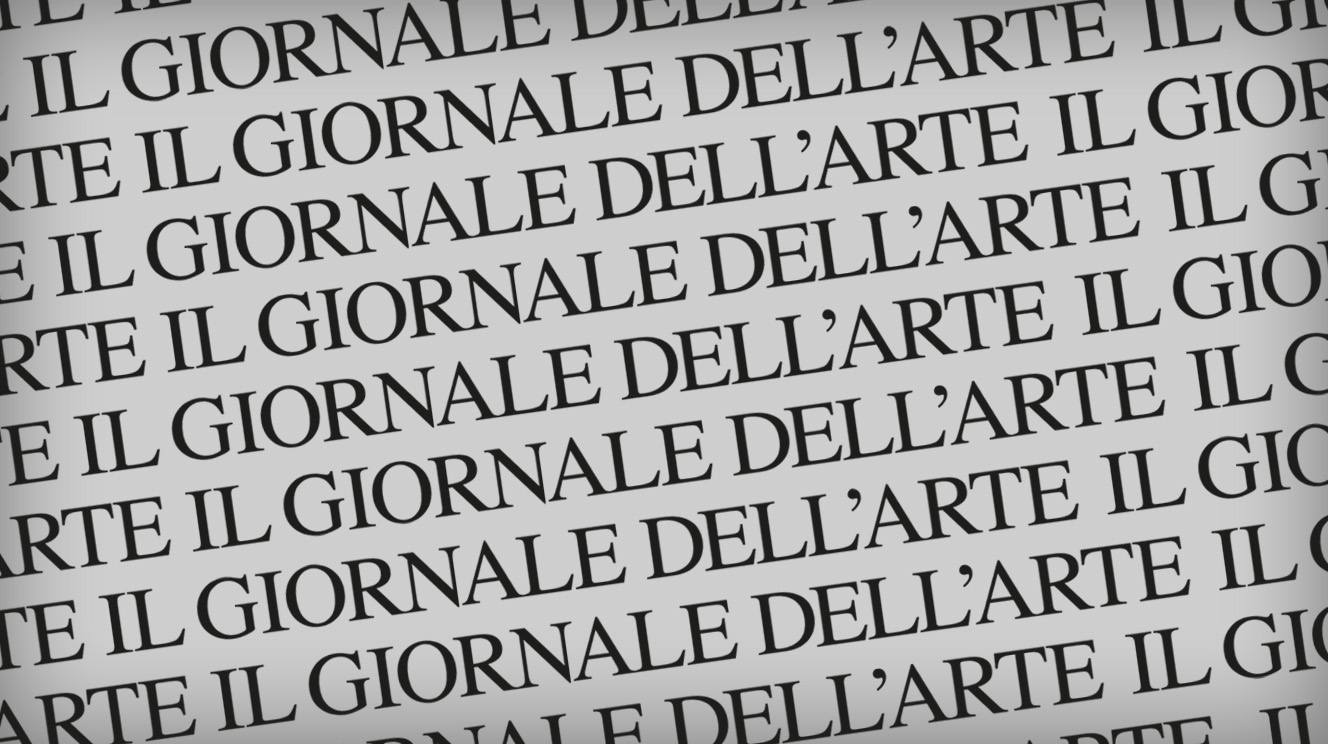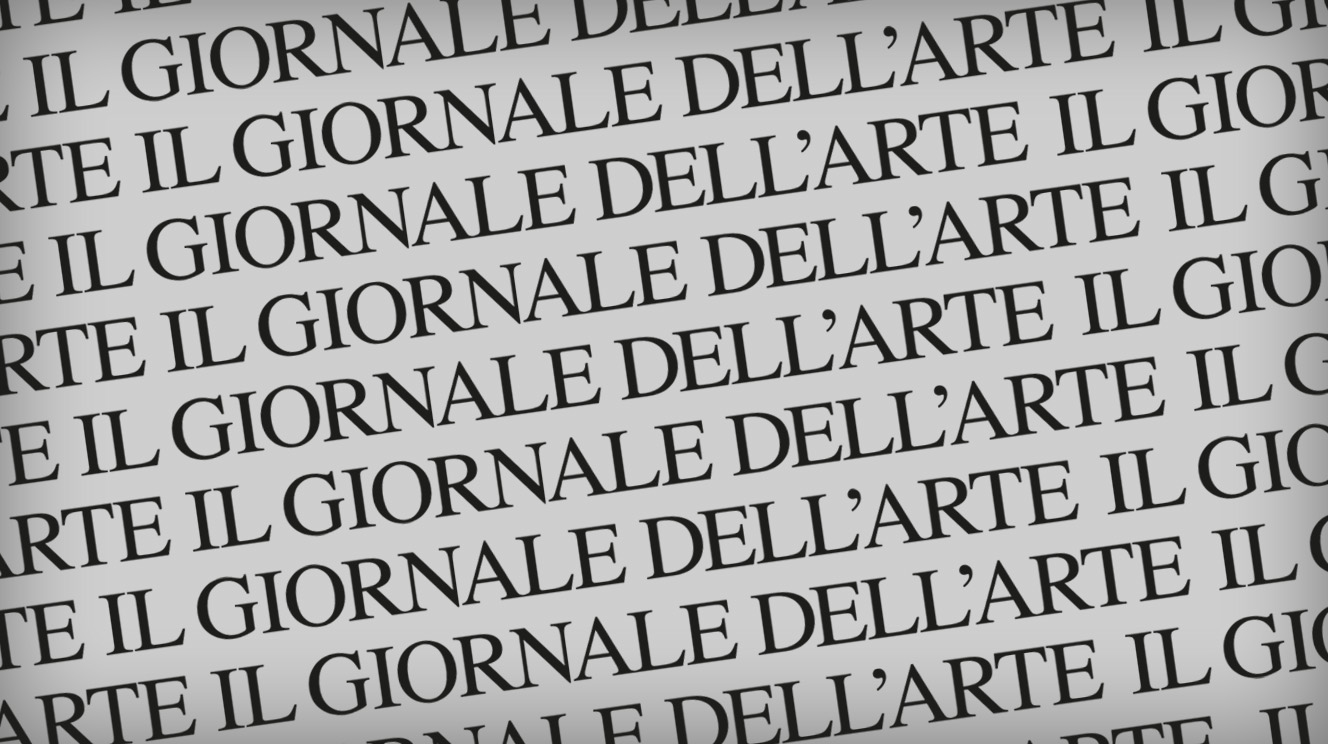Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Michele Dantini
Leggi i suoi articoliPubblicato oggi a distanza di circa trent’anni dalla versione originale inglese, L’antiestetica a cura di Hal Foster spinge il lettore da un lato a comprendere specificità e differenza dei singoli saggi, dall’altro a considerare retrospettivamente come la scena artistica e culturale si sia nel frattempo modificata. Alla data in cui appare, nel 1983, il volume si propone di riflettere sulla cesura che corre tra i ’50 e i ’60 e che improvvisamente sembra congedare il mito modernista: niente più utopie emancipazionistiche di origine illuminista, dunque, niente più filosofie della storia (o storie dell’arte) orientate a un inevitabile progresso. Invece, aleatorietà (la musica di Cage è tra i riferimenti principali del testo, con i combine painting e le serigrafie di Rauschenberg), ironia, rifiuto dell’ufficialità, a tratti vincolo di complicità e appartenenza (è il caso delle artiste femministe). Hal Foster, curatore della raccolta, cerca di presentare in modo organico pratiche sperimentali assai diverse e di ricondurle a un progetto critico unitario, postmoderno appunto, in cui coabitino connoisseurship, termine che peraltro non usa, e critica sociale. «Antiestetica», ai suoi occhi, non equivale affatto a una sorta di estetica del brutto o del deforme, ma alla nozione foucaultiana di «archeologia». Accade, a suo parere, che l’arte minimalista e postminimalista abbia attitudini archeologiche: indaghi cioè i presupposti dell’estetica e della storia dell’arte (il monumento, il pubblico, la fama, l’autonomia dell’opera) nel desiderio di invalidarli o quantomeno eroderne l’indiscussa autorevolezza. Sono due neomarxisti eterodossi, Fredric Jameson ed Edward W. Said, a contribuire maggiormente alla chiarezza di una proposta teorico-culturale «controegemonica» che si richiama esplicitamente a Gramsci e a suggerire i modi sottili attraverso cui filologia e politica si congiungono. I critici d’arte finiscono invece per trovarsi in maggiore difficoltà e apparire oscuri sino alla pedanteria. Il pensiero post-strutturalista francese diviene scolastica e la tradizione dell’illuminismo, ridotta alla povera astrazione contro cui si era scagliato già Max Horkheimer nel celebre testo del 1947, non è indagata con sufficiente perspicuità e completezza. La connessione tra critica d’arte e critica culturale resta (allora come oggi) esigenziale, nel senso che la storicità delle immagini e la loro «semplice» relazione al contesto storico-culturale è asserita ma non dimostrata. Infine, la polemica di Rosalind Krauss contro la «rabbia storicista» ha presupposti dogmatici, fondata sulla dubitabile ipotesi di una «logica interna» degli ambiti disciplinari o «campi», la pretesa iperrazionalistica di sganciare la storia dell’arte dalla storia delle forme postula cesure e discontinuità assolute.
L’antiestetica. Saggi sulla cultura postmoderna, a cura di Hal Foster, 192 pp., ill., postmediabooks, Milano 2014, € 19,00