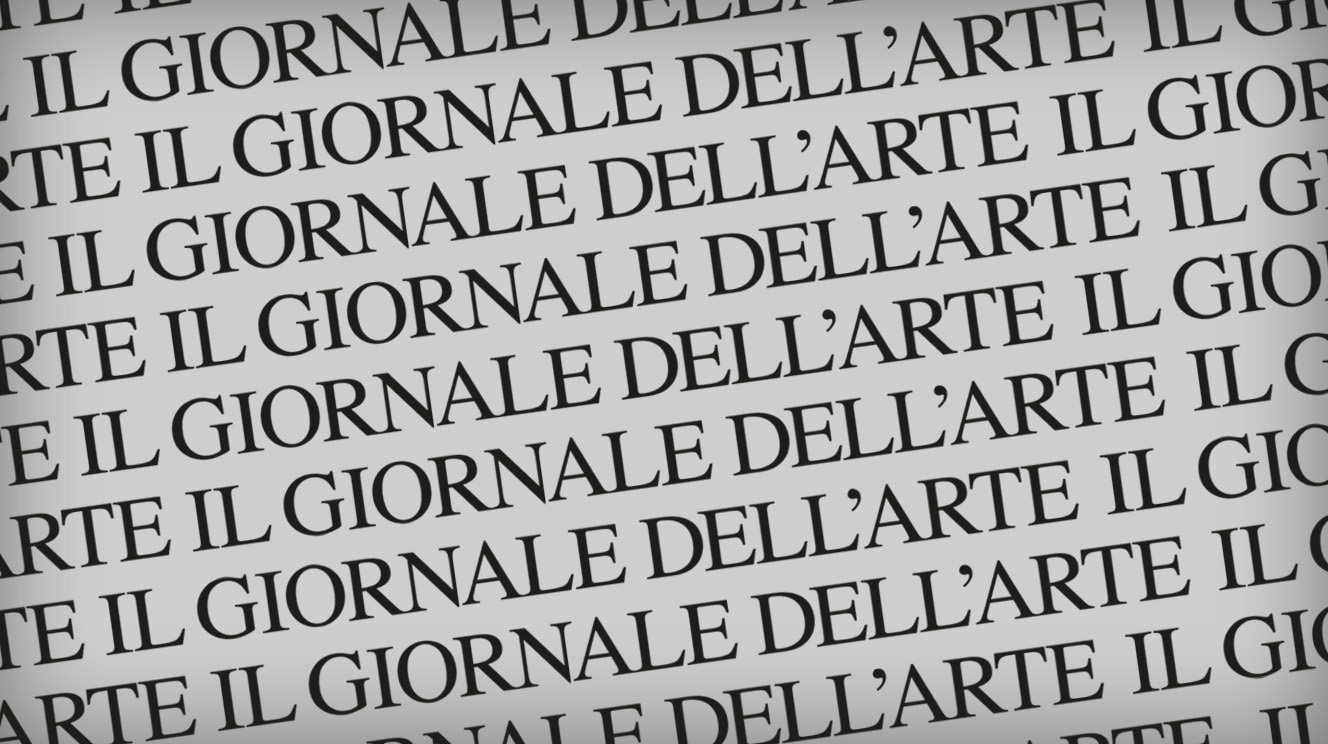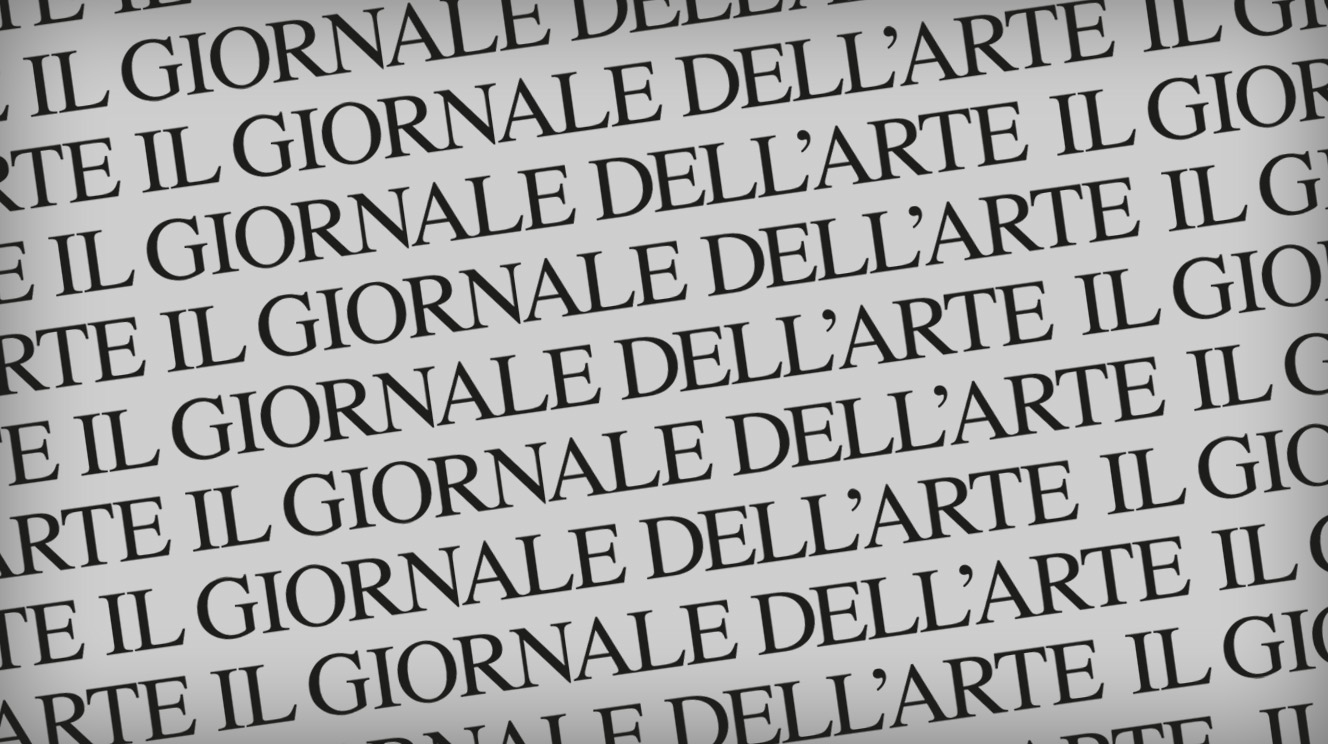Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Laura Sudiro
Leggi i suoi articoliLo strazio dei beni artistici dalla presa di Babilonia ad oggi
Scritto «cum ira et studium» (ed entrambi i sentimenti, il rancore indignato e il coinvolgimento emotivo, sono ben percepibili fra le righe) nei tempi in cui si consuma l’apocalisse dell’eredità culturale dell’Iraq e della Siria, l’ultimo lavoro dell’archeologo Paolo Matthiae, professore emerito della Sapienza e accademico, nonché illustre scopritore di Ebla, è la dissertazione colta e appassionata su un tema «sterminato» perché nient’affatto nuovo e divenuto purtroppo straordinariamente attuale: lo strazio dei beni artistici, mobili e immobili, che da sempre caratterizza i conflitti armati. Così, pagina dopo pagina, Matthiae prende per mano il lettore e lo conduce attraverso le infinite stanze del monumentale palazzo della Storia, che è soprattutto narrazione di guerre e conquiste, di devastazioni e saccheggi, a seguito dei quali a soccombere non sono soltanto i regni, gli imperi, le nazioni, ma il patrimonio culturale dei popoli e, insieme, la loro stessa identità.Ed ecco apparire, come in una successione di vividi affreschi, il tracollo delle grandi città del mondo antico, la presa di Babilonia (689 a.C.), la distruzione di Ninive (612 a.C.), di Gerusalemme (586 a.C.) e quella di Persepoli decisa da Alessandro Magno. E poi il rogo di Baghdad nel 1258 per mano dell’esercito mongolo di Hulagu, nipote di Gengis Khan, l’annientamento di Delhi nel 1398 sempre da parte dei Mongoli, questa volta guidati da Tamerlano, fino ad arrivare ai bombardamenti della seconda guerra mondiale, a Dresda che brucia sotto una tempesta di fuoco nella notte fra il 13 e il 14 gennaio del 1945.
Devastazioni puntualmente accompagnate da razzie, spoliazioni, furti. Pratiche usuali, che nell’antichità assurgevano addirittura al rango di diritto, lo ius praedae. Di cui i Romani furono maestri ma con allievi eccellenti nelle epoche successive: basti pensare al saccheggio di Costantinopoli dell’aprile del 1204, a opera dell’armata della IV Crociata, che costò alla città una perdita immane di opere artistiche, comparabile forse soltanto ai tre sacchi subiti dalla stessa Roma durante le invasioni barbariche del V secolo e, volgendo lo sguardo al Nuovo Mondo, al saccheggio dei tesori delle civiltà preincaiche, alle depredazioni sistematiche e organizzate, a partire dall’inizio del Novecento, del sito peruviano di Batán Grande, alle recenti ruberie perpetrate ai danni di aree archeologiche antichissime del Vicino Oriente, nei Paesi dilaniati da crisi interne tuttora irrisolte.
Appare evidente come non sia soltanto il logorio del tempo il nemico giurato dei beni culturali. I danni maggiori portano la firma dell’uomo, sono figli di una furia distruttrice non sempre fine a se stessa ma che spesso è sciagurata germinazione di un odio ideologico «spietato, intransigente e totalitario».
 Matthiae non fornisce soltanto un elenco di esempi di nefandezze. L’intento del libro è dichiarato fin dalle prime battute: di fronte alla pulizia culturale messa in atto dall’Isis/Daish, «nuovissima barbarie», esso si propone come un mezzo per sollecitare «valutazioni, considerazioni, giudizi non certo solo di studiosi ma dell’opinione pubblica internazionale perché l’indignazione e la condanna di questa ingiustificata e ingiustificabile infamia siano di tutta la comunità mondiale». E non manca un fermo appello all’Unesco cui si chiede di porsi «con la massima urgenza, da un lato, il problema di un adeguamento della normativa sul piano del diritto internazionale nei casi di conflitti interni e di guerre civili in materia di tutela del patrimonio e, dall’altro, il tema degli interventi concreti d’emergenza, anche con la presenza di forze militari di pace, quando si determinino casi catastrofici di dilapidazione del patrimonio archeologico».
Matthiae non fornisce soltanto un elenco di esempi di nefandezze. L’intento del libro è dichiarato fin dalle prime battute: di fronte alla pulizia culturale messa in atto dall’Isis/Daish, «nuovissima barbarie», esso si propone come un mezzo per sollecitare «valutazioni, considerazioni, giudizi non certo solo di studiosi ma dell’opinione pubblica internazionale perché l’indignazione e la condanna di questa ingiustificata e ingiustificabile infamia siano di tutta la comunità mondiale». E non manca un fermo appello all’Unesco cui si chiede di porsi «con la massima urgenza, da un lato, il problema di un adeguamento della normativa sul piano del diritto internazionale nei casi di conflitti interni e di guerre civili in materia di tutela del patrimonio e, dall’altro, il tema degli interventi concreti d’emergenza, anche con la presenza di forze militari di pace, quando si determinino casi catastrofici di dilapidazione del patrimonio archeologico». Distruzioni saccheggi e rinascite. Gli attacchi al patrimonio artistico dall’antichità all’Isis
di Paolo Matthiae
264 pp., 50 ill.
Mondadori Electa, Milano 2015
€ 24,90
Altri articoli dell'autore
Il volume del celebre falsario vede finalmente la luce a trent’anni dalla sua morte, grazie a un meticoloso lavoro di interpretazione e ricostruzione
Tombe paleocristiane affiorano nel centro storico del borgo laziale ferito dal terremoto