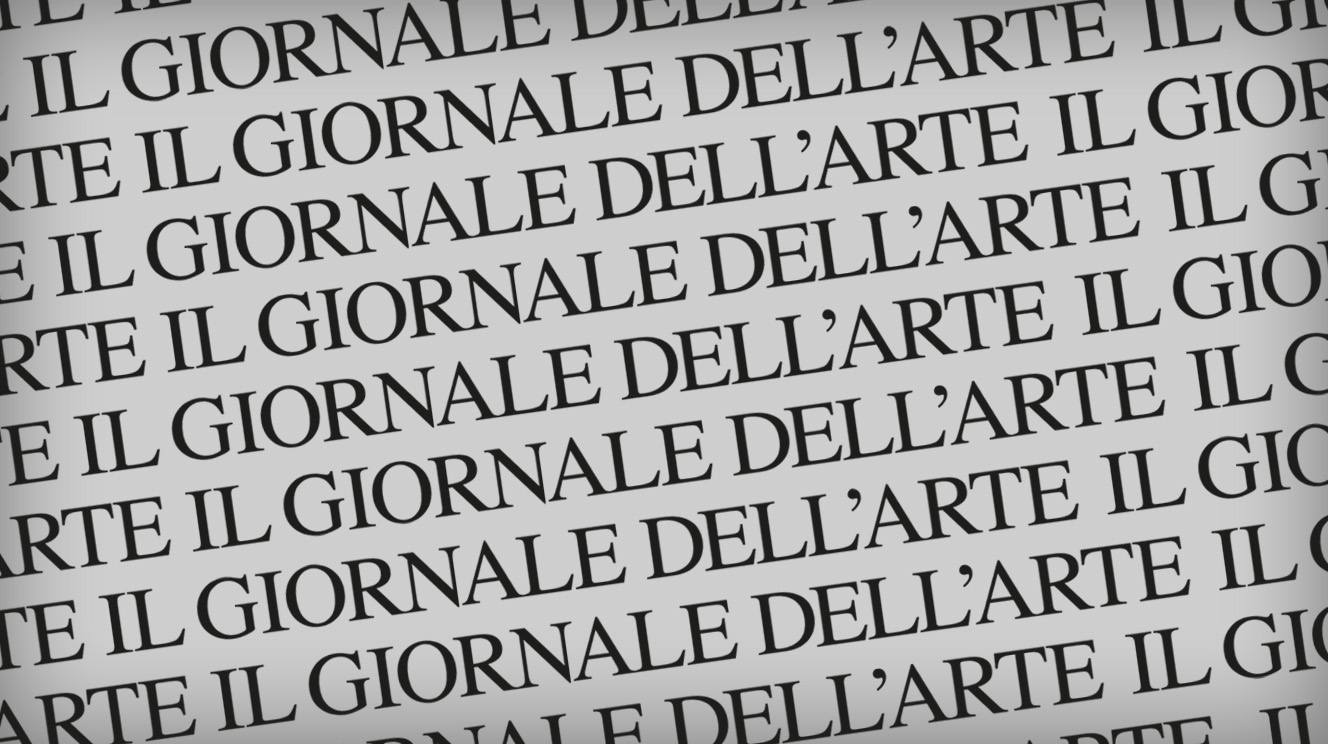Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Sandro Parmiggiani
Leggi i suoi articoliTragica, e ormai nota, è la vita di Charlotte Salomon, artista ebrea di grande talento, nata a Berlino il 16 aprile 1917 e morta ad Auschwitz il 10 ottobre 1943. Il Jewish Historical Museum di Amsterdam custodisce l’opera che Charlotte realizzò in meno di due anni, tra il 1940 e il 1942: circa 800 gouache, oltre 500 disegni preparatori e opere collaterali, cui lei stessa diede il titolo di Vita? O Teatro?, nelle quali ricostruì le vicende familiari, segnate dalle persecuzione nazista e da acute sofferenze, con la catena di suicidi dipanatisi tra le donne della sua famiglia. L’opera di Charlotte è un racconto autobiografico in forma di quella che oggi potremmo definire graphic novel, esito della fusione di pittura, scrittura, fumetto, cinema, teatro, compreso un accompagnamento musicale: un’opera totale, la memoria e l’eredità di sé che lei vuole lasciare (affidata in una valigia all’amica americana Ottilie Moore con queste parole: «È tutta la mia vita»), quasi presagisca, negli anni e nei luoghi in cui la realizza, il respiro brevissimo che la vita ancora le lascia. Bruno Pedretti scrive questa sorta di romanzo-verità nell’estate del 1993, qualche mese dopo la folgorazione suscitata in lui dalla mostra di «Vita? O Teatro?» vista a Parigi, e negli stessi luoghi del sud della Francia dove Charlotte, profuga, aveva vissuto e dove una delazione l’aveva consegnata ai carnefici nazisti. Il romanzo ricostruisce, scavando nell’interiorità e nell’immaginario segreto di Charlotte, la sua vicenda umana, ancorandola alle stesse immagini dell’opera dell’artista, riprodotte nei dieci capitoli del libro. Apre la narrazione il suicidio della zia diciottenne di Charlotte, che portava Il suo stesso nome, cui fanno seguito i brevi anni felici con i genitori, la morte della madre, la vita che lentamente riprende, le scoperte nei musei durante le visite con il nonno materno, la breve esperienza nell’Accademia di Belle Arti di Berlino (frequentata nel 1935, dalla quale fu presto espulsa, mentre al padre, virologo, è interdetta la professione e viene internato in un campo), le montanti persecuzioni antiebraiche, l’incontro con Amadeus, consapevole del «suicidio collettivo» e dalla rovina che incombono, lo scoppio della guerra, la vita da profuga nella Francia meridionale, con il suicidio della nonna e il nuovo amore per Alexander, il padre della sua creatura mai nata, dissoltasi con lei ad Auschwitz. Infine, la scelta di raccontare per immagini «la propria intera parabola biografica», immergendosi nel fervore della creazione artistica (un inscindibile, circolare cortocircuito tra vita e opera), consapevole del poco tempo che ancora le resta e dell’orrore che presto l’annienterà. Pedretti ci rivela i sentimenti segreti di Charlotte, e le verità che la sua esistenza ci dischiude: «Si può prevedere la musica, presagire la storia? Della prima impariamo a conoscere lo sviluppo quando il motivo è dato; della seconda comprendiamo il fine solo una volta concluso».
Charlotte. La morte e la fanciulla, di Bruno Pedretti, 154 pp., Skira, Milano 2015, € 15,00
Altri articoli dell'autore
Fondato da Ennio Lodi nel 1960, lo spazio espositivo nel centro storico di Parma prosegue la propria attività rilevata dalla figlia Patrizia. A settembre una nuova collettiva
Mostre, pubblicazioni, festival e percorsi nel dedalo di bambù più grande del mondo
Nel volume illustrato edito da FMR si raccontano pittori, musicisti e architetti nella città che, con Brescia, sarà Capitale Italiana della Cultura nel 2023
Dal Medioevo passando per il deserto e arrivando a Borges, una mostra ispirata da Umberto Eco e Franco Maria Ricci