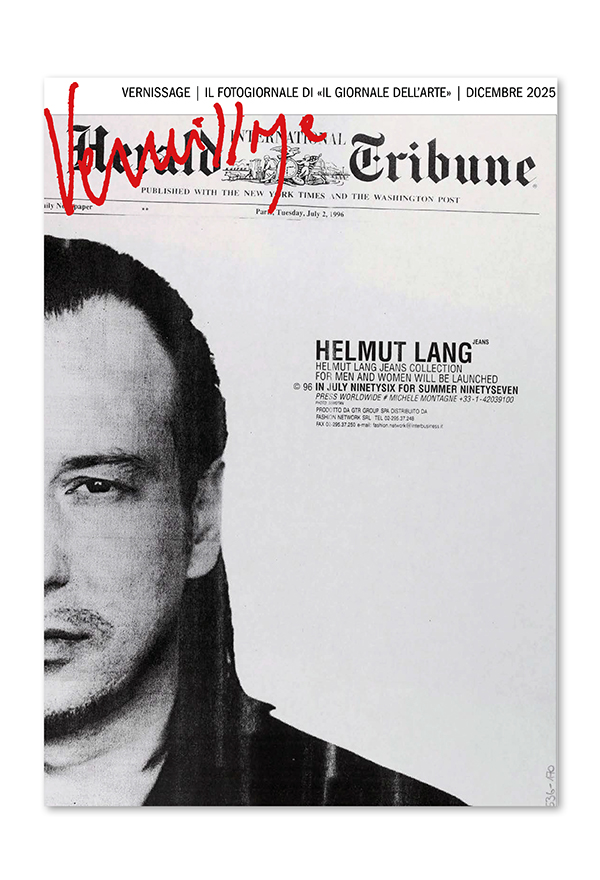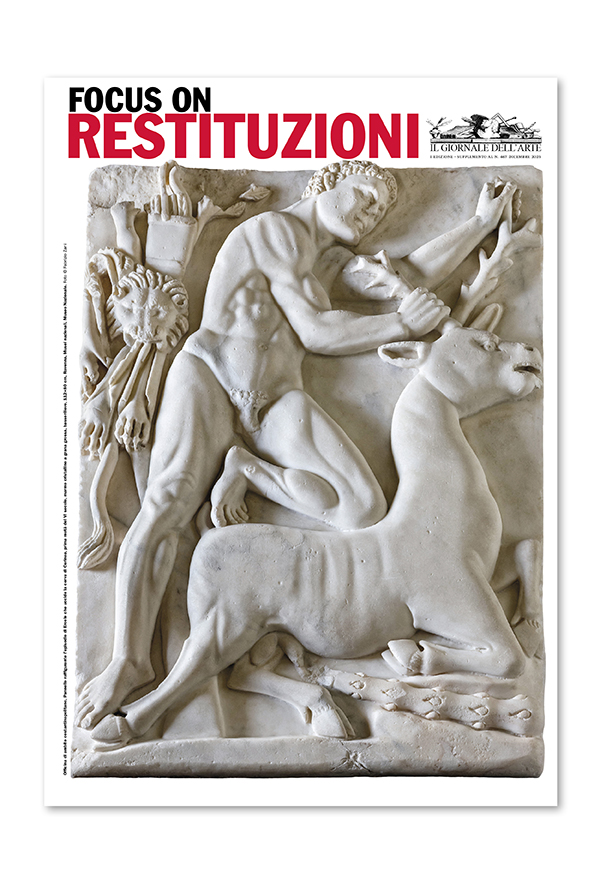Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Stéphane Renault
Leggi i suoi articoliLa Fondation Beyeler di Basilea ospita una retrospettiva su Jeff Wall, aperta al pubblico fino al 21 aprile, con più di 50 scatti del fotografo canadese che, realizzati in cinque decenni, ripercorrono l’evoluzione della sua pratica artistica. Stéphane Renault ha intervistato l’artista.
Qual è stato il suo primo choc visivo?
Da bambino sfogliavo i libri d’arte nella nostra casa di Vancouver. Ne sono sempre stato affascinato e quelle immagini probabilmente sono state i miei primi «choc». In particolare, mi ricordo il «Trionfo della Morte» di Pieter Brueghel il Vecchio. Avrò avuto più o meno 11 o 12 anni.
Ha studiato storia dell’arte all’Università della British Columbia, a Vancouver (dove poi ha insegnato) laureandosi con una tesi sul Dadaismo a Berlino. Che cosa l’ha colpita di questo movimento?
Ho iniziato a studiare storia dell’arte a Vancouver perché non volevo andare in una scuola d’arte. Desideravo saperne di più sul XX secolo. Mi interessavano gli anni ’20 del Novecento, in parte per l’atmosfera politica dell’epoca, era la fine degli anni ’60. Fu un interesse molto intenso, anche se passeggero.
Crede che lo studio del Dadaismo abbia influenzato il suo lavoro successivo?
Non più di altre cose. Sicuramente è così che ho conosciuto il lavoro di John Heartfield, rinomato per i suoi esperimenti con il fotomontaggio tra il 1920 e il 1930, una pratica che apre a diverse possibilità. Molte mie fotografie, soprattutto con l’avvento del digitale, sono essenzialmente dei fotomontaggi, nel senso che sono costituite da più immagini. Ma, a differenza del lavoro di John Heartfield, dove gli elementi originali sono esplicitamente riconoscibili, nel mio caso non è facile capire come sono stati utilizzati.
Quali fotografi o artisti l’hanno influenzata?
Sono sempre stato attratto da quelle che considero le migliori opere d’arte, vecchie o nuove che siano. Nessun artista ha avuto un ruolo preponderante o determinante nel mio lavoro. Mi sono interessato a John Heartfield come a Paul Gauguin, Jackson Pollock o Donald Judd.
Perché si è avvicinato alla fotografia e quali sono state le sue prime esperienze a partire dagli anni ’70?
Quand’ero bambino disegnavo e dipingevo. A un certo punto, negli anni ’60, con l’avvento del postminimalismo e dell’arte concettuale, mi trovai di fronte a forme d’arte più sperimentali e innovative. Io e alcuni miei amici eravamo entusiasti di queste novità e abbiamo cominciato anche noi a lavorare in quel modo. Alla fine del decennio apparve una nuova versione della fotografia concettuale o postconcettuale. Andava di moda allora. Il mio interesse per la fotografia viene da là. Ma sentivo che non mi apparteneva e che dovevo intraprendere un’altra strada: guardare alla fotografia documentaria classica e reinventare la fotografia soggettiva, per creare delle composizioni di immagini.
Molte sue immagini creano confusione per la loro complessa messa in scena che ricorda la fotografia di reportage. Là dove lo spettatore crede di trovarsi di fronte a qualcosa di vero, in realtà si tratta di un’immagine sapientemente architettata. Giocare su questa ambiguità, creare l’illusione, sondare le frontiere tra verità e finzione, fa parte della sfida?
Non proprio. Io cerco di creare, proprio come dice lei, una illusione di realtà. Lo faccio per molte ragioni. Una di queste ruota attorno al mio interesse per l’effetto pittorico finale, e questo spesso può richiedere un lavoro di composizione. Quando la gente fa reportage, spera di cogliere, grazie al talento artistico e ai mezzi tecnici molto limitati (poiché generalmente hanno una sola macchina fotografica) un’inquadratura funzionale a un’immagine colta quasi per caso o per una combinazione di casualità. Immortalare un evento reale diventa una vera e propria «immagine» per chi lo sa fare. Credo non riusciremo mai a sfuggire a questo aspetto fondamentale della fotografia. Ma non è l’unico modo.
Spesso sono testimone di cose che avrebbero potuto essere affascinanti se fossero state immortalate nella vita reale. Ma non è ciò che faccio io. Non lo faccio perché non mi piace ottenere il genere di fotografia che voglio io. Se la pensassi diversamente, farei reportage pure io. Io ricostruisco ciò che ho visto con grande fedeltà degli aspetti essenziali. Cerco di riprodurre ciò che mi è sembrato significativo. Si tratta essenzialmente di un processo compositivo. Se il luogo in cui mi trovo non è in sintonia con quello che sento, mi sento libero di andare da un’altra parte. Non so spiegare il perché, ma so che nel mio caso funziona così. Ricostruisco ciò che ho visto cercando di avvicinarmici, di liberare la sensazione di quello che ho fotografato e di ciò che ha significato per me.
L’illusione è una specie di realismo nell’immagine. Non si tratta di un’istantanea, non voglio ingannare nessuno e non mi interessa l’interazione tra artificio e realtà. A me interessa ottenere un’immagine in grado di convincere che ciò che si sta guardando ha un senso rispetto alla realtà. Se si percepisce questa sensazione di «reale», vale tanto quanto una storia, un romanzo o qualsiasi altra forma d’arte. Si è persuasi che ci sia un impulso emotivo, un senso e una bellezza. Ciò che provo a realizzare è una specie di poetica della fotografia, a discapito di un approccio più determinato e prosaico tipico del reportage. Chiamo questo tipo di immagini «quasi documentarie», perché non sono documentarie, ma contemplano ciò che fa la fotografia documentaria e ciò a cui assomiglia.
Questo approccio, conferisce alle sue immagini una dimensione narrativa. Lei utilizza il termine «fotografia cinematografica». In che modo l’ha influenzata il cinema?
Negli anni ’60 e ’70 ero, come molte persone, interessato al cinema. Era un periodo molto felice, i grandi registi lavoravano in libertà. Non erano al servizio delle grandi case cinematografiche; producevano opere che non erano necessariamente di intrattenimento. Penso ad «autori» come Roberto Rossellini, Ingmar Bergman o Jean-Luc Godard. Guardavamo i loro film come si potevano ammirare le opere di Jackson Pollock. In quell’epoca il cinema ha avuto un’influenza significativa su tutte le arti. Non che prima non l’avesse, ma da quel momento si intensificò. Molti film hanno avuto un forte impatto su molti artisti. Ciò che a me interessava era la dimensione costruita del cinema, la tecnica fotografica molto sviluppata. Mi dissi infatti che quel tipo di composizione (o costruzione) sarebbe stato utile per ciò che volevo fare. Se lavori per strada come Henri Cartier-Bresson, una macchinetta piccola è sufficiente. Ma per realizzare delle immagini più costruite dovevo ricorrere a un equipaggiamento diverso, in grado di rispondere a certi bisogni tecnici. Più elaborate: non migliori, non più importanti, semplicemente più elaborate. Il cinema ha quindi giocato un ruolo importante ma non direttamente. Non ho mai voluto veramente diventare regista. Non penso che le mie fotografie siano più o meno narrative di quelle di altri.
Qual è il suo modus operandi per dare vita a una fotografia?
Non seguo alcun processo prestabilito. Tutto dipende dal punto di partenza, che a sua volta dipende sempre dal caso, come ho detto, vedendo, ascoltando, immaginando… poco importa, qualcosa arriva. «A Sudden Guest of Wind», la fotografia ricavata da un’incisione su legno di Hokusai, per esempio, nacque perché mi trovavo per caso in una libreria dove ho sfogliato un libro su di lui. Ho visto questa immagine, che probabilmente avevo già visto, e in quel momento sono stato colpito dalla natura fotografica di quella composizione e dal fatto che, attraverso essa, Hokusai avesse creato un effetto istantaneo. È diventato il mio punto di partenza. Mi sono detto che dovevo provare a riprodurre questa composizione «fotografica». Facendo così, avrei reso una sorta di omaggio a Hokusai, che poteva essere una cosa altrettanto interessante.
Nel trittico «The Gardens» (2017), per esempio, lo stesso personaggio appare più volte. Tutto è accuratamente scritto in anticipo, come una sceneggiatura, o si crea la composizione in postproduzione, in totale libertà?
Postprodurre un’immagine significa aggiungere del materiale a ciò che è già stato fotografato. Non faccio «postproduzione» in questo senso. Le mie fotografie sono strutturate per essere combinate. Niente di più. Niente è «scritto in anticipo». Guardando attentamente il cinema, ho imparato che c’era una scrittura nella realizzazione delle immagini. Io non procedo in questo modo. Non c’è una scenografia. Se esiste un elemento scritto, non l’ho scritto io. Sopprimo tutti i pensieri narrativi e mi accontento di lavorare sull’immagine in sé.
In che modo il digitale, tipo Photoshop, ha modificato la sua pratica?
Il punto è che più di un negativo può essere utilizzato nella realizzazione di una sola immagine. Si tratta di una linea di demarcazione fondamentale rispetto alle fotografie precedenti o nella maggior parte di esse. Nientemeno, continuo a realizzare fotografie a partire da negativi unici. Lo faccio ogni volta che posso, è più facile e immediato. Ma non è sempre possibile ottenere ciò che voglio in questo modo. Photoshop è apparso agli inizi degli anni ’90 e mi ha subito interessato, perché sapevo che avrebbe offerto più possibilità. Permette di combinare dei negativi per creare un’immagine che sembra essere stata sviluppata da un solo negativo, e amo questa illusione.
Lei è stato il primo a presentare le sue fotografie in un lightbox, una scatola luminosa precedentemente riservata alla pubblicità. Come le è venuta l’idea di usare questo dispositivo? Qual era la sua intenzione, rispetto alla stampa classica?
Non avevo mai pensato di farlo, ma all’inizio degli anni ’70, quando ho iniziato seriamente ad interessarmi alla fotografia, ho dovuto trovare un mezzo per realizzare le stampe. E la maggior parte delle possibilità tecniche non erano soddisfacenti. Uno dei laboratori a cui mi rivolgevo mi ha mostrato questo materiale trasparente, a cui non avevo mai veramente pensato. Ho amato il suo aspetto e ho capito che avrebbe potuto risolvere qualche problema. Ho quindi deciso di provare. All’epoca, nessuno l’utilizzava. Sembrava portare una specie di dinamismo e una certa volgarità che mi sembravano fresche e interessanti. L’accoglienza riservata alle mie prime scatole luminose è stata globalmente positiva, ciò che mi ha incoraggiato a perseguire questa strada, ciò che ho fatto per una ventina d’anni. Ma durante quel periodo, non mi piaceva avere una sola forma per le mie immagini, volevo espandere il mio repertorio. Quando ho potuto, ho aggiunto stampe in bianco e nero alla stampa ai sali d’argento, molto tradizionale, il cui effetto è quasi completamente opposto a quello dei trasparenti. Le stampanti ad inchiostro hanno iniziato a migliorare verso il 2005 e hanno offerto delle belle possibilità per realizzare delle stampe a colori su carta; le mie prime risalgono proprio ad allora. Non mi sono mai voluto limitare a un solo tipo di immagine. Non ho mai considerato la lightbox come un «marchio depositato». Me ne sono allontanato più di 15 anni fa. Ci ritornerò, forse, ma per ora non sento motivi per farlo.
Ciò che colpisce della mostra, è la scelta del grande formato, diventato monumentale in questi ultimi anni…
La fotografia classica era generalmente concepita come reportage, principalmente per i media stampati: giornali, riviste e libri. Le stampe erano realizzate per poter essere guardate in quel modo, il loro formato era determinato dall’industria editoriale. Non c’è alcun motivo per cui molte fotografie scattate negli anni tra il 1920 e il 1940 non siano più grandi. Ho ammirato la libertà che la pittura ha sempre avuto in termini di scala e dimensioni, dal gigante al minuscolo. Non aveva dei limiti imposti dall’esterno. Inoltre, esiste una relazione fisica e quindi psicologica molto interessante secondo cui un’immagine si avvicina alla dimensione del mondo reale, ciò che chiamiamo «la scala della vita». È una specie di momento magico durante il quale l’immagine sembra il continuum del mondo che lo spettatore occupa. Non vedevo perché la fotografia non potesse assimilare questa idea. Non ho mai voluto fare grandi foto in quanto tali, per il proprio interesse, ma solo perché volevo avere la libertà di stamparle nel formato che mi sembrava più adatto a loro.
Nel 2005 lo Schaulager a Münchenstein, vicino Basilea, ha presentato una grande mostra del suo lavoro dal 1978 al 2004, prima della Tate Modern di Londra. Alla Fondazione Beyeler sono esposte 55 opere iconiche al fianco di altre più recenti. Come è stata pensata questa mostra assieme al curatore Martin Schwander?
Abbiamo guardato allo spirito della mostra del 2005, perché fu davvero importante, ma non vogliamo che questa vi assomigli. E poi, sicuramente, lo spazio con cui abbiamo dovuto confrontarci ora è molto diverso. La Fondazione Beyeler, avendo una configurazione relativamente fissa, abbiamo deciso di utilizzarla per creare delle serie di immagini. Volevo che ogni sala fosse unica, diversa dalla seguente, cosicché chi percorre la mostra abbia l’impressione di vederne 10, perlomeno 10 raggruppamenti specifici che possono avere delle ragioni diverse per essere insieme, ma ciascuno di essi è, in un certo senso, singolare. Abbiamo lavorato partendo da questo presupposto e l’abbiamo sviluppato man mano, trovando motivi per associare certe immagini. Per esempio, nella primissima sala, si ha di fronte scene che si svolgono all’aria aperta nella città di Vancouver. È una specie di studio della città, ma riflette l’idea che il mio lavoro si situa in un luogo aperto sul cielo, il che non è privo di conseguenze. E così via per ogni spazio.
L’insieme rivela una grande diversità, ma allo stesso tempo coerenza, uno «stile». Che cosa direbbe lei sull’evoluzione del suo lavoro?
Non credo che si sia evoluto molto, la creazione di immagini in quanto tale non si presta molto a un discorso del genere. Non è molto cambiata sul lungo periodo. Possiamo tranquillamente andare indietro di 500 anni e vedere, per esempio, pitture e disegni che non sono, a livello strutturale e tecnico, molto diverse da quelle che si fanno oggi. La fotografia è un’arte che s’inscrive in una continuità dalla quale non si può sfuggire. Per questa ragione, non credo che il mio lavoro si sia granché evoluto da un punto di vista tecnico, se non per il subentro del digitale. Ma a parte quello, ciò che mi interessa è un’immagine unificata, ben composta, piena di una vera e propria cattura del mondo con tutti i dettagli e la trama che comporta. Anche se sembra immutabile, la creazione di immagini è assolutamente illimitata. L’apertura della forma impedisce in qualche modo un’eccessiva evoluzione stilistica, ma offre comunque delle possibilità infinite.
Qual è una buona immagine?
Non c’è una definizione, non ci sono degli esempi. Si tratta semplicemente di un insieme di elementi fondamentali che si apprendono all’inizio di un corso d’arte: come usare il colore, la luce, l’ombra, la forma, la dimensione, lo spazio, le sfumature… È attraverso tutti questi parametri formali che si deve lavorare. Bisogna allo stesso tempo scegliere dei punti di partenza appropriati, trovare qualcosa che vale la pena di essere fatta. Ma non esistono mezzi per regolamentare questa parte. Si possono citare degli esempi, identificarli e studiarli. Non come ricette da seguire, ma come immagini finite da cui imparare.
Che consiglio darebbe a un giovane artista o fotografo?
Studiate il meglio dell’arte e ignorate il resto.
Leggi anche:
Jeff Wall: «Il mio lavoro è cinematography»



Altri articoli dell'autore
Camille Bertrand-Hardy, già responsabile dei musei della città di Montélimar, subentra a Stéphane Tarroux alla guida del museo occitano
L’operazione, che consentirà una visita virtuale del capolavoro gotico parigino, «richiederà almeno un anno di lavoro e costerà probabilmente diversi milioni di dollari», ha precisato il presidente del gruppo informatico
L’attuale vicedirettrice subentrerà a Vincent Rondot a partire dal prossimo 1° settembre
«Van Lévé: Visioni sovrane delle Americhe e dell'Amazzonia creola e marrone (Guadalupa, Martinica, Guyana e Haiti)», prevista per l’autunno 2026, è stata cancellata per motivi di bilancio. La curatrice denuncia una decisione «brutale e scioccante»