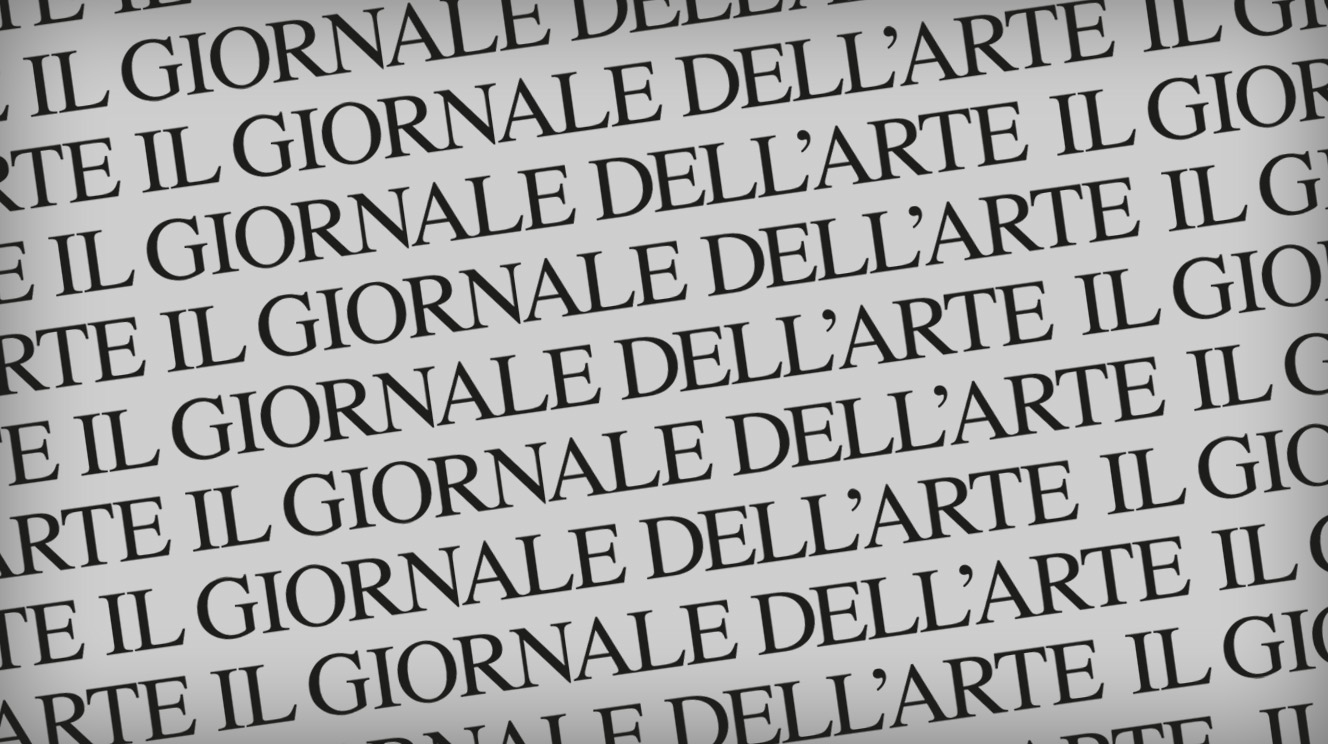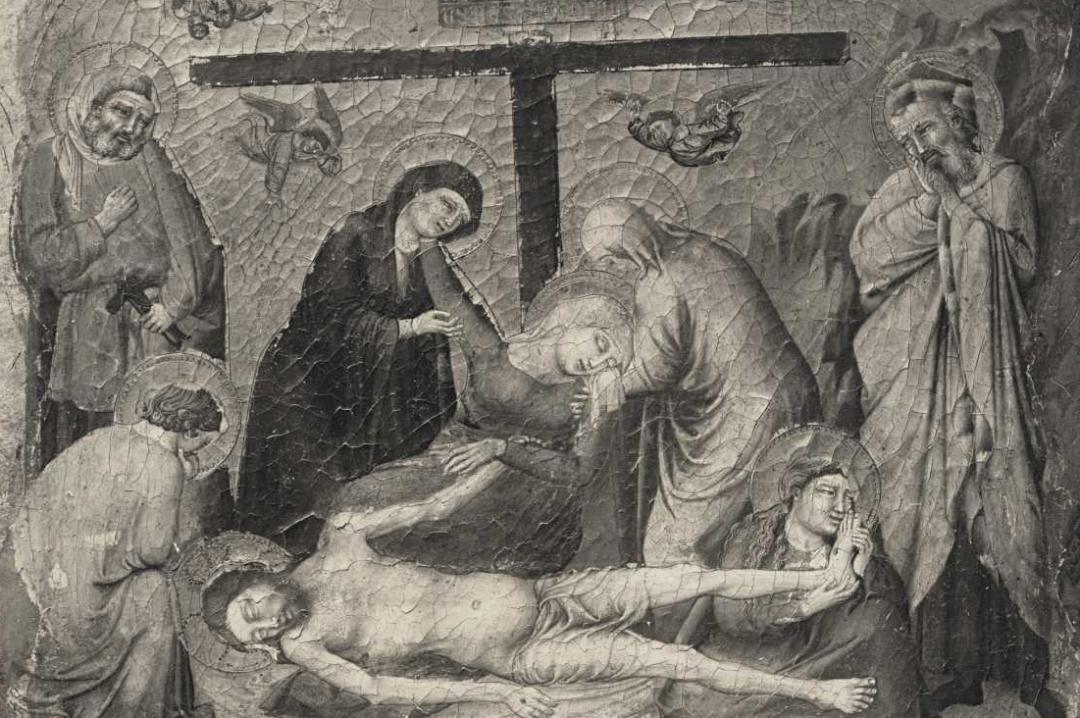Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Giorgio Bonsanti
Leggi i suoi articoli«Ci è parso giusto in questo momento rimettere l’accento sulla connoisseurship con una serie di seminari, da Vasari ai giorni nostri, dedicati a una persona o ad un momento significativo per la connoisseurship quale momento primo della storia dell’arte, oggi molto trascurato, riportando su di essa l’attenzione dei giovani, ma non soltanto; ad esempio, degli insegnanti». Così si è espresso Andrea Bacchi, direttore della Fondazione Federico Zeri ubicata a Bologna nel convento di Santa Cristina in occasione del seminario di formazione specialistica tenuto presso la Fondazione stessa nei giorni fra il 24 e il 26 settembre. Intitolate «Il mestiere del conoscitore. Roberto Longhi», le giornate bolognesi hanno presentato un quadro esauriente delle tante questioni che muovono dal momento primario dell’attribuzione per coinvolgere ogni modo e modello di fare storia dell’arte, grazie ad una selezione nella costruzione del seminario e nell’individuazione dei relatori operata dai quattro curatori (oltre a Bacchi, Anna Maria Ambrosini, Daniele Benati, Aldo Galli).
La scelta di Longhi come primo oggetto nella serie dei seminari era in qualche misura obbligata, perché se da un lato riguardava l’attributore principe nel nostro Novecento, dall’altro grazie appunto alla complessità della figura longhiana poteva dimostrare come l’attribuzione non sia che il primo stadio di un discorso tipicamente assai articolato. Già parlare di «attributore» anziché di «attribuzionista», e di «conoscitore» anziché «riconoscitore» (lo ha sottolineato Massimo Ferretti) significa aprire l’orizzonte nella direzione di una storia dell’arte a tutto tondo, disciplina che offre chiavi di lettura e d’interpretazione dei fenomeni storici non meno utili ed efficaci di altre più praticate. E forse il risultato più permanente del seminario consisterà nell’aver ripetutamente, e da parte di più autori, insistito sulla complessità dell’operazione longhiana.
È stato soprattutto Bruno Toscano a illustrare la tecnica attributiva di Longhi; con la consapevolezza che comunque un sistema attributivo è sempre provvisorio, Longhi attraversava tre fasi: una prima di riconoscimento di specificità identificative, una seconda diretta ai «sentimenti, ai modi di raccontare», una terza di attribuzione di luogo, di dati geostilistici. Naturalmente l’operazione non era senza rischi, soprattutto nella fase due («la procedura sentimentale ha giocato un tiro a Longhi», ad esempio, nel suo fraintendimento degli affreschi del Trionfo della Morte nel Camposanto di Pisa, giudicati opera di un bolognese, ma molti anni dopo riconosciuti da Luciano Bellosi al fiorentino Buffalmacco); Toscano ha segnalato quanto sia ardua «un’antologizzazione di elementi di espressione». Ma Longhi stesso aveva allargato di molto il senso della regionalità, i suoi procedimenti attributivi non avevano niente di «catalogante» (così scrisse Francesco Arcangeli, con evidente riferimento a Bernard Berenson).
Altri approfondimenti del metodo longhiano sono stati offerti in chiusura delle due prime giornate da Massimo Ferretti. A Longhi è dovuta, ha spiegato, nientemeno che «la totale configurazione della mappa dei valori della cultura figurativa italiana», proponendo «un’Italia complessa, fatta di regioni e province, ma inserita nell’Europa». L’attribuzione, ancora Ferretti, è da vedere nella nozione di serie: non una divinazione, ma lo spostamento di un anello di una catena, tale da procurare nuovo ordine a una serie appunto (Longhi alza un giudizio abbassandone un altro; rammento la frase di Max J. Friedländer in reazione ad un’attribuzione sbagliata: «Vedo, caro collega, che lei non conosce due pittori»). Ferretti ha inoltre ricordato che Longhi, personaggio di precocità mostruosa (saggi ricchi di aperture fondamentali scritti a vent’anni), non nasceva attributore: in una sensazionale lettera indirizzata a Berenson, scritta a neanche ventidue anni (riscoperta da Giacomo Agosti), gli scriveva di sperare di non fermarsi al periodo di tirocinio di conoscitore, come è quello di chimico per il pittore. Conoscitore sì, ma in un senso estremamente complesso, di straordinario riconoscitore; e, direi io, interprete delle coordinate storico-geografiche di un’opera, di un autore (Longhi combatté vittoriosamente la tradizione interpretativa vasariana fiorentinocentrica), di un contesto culturale. Il tutto sulla base (elemento spesso trascurato) di una conoscenza formidabile, difficilmente eguagliata, della letteratura artistica; essenziale non soltanto come fonte, ma come momento essenziale per procurare l’acquisizione del lessico del mestiere del conoscitore. Il famoso linguaggio longhiano nasce dal dannunzianesimo, si pasce di vocabolari compulsati fino alla distruzione, ma si costituisce, nella sua maturità, in un sistema di mimesi delle opere e degli artisti che è rimasto ineguagliato nella sua funzionalità storico-critica.
Gli argomenti trattati e illustrati dai relatori erano quelli tipici nel sessantennale percorso longhiano (1910-1970, anno della morte). Dopo la proiezione di una bella videointervista di Maria Cristina Terzaghi a Mina Gregori (che aveva portato agilmente a Bologna i suoi novantun anni), Anna Ottani Cavina ha parlato di Longhi studioso del Seicento, fin dalla tesi su Caravaggio (1911), quando il secolo era «prateria sconosciuta», ricordando che la sua fu essenzialmente una produzione di saggi più che di monografie (cosa valida in fondo per lo stesso Zeri). Andrea De Marchi ha affrontato uno degli argomenti spinosi, quel Giudizio sul Duecento che al suo apparire (1948) rappresentò «un pugno nello stomaco per i bizantinisti»; né mancava nel suo ragionamento una lettura ideologico-politica di quel saggio famoso, alla luce di una valutazione di Longhi come «fascistissimo», subito contestato in questo da Ferretti; che nel suo intervento ammoniva a tenere conto, nel giudicare il Giudizio, delle conoscenze e degli strumenti dell’epoca. Laura Cavazzini è intervenuta sulla ricostruzione longhiana di un polittico giottesco (verosimilmente in origine nella cappella Pulci-Berardi in Santa Croce a Firenze), recentemente confermata valida ma tuttora contestata da qualche studioso (Andrea De Marchi) sulla base di elementi quali le decorazioni delle aureole. Andrea Bacchi ha parlato di uno dei grandi meriti longhiani, i suoi studi sulla pittura ferrarese quattrocentesca (fino ad allora, era considerato solo un seicentista), fondamentali per Tura, Cossa e soprattutto Ercole Roberti. Neville Rowley ha trattato un altro argomento quattrocentesco, Longhi e Domenico Veneziano, con la ricostruzione della Pala di Santa Lucia dei Magnoli. Aldo Galli ha illustrato un argomento complicatissimo come il misterioso Giovanni di Francesco, forse identificabile, anche a seguito di studi recentissimi, con il cosiddetto Maestro di Pratovecchio, mentre un Giovanni di Franco sarebbe l’autore del Trittico Carrand del Bargello; un corpus dunque da dividere in due, ma rimangono questioni insolute. Alessandro Angelini, pur avendo recentemente pubblicato una monografia su Piero della Francesca, soggetto fra gli identificativi della storia d’arte longhiana, sorprendentemente non ha affrontato se non tangenzialmente il Maestro di San Sepolcro trattando invece di artisti «minori» come Giovanni di Piamonte e Tommaso Garelli. Mauro Natale ha esaminato un altro argomento spinoso, la famosa ricostruzione longhiana del pittore lombardo di fine Quattrocento Carlo Braccesco, oggi messa in forse col dubitare dell’attribuzione al pittore dell’«Annunziata» del Louvre (e qui osservo che Longhi descriveva l’angelo annunciante come «quasi supino», mentre in realtà è prono). Liliana Barroero ha ricordato il riconoscimento da parte di Longhi dell’importanza per il giovane Goya di Luca Giordano e Corrado Giaquinto (oltre ovviamente al Tiepolo), in alternativa al classicista Mengs; mentre a Francesco Caglioti è toccato il compito un po’ imbarazzante di parlare del rapporto fra Longhi e la scultura, in cui il grande critico non dette certamente il meglio di sé. Anna Maria Ambrosini, riconosciuto che «Raffaello non era nelle sue [sc. di Longhi] corde», ha messo in luce la sua battaglia contro la centralità del Rinascimento basato su Leonardo e Raffaello appunto. Complesso anche il compito di Daniele Benati, come lo fu il rapporto di Longhi con Annibale Carracci; Benati ha sottolineato (citando Carlo Volpe) un altro aspetto dell’attribuzione, l’essere un meccanismo di approssimazione all’insegna del relativismo, basato sulle conoscenze che abbiamo di un artista in un determinato momento. Di nuovo la letteratura artistica studiata da Stefano Pierguidi, mentre Maria Cristina Terzaghi ha affrontato un argomento longhiano per eccellenza come le copie e repliche degli originali caravaggeschi. Il raro caso di uno scritto longhiano sui disegni è stato raccontato dalla specialista Simonetta Prosperi Valenti Rodinò, mentre Alessandro Morandotti ha ricordato che sulla pittura lombarda del Seicento, Longhi «aveva indovinato tutto», lamentando però, come altri partecipanti, che gli archivi della Fondazione Longhi non siano fruibili per gli studi, situazione che andrebbe certamente corretta, e che è in contrapposizione con la politica di apertura e disponibilità praticata invece dalla Fondazione Zeri.
Infine, in una seduta aperta al pubblico tenuta il sabato mattina, si sono succeduti due passati président-directeur del Louvre, Michel Laclotte (i numerosi riconoscimenti di opere italiane operati da Longhi in Francia) e Pierre Rosenberg (Longhi e Poussin, con l’attribuzione del «Re Mida» di Ajaccio). Di grande interesse l’intervento di Keith Christiansen, del Metropolitan Museum di New York, su artisti come Valentin, De La Tour e Le Nain, sui quali sono programmate a breve mostre monografiche. Ultimo, prima della chiusura di Giovanni Agosti con l’avvincente racconto delle sue vicende personali in rapporto con la conoscenza di Longhi, il contributo di Alessandro Ballarin che ha ricordato la geniale tempestività delle attribuzioni longhiane a Giorgione, lamentando che i «Cantori» della Galleria Borghese siano stati «sconciati dal restauro e collocati sopra le porte». Si auspica che la Fondazione Zeri riesca, come è negli intendimenti, a pubblicare gli Atti, nell’attesa dei prossimi seminari della serie.
Altri articoli dell'autore
Aperto per restauri • Diagnosi sul restauro da restaurare di Giorgio Bonsanti, già professore all’Università di Firenze
Aperto per restauri • A un anno dall’inaugurazione del museo, nella nuova sede di Palazzo Cavalli si è tenuto un convegno rivelatosi occasione interessante e piacevole per presentare un’ampia casistica di interventi conservativi infrequenti
Orietta Rossi Pinelli ripercorre le principali tappe di come sono cambiate le regole dalla Carta di Atene del 1931 ad oggi
Operatività, ricerca e didattica hanno improntato l’attività dell’insigne «ambasciatore» del restauro italiano, per quasi quarant’anni attivo all’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, di cui è stato soprintendente per dieci anni