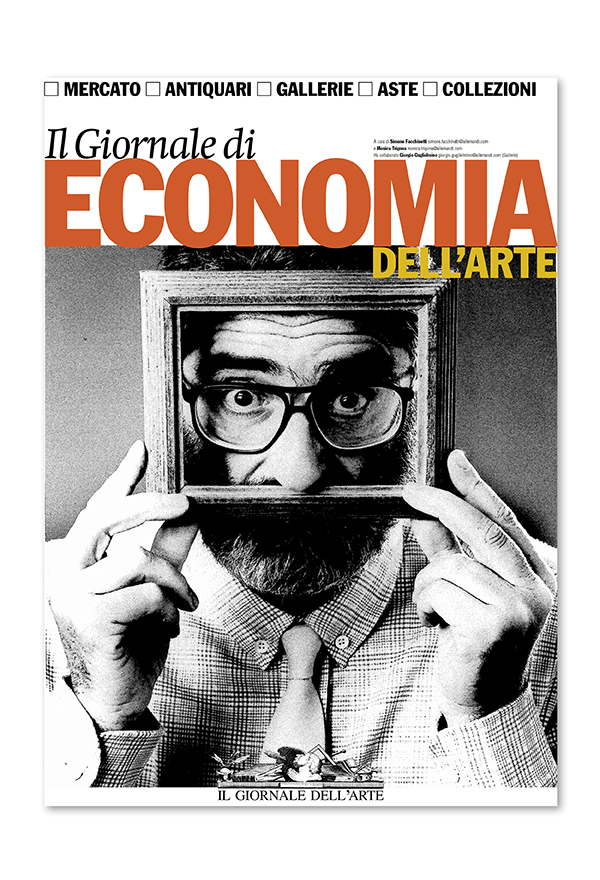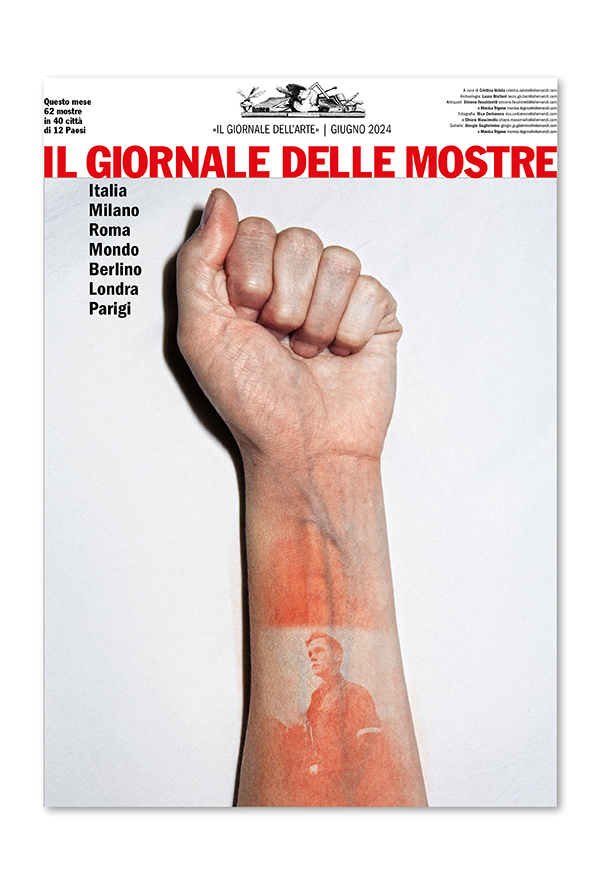La mostra di Liliana Moro (Milano, 1961) allestita al Pac dal 26 giugno al 15 settembre prende il titolo dall’ultimo suo lavoro «Andante con moto» (2023), un omaggio (l’ennesimo, ma forse anche l’ultimo) che l’artista milanese dedica a Samuel Beckett: per lei una guida sin dall’adolescenza quando, letto Aspettando Godot, si appassionò a tal punto alla sua scrittura da decidere di studiare scenografia. Scelse poi l’arte visiva ma la lezione del drammaturgo irlandese è rimasta ben viva nel suo modo di «fare arte attraverso lo spazio», proprio come voleva lui che, in ambienti vuoti e disadorni, era attentissimo alla disposizione degli attori nello spazio. In arrivo dal Kunstmuseum Liechtenstein di Vaduz, ma con nuovi innesti e con qualche elisione, e pronta a trasferirsi, dopo il Pac, al Magazzino Italian Art di New York, che con le altre due istituzioni l’ha prodotta, la rassegna, curata da Letizia Ragaglia e Diego Sileo, presenta il suo lavoro dalla fine degli anni Ottanta sino ad oggi con opere ben note come «Spazi», esposta alla Biennale di Venezia del 2019, e altre viste raramente. Ne parliamo con lei.
Liliana Moro, partirei proprio dall’ultima sua opera, «Andante con moto». Vuole illustrarne il significato?
Nasce da un atto unico di Beckett del 1958, Krapp’s Last Tape, in cui il protagonista sessantenne (allora, un anziano) affronta il suo passato e i suoi fallimenti attraverso i nastri magnetici su cui, nel tempo, ha tenuto una sorta di diario. Avevo il testo nel cassetto da trent’anni ma sapevo di non essere ancora pronta. Ora, compiuti i sessant’anni, ho deciso di lavorare su questo testo, cui ho aggiunto per la prima volta frasi mie accompagnate dal suono di un treno, perché il treno fa parte della mia storia personale. Nel testo compare una banana: ne ho realizzata una, grande, di cemento grezzo con, accanto, una buccia vera che deperirà e sarà rinnovata regolarmente. Per me è una sorta di ultimo omaggio a Beckett: mi ha dato tantissimo, ma ora forse non c’è più bisogno di disturbarlo.
In mostra ci sarà anche «Moi» (2012). Si può considerare una sorta di autoritratto?
No, non lo è. Mi piace pensare che il pubblico lo prenda su di sé penetrando nel cerchio formato dai 12 altoparlanti su treppiedi che diffondono la mia voce mentre leggo la recensione di un critico alla mia performance «Studio per un probabile equilibrio in movimento», tenuta con Giovanna Luè nel 1997. Esposi «Moi» nel 2012 nell’ex Chiesa di San Pietro in Atrio a Como, quand’ero Visiting Professor alla Fondazione Antonio Ratti, ma in Italia non è molto conosciuta. Tenevo perciò a esporla anche a Milano, dopo Vaduz.
Il suono è una costante del suo lavoro. Anche «Le Nomadi» (2023), presentato in anteprima a Vaduz e ora a Milano, si fonda su suoni da ascoltare con attenzione.
Sì, è un lavoro in cui sono i carrellini e uno zaino, con le basi musicali, di quelli usati sui treni e sui tram dalle nomadi (in senso lato, di homeless) per suonare e cantare. Ho pensato che quei bagagli fossero per loro il luogo di lavoro e la casa che non hanno. Ne esce un suono lieve: bisogna chinarsi per sentirlo...
La dimensione politica è sempre presente nelle sue opere: talora è esplicita (come in «Quattro stagioni» del 2014, in cui «Bella ciao» è cantata in più lingue), talora è latente, come quando, appunto, costringe l’osservatore ad abbassarsi.
Mi piace pensare alla figura umana che non emerge ma si piega, cambia punto di vista, dà attenzione a realtà trascurate. Anche il suono chiede attenzione, per questo l’ho sempre usato. E anche perché costruisce e modella uno spazio mentale.

«Sundown City Life» di Liliana Moro. Foto © Marco Cappelletti. Cortesia dell’artista
Altri articoli dell'autore
Riuniti nella residenza a Tremezzina i capolavori di Canova, Thorvaldsen e Hayez raccolti per rivalsa su Napoleone dal marchese lombardo
Le opere dell’artista spagnolo avvolgono la sede milanese della galleria con un’atmosfera sognante, tra il bucolico e l’immaginario
L’omaggio al gallerista recentemente scomparso di tre collezionisti-galleristi nel nuovo spazio che è «un luogo di studio, di conversazioni colte e di dibattito»
Donato da Giovanna Zanuso, presidente della Fondazione Sacchetti, la grande tela di Gian Paolo Panini sarà il fulcro della collezione settecentesca riallestita nell’ala nuova del museo a Milano