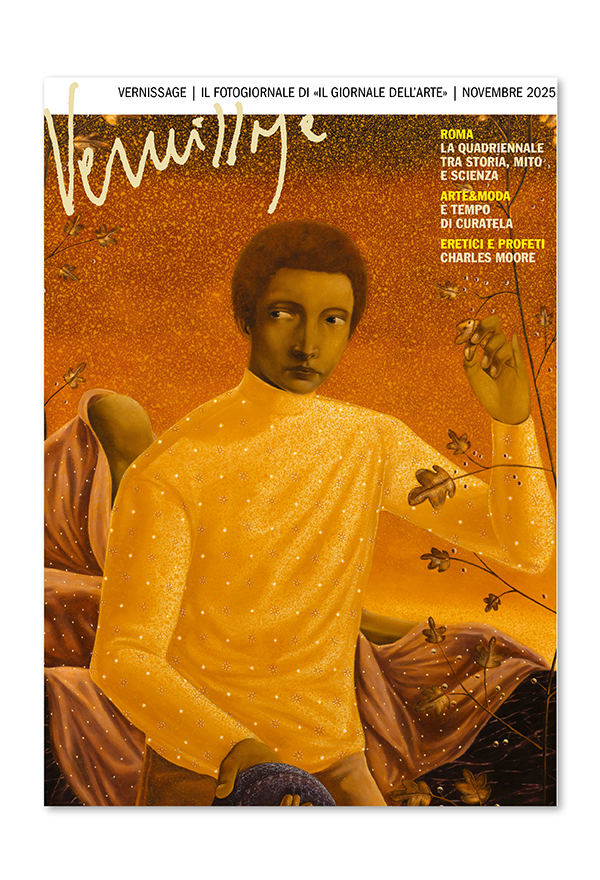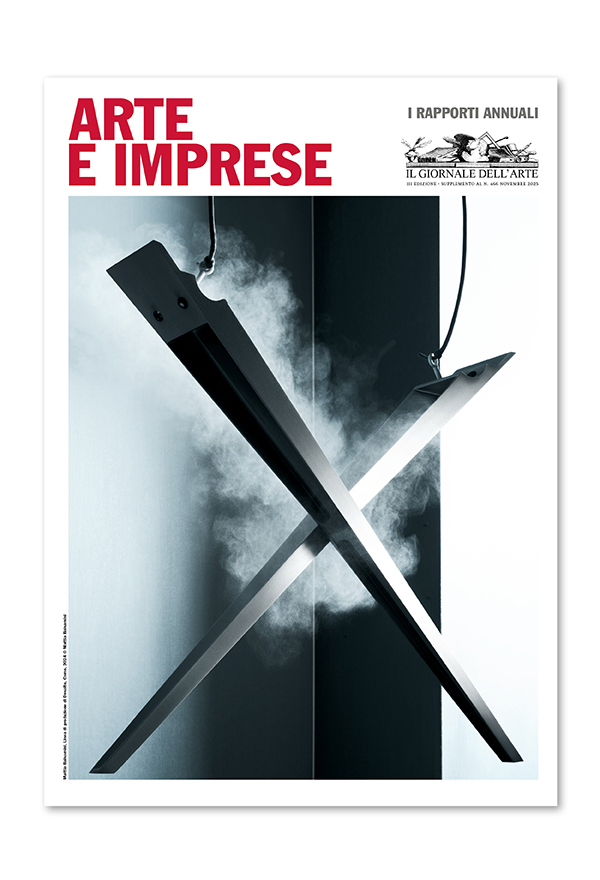Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
A 50 anni da «Aktion n. 50», la performance in cui Hermann Nitsch (Vienna, 1938-Mistelbach, 2022), nel suo malandato castello di Prinzendorf, in Bassa Austria, metteva in scena un uomo nudo e bendato in un’evocazione della Crocifissione, il Museo Diocesano di Brescia presenta, dall’11 settembre al 30 novembre, un progetto monografico che indaga il tema, così intensamente sentito dal maestro dell’Azionismo viennese, del sacrificio come espiazione delle atrocità perpetrate dal nazismo e dalle dittature del ’900.
La mostra, intitolata «Hermann Nitsch Corpo-Sacro-Mito», è curata da Ilaria Bignotti con la Nitsch Foundation di Vienna e con la galleria Iaga Contemporary Art di Cluj-Napoca (Romania) e riunisce intorno alla storica fotografia della Passione-Crocefissione di quel giorno del 1975, una scelta di opere di grandi e grandissime dimensioni. Molti sono i «Relikt», lavori che l’artista ostende come «relitti» di quelle tragedie, intrisi come sono di liquidi e fluidi di un rosso sanguinoso, quando non di sangue vero (bovino, preso dai macelli). Come accade in «Senza titolo (Action shirt)» (2004), un lungo camice inzuppato di rosso indossato durante una performance, o in «Relitto con applicazioni» (2008), in cui una pianeta rossa e alcune stole liturgiche, oltre a cerotti e garze intrise di liquido rosso, sono applicati sulla tela in un grande, cruento collage. Sangue vero e tela di lino sono invece i materiali di «Relitto tessuto (Relikttuch)» (1998), mentre per «Santa Lucia 77. Sangue. Vittima. Operazione» (1977) Nitsch si è servito di colore acrilico gettato su una stola e garze.
Anche nei lavori in cui non entra il colore del sangue, però, la tragedia è presente nei grovigli di membra e di forme che rammentano delle interiora, perché il corpo, violato dalla brutalità delle dittature, è sempre il protagonista dei suoi lavori, anche quando è solo evocato da abiti o paramenti sacri. Nitsch si serve anche della tecnica serigrafica, con cui crea lavori monumentali come la «Conquista di Gerusalemme» (tre metri di larghezza), realizzata su un «relitto» originale del 1971 e poi riedita durante un’azione del 2017. O come l’«Ultima Cena», realizzata nel 1983 su un altro «relitto» precedente: quasi quattro metri di corpi anatomizzati dall’autore in un groviglio di segni convulsi che, come tutto il suo lavoro, si nutrono degli stimoli della psicoanalisi freudiana per far affiorare dal profondo le emozioni rimosse di ognuno degli spettatori, che nelle sue «azioni» e nei suoi lavori teatrali diventano presto coprotagonisti dell’opera.
Fondato nei primi anni Sessanta da Nitsch con Günter Brus, Otto Muehl e Rudolf Schwarzkogler, l’Azionismo viennese si proponeva infatti di «presentificare per non dimenticare», riaprendo deliberatamente quelle ferite che, dopo le atrocità del nazismo, le persone cercavano di rimuovere consegnandosi al consumismo degli anni del boom economico. Solo verso la fine della sua vita Nitsch virerà verso soggetti sempre più dichiaratamente sacri, e sul tema della resurrezione specialmente, e per farlo si affiderà in prevalenza al segno grafico.