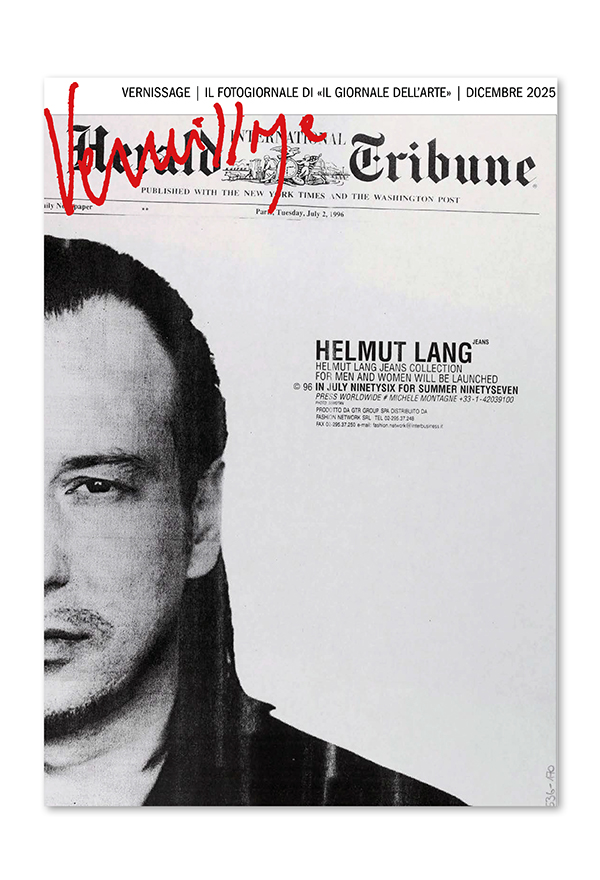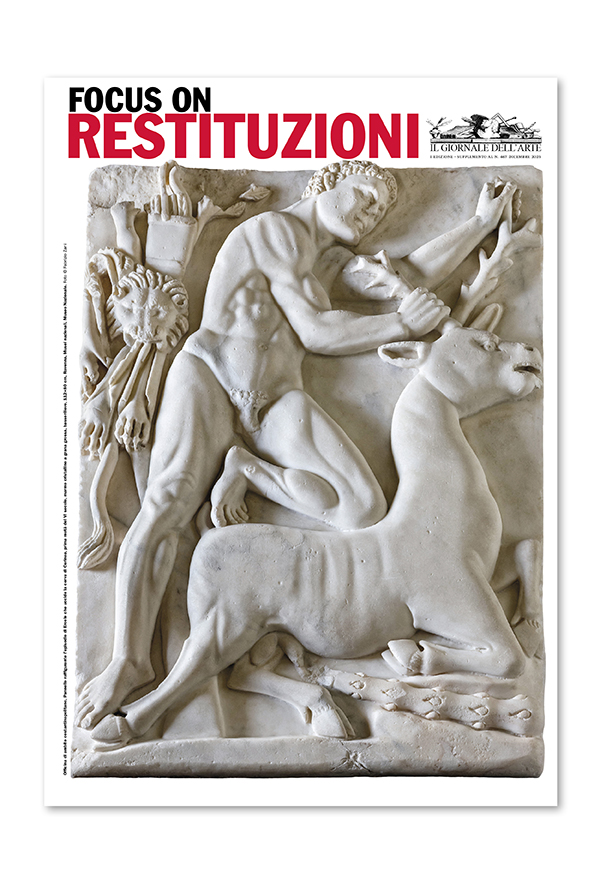Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Stefano Causa, Arabella Cifani
Leggi i suoi articoliSeni. Occhi. Bocca. Mani. E labbra. Sederi e inguini. Si può raccontare una storia dell’arte anche attraverso le parti del corpo. Abbiamo provato a farlo in questa serie spegnendo internet e riallenando il muscolo della memoria. Non è vero come dicono che cultura è tutto quel che rimane quando uno si è dimenticato tutto? Ecco. Tra storia e immaginazione, lavorando di accoppiamenti giudiziosi e nuovi nessi abbiamo provato a ripensare perché le labbra di Pino Pascali e del logo degli Stones sono la sineddoche della sensualità contemporanea più estroflessa e aggressiva. E perché i piedi e le mani siano un valido indicatore non solo dello stile di un artista ma una cartina al tornasole del realismo occidentale. Oggi che viviamo stagioni di narcisismo autoreferenziale interrogarsi sul corpo, e non solo sui lati a e b, ci sembra urgente. Oltre che doveroso.
La mano morsa
Conosco quattro mani che rubano la scena (nella «Pietà» di Brera, il più bel quadro di mani della storia dell’arte); e ne ho viste che si prolungano, si confondono e non si capisce subito a chi appartengano (il «Figliuol prodigo» del Guercino a Vienna, per me medaglia d’argento dopo Giambellino). Ma in quanto a questo devo mettermi ultimo in coda mentre la fila gira dietro l’angolo. Era Roberto Longhi il «Genio delle mani»: è dai Fatti di Masolino e di Masaccio che occorre ripartire per capire cosa significhi guardare non i quadri ma dentro i quadri, quando nel separare le spettanze nella «Madonna col Bambino e Sant’Anna» mise a fuoco la posa «irrevocabile» della Vergine (il giovane Masaccio) opponendola alla «mano di miele» della Sant’Anna che impedisce lo scorcio (l’antico Masolino). Cose penetrate nei migliori manuali.
La mano di miele sicuramente no: né si smette di lamentare quanto abbiamo perso disprezzando simili sciccherie; e la critica nel continuare a ignorare che la letteratura del ’900 vive di reinvenzioni folli e aderenti. La mano di miele non si può tradurre e neanche spiegare. O capisci o passi la mano (ma intanto rinunci a Masolino). Nel 1940 Longhi la issò a contraltare della presa dentro cui la Vergine chiude a chiave le gambe di Gesù. Masolino fa la mano di miele. Masaccio fa la mano morsa.
La Storia è attraversata da incroci di mani. Mani di miele e mani che stritolano, che non fanno il loro mestiere primario e si limitano a descrivere note nell’aria (l’«Annunciazione» del Botticelli), mani offese (Cervantes a Lepanto) e gigantesche che spuntano da sottoterra (come nel «Seppellimento di Santa Petronilla» del Guercino), mani creanti (Michelangelo alla Sistina), mani esploranti (ET, chi altri?), mani che subito capisci che generi di doni distribuissero (quelle di Miles Davis fotografate, ma senza tromba, da Irving Penn).
Il ’900 è un’infilata di mani morte (sui tram), mani pulite (nei tribunali), mani mozze (nei teatri di guerra) e morse in senso proprio (per la copertina di un live del 1977 degli Stones, Warhol immaginò che Mick Jagger l’addentasse). Se però dovessi raccontare a che cosa servano veramente le mani e quanto contino fuori e dentro la storia dell’arte, non avrei dubbi. Chiederei a Gino Paoli. «Senza fine» (1961), con gli arrangiamenti di Reverberi, è una delle più belle canzoni di sempre (chi non si commuova al passaggio di «non m’importa della luna», ottonario bastevole a liquidare secoli di petrarchismo, è sordo). «Tutto è ormai nelle tue mani grandi, mani senza fine», cantava dietro alla Vanoni. E ha continuato a giocarci con le mani quando, un quarto di secolo dopo, ha cucito addosso a Zucchero i versi di un blues smargiasso. «Con le mani» suggerisce applicazioni carnali e allusive (ci sbucci le cipolle, ci accarezzi il gatto…). Ma sempre finalizzate a un contatto («è un incontro di mani questo amore»; «le tue mani così all’improvviso si sono fatte strada fuori e dentro di me»).
Siamo alle ultime battute di un universo intessuto in termini di interazione e dove le mani giocano un ruolo formativo e assodante. Da quest’osservatorio si misura cosa sia cambiato nel costume di casa quando, a Sanremo, la cantante della Rappresentante di Lista, Veronica Lucchesi, che ha la stessa età della canzone di Zucchero, intona: «con le mani ciao ciao». Nonché un omaggio a Tenco, il ritornello sancisce la fine di ogni contatto. Le mani di Zucchero come, volenterosamente, le mani di miele, implorano lo sbocco di un contatto. Queste ti salutano. Non è poco (e neanche molto). Dammi una mano suonerebbe oggi incomprensibile. «Mettere le mani avanti» un modo di dire irriguardoso.
Eppure come i piedi, le mani sono state sempre un indicatore di gradiente realistico (o di antirealismo). A fine Ottocento il veronese Giovanni Morelli li sagomava per cogliere gli autori in fragranza di reato pittorico. Poco più che ventenne Longhi, di nuovo lui, professore nei licei romani, imponeva, più che proporre, la mano dell’«Annunciata» di Palermo come la più bella mai dipinta. Una mano che sonda lo spazio e indica verso di noi così da trasformarci, ipso facto, nell’angelo annunciante (che manca). Ma esistono mani che mal si prestano a fare da natura morta o dimostrazione della diffusione della civiltà prospettica nel secondo Quattrocento.
Vent’anni dopo Antonello, per «Cecilia Gallerani» Leonardo rialza la posta nell’animaletto che la giovane usa come arma bianca mentre la posa sale di tono nella mano, questa sì la più bella di sempre, non foss’altro perché sottilizza e integra i dati del carattere. L’ordine non è vincolante (il ritratto si può leggere dalla mano o subito dall’ermellino che mostra i denti). Ma l’uniformità pacificante tra viso e mani che sostiene la «Gioconda» qui è messa in crisi dallo scatto della bestiola. Un poco in allarme, lo spettatore si congeda da uno degli apici del Rinascimento con la sensazione di aver visto il ritratto dell’ermellino con la dama.
Stefano Causa
Congiungiamo le mani
Per parlare di mani nell’arte niente di meglio che un tratto del Piacere di D’Annunzio dove Andrea Sperelli si mette a ritrarre le mani di donna Maria Bandinelli, prossima e ancora innocente sua vittima. Le disegna le mani e lei si piega fra i brividi alla «lenta, soave e indefinibile tortura» durante la quale non le pare di offrire al disegnatore solo la propria mano nuda ma anche tutta sé stessa, già scossa dalla passione che a breve l’incendierà.
Ma oltre che utile a fare innamorare dame e cavalieri, disegnare, scolpire e dipingere bene le mani è uno degli elementi fondamentali che qualificano un artista che deve iniziare a fare arte figurativa (poi una volta cresciuto potrà fare quello che gli piace ma la grammatica dell’arte come quella della lingua si deve conoscere). Da sempre chi ha frequentato scuole d’arte, licei artistici e accademia di belle arti sa che appena giunto quattordicenne (un moccioso/a o poco più), dal primo anno, gli toccheranno in dote un sacco di gessi noiosissimi da disegnare e ridisegnare all’infinito con dettagli di occhi, mani, nasi, bocche orecchie e piedi. Nelle mattinate invernali, nella luce incerta torinese, in aule enormi e gelide, il professore passava a controllarci questi disegni e trovava sempre da ridire.
Ma mentre occhi nasi e bocca alla fine in qualche modo si raddrizzavano le maledette mani non andavano mai a posto. Sembravano sempre guantini sgonfi, o salsicciotti informi, o oggetti disossati, e allora si partiva con un nuovo foglio bianco a cercare di cavare il sangue da quel gesso dispettoso che raffigurava la mano del Mosè di Michelangelo: provate a schizzarlo e a renderlo bene e poi vedrete. Ci vogliono molti anni per imparare a disegnare e dipingere le mani e d’altra parte in un quadro sono una delle prime cose che si guardano.
Vi immaginate Albrecht Dürer o Leonardo che non sanno disegnare le mani? E qui entra in gioco lo studio dell’anatomia e Leonardo, sappiamo, si dedicò per molto tempo a disossare e scarnificare cadaveri per vedere come erano fatte (anche) le loro mani e le loro braccia e capire quale segreto meccanismo le animasse e le facesse muovere. Anche senza essere Leonardo, il nostro indimenticabile professore di anatomia artistica cercava di istruirci in merito spiegandoci come un osso si collegasse con l’altro e mettendoci davanti scheletri o pezzi di scheletri veri (allora si poteva ancora); ce li faceva toccare e manovrare e quelle mani aguzze e scarnite che erano state vive ed erano diventate ossa giallastre e patinate da centinaia di mani di studenti, comunicavano una sensazione leggermente inquietante. Ma a quindici anni ci si passava sopra in qualsiasi caso.
Ho pensato spesso a quelle mani scheletrite contemplando un celebre quadro di Van Dyck raffigurante Sofonisba Anguissola sul letto di morte della Galleria Sabauda di Torino. Le mani che avevano tanto dipinto e con tanta grazia, che erano scorse veloci sui tasti della spinetta o nello scrivere (come negli autoritratti degli Uffizi e di Capodimonte) e che erano state delineate nei suoi autoritratti con dita flessibili, tornite e croccanti come grissini bianchi (come nell’autoritratto del 1556 del Lancut Museum in Polonia) erano ora rattrappite e spolpate, con le unghie lunghe dei vecchi e dei morti, già preda della tomba. Con quelle mani adunche, conserte e serrate sul rosario Sofonisba era stata sepolta nel 1625 nella chiesa di san Giorgio dei Genovesi a Palermo, suo ultimo approdo.
Ma le mani non sono fatte per congiungersi in una muta preghiera solo sul letto di morte, anzi. Principalmente si uniscono per amore, e poi anche per amicizia e per protezione. Il gesto della Dextrarum iunctio con cui gli antichi romani si sposavano noi lo abbiamo ereditato nel matrimonio cristiano. L’anello rinvenuto a Firenze nella tomba di Eleonora di Toledo, dono di fidanzamento di Cosimo de Medici fu così caro alla duchessa (Bronzino lo dipinse al dito di Eleonora nel ritratto della galleria Nazionale di Praga ) da seguirla nella tomba. Vi si vede fra le cornucopie, simbolo di buon augurio, un cratere su cui poggia un pappagallo che sovrasta proprio la dextrarum iunctio, simbolo di eterno amore che, in questo caso, continuava oltre la morte.
Mani fiorentine così leggiadre che si sfiorano si ritrovano dipinte ne «Il Matrimonio di Maria», di Giovanni Battista Bizelli (1550 ca-1607), mentre un cameo con la dextrarum iunctio sta sulla spalla di una giovane sposa di casa Acciaioli nella «Presentazione di Maria al tempio» di Giovanni Maria Butteri, Due quadri, del 1585, che si trovano a Reano (Torino) divisi fra la chiesa parrocchiale e la cappella della Pietà e che facevano parte anticamente della splendida cappella di Pietrafitta di san Gimignano.
Nel Daniele Cortis di Antonio Fogazzaro l’amore di Daniele ed Elena giunge all’addio in un giardino dove «una colonna di marmo antico, portata dalle terme di Caracalla reca sulla base due mani di rilievo che si stringono e le seguenti parole: “HYEME ET AESTATE ET PROPE ET PROCUL USQUE DUM VIVAM ET ULTRA”. (D'inverno e d'estate, da presso e da lontano, fin ch’io viva e più in là)». Qui le mani giunte erano insieme promessa e speranza di una felicità non realizzabile sulla terra.
[Arabella Cifani]
«Pas de Deux»
Strumenti umani come mani, piedi, occhi, peni e passere, dipinti dagli artisti e raccontati da Stefano (Causa) e Arabella (Cifani)
Le mani
I piedi
Le labbra
La passerina
Le tette
Gli occhi
I membri maschili
I nasi
I sederi
Le orecchie
I denti
I capelli
Le schiene

Le mani nel ritratto di «Cecilia Gallerani» (1488-90) di Leonardo da Vinci

La mano di Miles Davis fotografata da Irving Penn

«Madonna col Bambino e Sant’Anna» (1424-25) di Masaccio e Masolino
Altri articoli dell'autore
Strumenti umani come mani, piedi, occhi, peni e passere, dipinti dagli artisti e raccontati da Stefano (Causa) e Arabella (Cifani)
Strumenti umani come mani, piedi, occhi, peni e passere, dipinti dagli artisti e raccontati da Stefano (Causa) e Arabella (Cifani)
Strumenti umani come mani, piedi, occhi, peni e passere, dipinti dagli artisti e raccontati da Stefano (Causa) e Arabella (Cifani)
Strumenti umani come mani, piedi, occhi, peni e passere, dipinti dagli artisti e raccontati da Stefano (Causa) e Arabella (Cifani)