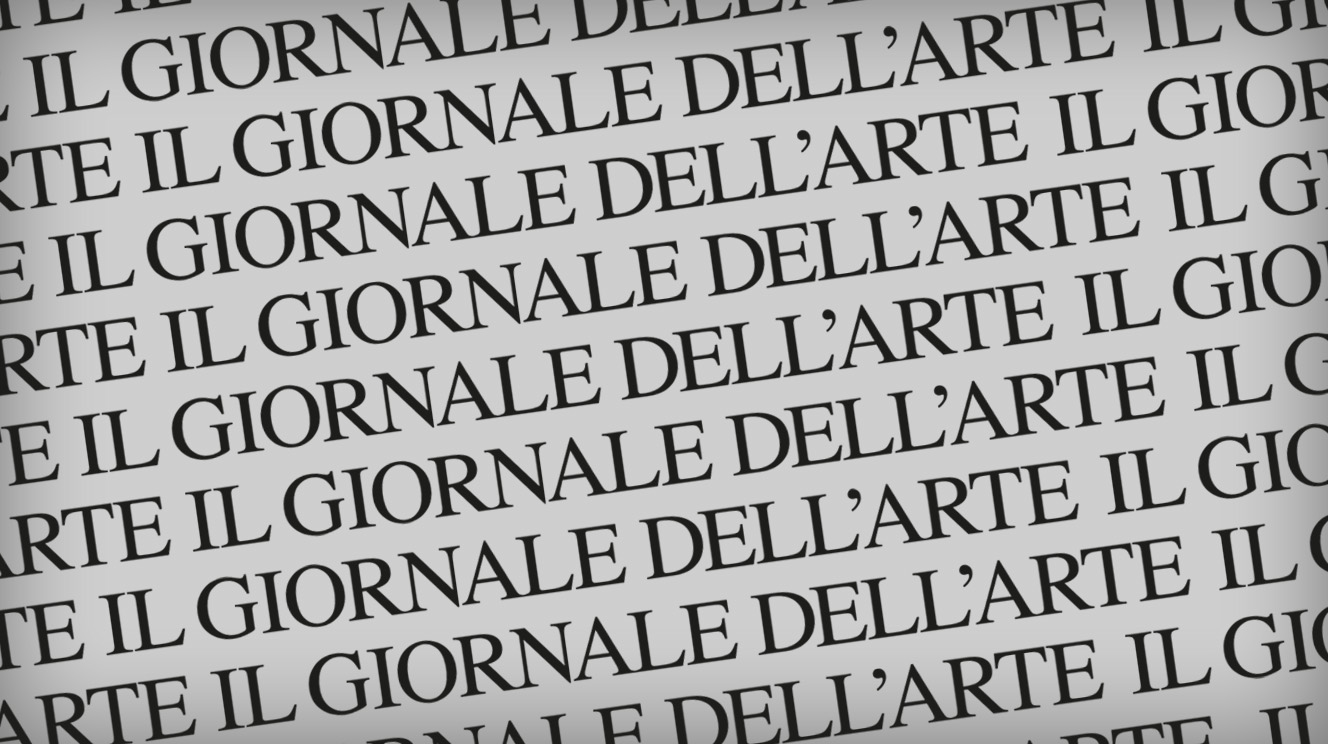Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Massimo Melotti
Leggi i suoi articoliNel Salon del 1865 Edouard Manet, artista che già aveva suscitato entusiasmi e critiche, espone «Olympia», nudo di donna che si rifà alla Venere di Urbino di Tiziano, rivisitata in chiave moderna, tanto moderna che ben presto si passò dalle critiche a uno scandalo senza precedenti. Una vera e propria collera collettiva accomuna gli addetti ai lavori al pubblico che si accalca di fronte alla tela. «Un quadro, scrive addirittura “L’Epoque”, che potrebbe scatenare un’insurrezione». La critica concorde condanna. Scrive Jules Claretie: «Cos’è mai questa odalisca dal ventre giallo, ignobile modello raccattato non so dove, che vorrebbe rappresentare Olympia». E il «Constitutionnel»: «Riesce a suscitare risate quasi scandalose che assembrano i visitatori del Salon davanti a questa grottesca creatura». E ancora: «Non si è mai visto uno spettacolo simile, e di un effetto più cinico: questa Olympia, sorta di gorilla femmina…» tuona il «Grand Journal», mentre l’autorevole critico Paul de Saint-Victor scrive sulla «Presse»: «La folla si accalca come all’obitorio di fronte all’Olympia infrollita di Manet. L’arte scesa così in basso non merita neppure che la si biasimi».
Ma che cosa c’era di così scandaloso da suscitare reazioni a dir poco inusitate per un’opera d’arte? Non il modellato inesistente o le tonalità sporche o ancora i chiaroscuri messi in evidenza da «striature di lucido da scarpe più o meno larghe» scatenarono l’ira e il dileggio dei parigini, ma qualcosa di più profondo, di ancestrale. Qualcosa che andava a toccare valori consolidati su cui si basava la struttura di un mondo che stava velocemente cambiando. Manet, con le sue opere suscita scandalo non tanto per l’irregolarità estetica quanto per ciò che le sue opere, soprattutto «Le Déjeuner sur l’herbe» e definitivamente l’«Olympia», svelano. L’olimpico mondo degli dei e dei reali era finito, spazzato via non solo dalle rivoluzioni ma soprattutto dal treno e dalla fotografia. La manifattura era diventata fabbrica ma ancora la borghesia si abbeverava ai miti del Bello e del Sacro. Ancor dopo Ingres e Delacroix, tra Neoclassicismo e Romanticismo, ancor dopo gli umili soggetti di Courbet, la borghesia, divenuta classe dominante, si crogiolava nella bellezza estatica, nelle forme vuote che l’aristocrazia le aveva lasciato. Manet svelava l’abisso, ne stracciava i paramenti aristocratici nei quali ancora si drappeggiava. Non più dee diafane ma le protagoniste del quotidiano «raccattate non si sa dove» che sarebbero andate a nutrire l’immaginario collettivo del nuovo mondo. «Olympia» è il culmine di quel percorso creativo che Manet compie tra incertezze e scandali e che viene riproposto da Abscondita con un testo importante e un po’ dimenticato del 1955 di Georges Bataille nella bella traduzione di Guido Alberti.
Tanto di cappello a Bataille studioso e visionario che parte da basi storiche, dalle testimonianze dell’epoca, dall’analisi psico-estetica dell’eleganza di monsieur Manet, parigino a tutti gli effetti, deliziosamente modesto e spiritoso nei caffè ma pasionario nell’arte, timoroso di creare scandalo proprio nel momento in cui manda all’aria, con le sue opere, l’intero mausoleo di feticci e icone dell’arte e della società. Manet non voleva lo scandalo ma è l’arte stessa, come in tutti i tempi, a provocarlo. Bataille, da sovversivo che guarda all’erotismo, mischiando storia dell’arte e testimonianze del tempo con la lettura del segno, ci guida nella scoperta di uno dei padri dell’arte moderna ma ancor più nell’analisi delle sue principali opere avvertendoci di come queste siano divenute operazioni di destrutturazione e di formazione di una nuova cosmologia. Attesta lo sgombro di figure appartenenti a un apparato segnico e simbolico ormai desueto e la loro sostituzione con la scoperta di nuovi segni che serviranno per la comprensione del nuovo mondo. Bataille del resto, che dell’interdisciplinarietà aveva fatto una bandiera, si trova a suo agio nello scoprire interazioni tra segno pittorico e sguardo del pubblico così da svelare che il segno pittorico più che operazione estetica è un’operazione di decostruzione e ricostruzione del linguaggio. Molteplice nel testo è la varietà di stimoli che viene offerta al lettore: il gusto dell’indagine, i percorsi iniziati e ricchi di svolte. Lo scrittore si muove da antropologo e ancor più come partecipe appassionato che sembra voler scoprire con il lettore non solo lo «scandalo» Manet ma, quasi un anticipo degli studi sull’erotismo, si gusta la libidine della scoperta in sé, del processo di decostruzione, appunto. In tanta dovizia due mancanze: una dell’autore l’altra editoriale. Stupisce che Bataille sottovaluti l’influenza del giapponesismo che in quegli anni a Parigi imperversa come si può vedere in «Portrait d’Emile Zola», ma soprattutto nell’uso delle campiture di colore piatte utilizzate da Manet come in «Le Balcon». La mancanza editoriale è che accanto a un encomiabile e agile apparato storico-iconografico manchi un saggio sul Bataille, curioso della vita e dell’arte. Sarebbe stata la ciliegina sulla torta.
Manet, di Georges Bataille, trad. di Guido Alberti,
128 pp., Abscondita,
Milano 2013, € 13,00
Altri articoli dell'autore
Alessandro Bergonzoni: «Chi vede le mie opere può entrare in un altro stato di consapevolezza e percezione»
Chen Zhen ci fa capire con la forza dell’arte quanto il mondo stia cambiando
Per lui illustrare libri significava anche l’inizio di una seconda vita
Da Michela Rizzo e nello Spazio Cosmo la collaborazione tra il sound artist e l'artista visivo