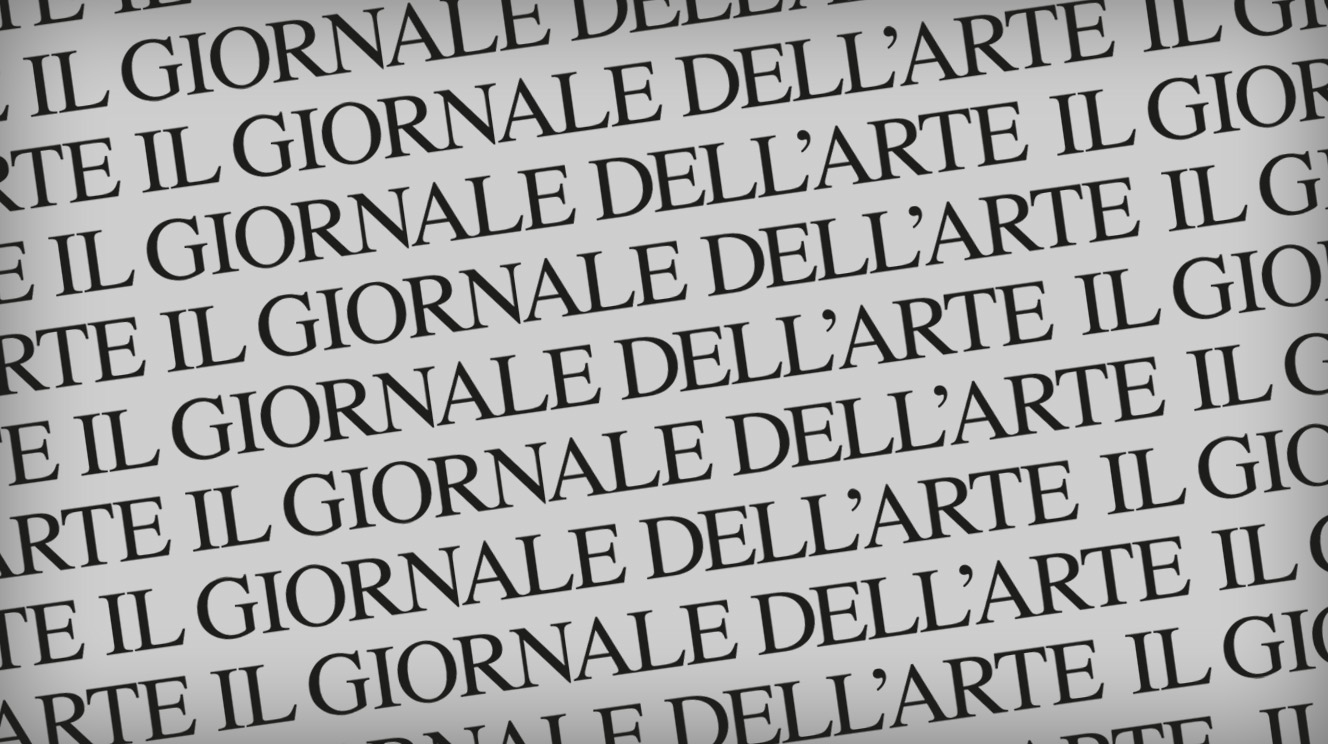Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Marzia Minore
Leggi i suoi articoliSiena. Dal famoso articolo di Brandi del 1968, che sollecitava il recupero dell’antico Ospedale come bene culturale, parlare di Santa Maria della Scala (Sms) significa parlare dell’identità stessa di Siena, poiché il monumento è stato sempre al centro del dibattito su patrimonio, cultura, sviluppo nella città toscana. Nel 2012 una crisi senza precedenti (il commissariamento del Comune, le vicende della Banca e della Fondazione Monte dei Paschi...) ha investito anche il complesso, di proprietà e gestione comunale, con il rischio della chiusura, poi con la riduzione dell’orario e dei servizi. Alla soglia delle elezioni amministrative (26-27 maggio 2013), il suo futuro è incerto, mentre la città che si candida a Capitale europea della Cultura 2019 soffre il ridimensionamento del suo principale finanziatore.
Santa Maria della Scala, tra i più antichi ospedali medievali in Europa, è una città nella città. Nato per l’accoglienza di poveri e pellegrini sulla via Francigena, orfanotrofio e luogo di cura, era una cittadella autosufficiente, che ha inglobato nei secoli strade e parti di città, crescendo per aggregazioni successive. Comprende, nei 20mila mq recuperati, oratori, chiese, ambienti monumentali affrescati, musei. La discesa nelle viscere dello Spedale Grande, percorrendo i suoi vari livelli, nei labirinti di cunicoli, è un viaggio nella storia profonda di Siena. La vicenda del suo recupero è un percorso altrettanto accidentato, dove si alternano conquiste e disfatte. Fino al 1996 era ancora un ospedale: davanti agli affreschi quattrocenteschi del Pellegrinaio erano i letti dei degenti. Enrico Toti, conservatore al Sms dagli inizi fino al 2012, ricorda: «I primi ambienti aprirono nel ’95 mentre la struttura sanitaria era ancora in funzione. C’era sinergia, un clima di entusiasmo, professionalità alte. Mentre procedeva il cantiere i locali venivano progressivamente restituiti al pubblico. Tutto il patrimonio artistico dell’antico ospedale fu riunito, catalogato, messo in sicurezza». Assessore alla cultura era Omar Calabrese, poi rettore del complesso. L’idea di un bene restituito alla città come luogo di conservazione, ricerca, laboratorio della vita culturale, era stata nutrita dallo stesso Calabrese, da Brandi e Previtali.
Seguendo il progetto dell’architetto Guido Canali, il recupero si è sviluppato per tappe, conquistando spazi contestualmente alle indagini storiche e archeologiche. Dall’esposizione del Tesoro delle reliquie medievali all’apertura del Museo Archeologico, al trasferimento della Biblioteca e della Fototeca Briganti, all’allestimento dei marmi di Jacopo della Quercia per Fonte Gaia. Fino alle campagne di restauro degli anni recenti: ultimi gli affreschi della Sacrestia Vecchia (2010-11). Il complesso ospita anche il Museo d’arte per Bambini, la Mediateca, 6mila mq di spazi per mostre e convegni. Oggi circa metà della superficie dell’Ospedale è stata recuperata. Con un’identità polivalente, una vocazione mai pienamente realizzata, oscillante tra valorizzazione del patrimonio, produzione di ricerca e cultura, eventi. Con progetti inattuati: il trasferimento della Pinacoteca Nazionale, che unita al patrimonio del Sms costituirebbe il più grande museo di fondi oro nel mondo (già oggetto di un protocollo di intesa ai tempi del ministro Giovanna Melandri) rimane sulla carta.
L’ultimo anno è stato forse il più buio. A giugno 2012 il Comune è commissariato, proprio mentre i finanziamenti del Monte dei Paschi alla città si riducono drasticamente. L’affidamento dei servizi museali (sorveglianza, didattica e affini) scade, non è emesso il nuovo bando di gara. La chiusura sembra inevitabile. Ad agosto i media ne parlano, cittadini e studiosi si mobilitano, si crea il Comitato Salviamo Santa Maria della Scala. La chiusura è scongiurata solo grazie a finanziamenti ad hoc di Mps e della Regione Toscana (che ha destinato al complesso 400mila euro da erogare in più tranche). Si proroga l’affidamento alle cooperative, ma il monte ore è limitato. Dei 16 dipendenti di Zelig (una cooperativa di servizi), 13 vanno in cassa integrazione, gli operatori didattici di Elicona (altro ente cooperativo) lavorano a singhiozzo. Da settembre sono aperte, generalmente, solo le sale monumentali del piano di accesso con due giorni di chiusura a settimana. Si naviga a vista, senza una dirigenza politica (mancano Sindaco e assessori), con fondi scarsi.
La crisi è esplosa, ma era nell’aria. Evidenzia problemi strutturali. Un esiguo personale garantisce, con un lavoro quotidiano e invisibile, la sopravvivenza di una struttura di enorme estensione e complessità. Si è riusciti, quest’anno, a organizzare aperture speciali integrali per le feste primaverili, a rinnovare i «percorsi dell’acqua», a garantire l’attività di base con le scuole e le mostre del Museo per Bambini. Ma è possibile che per un complesso del genere non si possa avere personale scientifico con una stabilità contrattuale? Che non esistano figure permanenti come il direttore scientifico o il conservatore? I pochi dipendenti comunali con funzioni culturali sono tutti assunti a tempo determinato, a differenza degli amministrativi. L’incarico di conservatore nel 2012 non è stato rinnovato, non c’è più un restauratore. Dal 2003 si è formato un servizio educativo, 4 storici dell’arte e archeologi, collaboratori della cooperativa affidataria. Professionalità preziose per la costruzione del rapporto tra museo e città, hanno realizzato percorsi per tutte le età e progetti per scuole come «Apprendisti ciceroni» con il Fai. Ma non c’è certezza di continuità. La nuova gara, che comprende tutti i servizi museali esternalizzati, è stata finalmente bandita, e aggiudicata il 12 aprile scorso. Il vincitore (un raggruppamento temporaneo di imprese con a capo Opera Laboratori Fiorentini spa) deve rilevare per legge il personale di Zelig, assunto a tempo indeterminato. Diverso il discorso per gli operatori didattici, per cui il reintegro, pur probabile, è discrezionale. L’unico criterio adottato nella gara è stato quello del prezzo più basso. Come dire, conta solo risparmiare, non competenze ed esperienza.
Connesso al problema del personale, quello della gestione. Concordano tutti: il passaggio dalla forma dell’istituzione alla gestione diretta del Comune, nel 2007, è stato un errore. Con l’istituzione c’era maggiore autonomia e un’équipe dedicata: rettore, conservatore, consiglio di amministrazione, comitato scientifico. Ora il Sms è gestito come un ufficio del Comune, subordinato alla Direzione Cultura (che si occupa anche di sport, turismo e del Palio!). Nel febbraio 2012 era stato approvato lo statuto di una Fondazione, mai avviata per la caduta della giunta Ceccuzzi. D’altronde, si può discutere se quel modello fosse la soluzione: nello statuto, molto contestato, mancava ad esempio la figura del direttore scientifico.
Altro nodo cruciale: la dipendenza, di fatto, da un finanziatore quasi esclusivo, il Monte dei Paschi, ha implicato a lungo termine la non sostenibilità. Caso esemplare le mostre, finanziate interamente da Banca e/o Fondazione. Nel 2005 nasce Vernice, società strumentale della Fondazione Monte dei Paschi e principale soggetto organizzatore di mostre, alcune di qualità, altre meno significative. «Abbiamo sempre cercato di mantenere il filo tematico del rapporto con il territorio, dice Laura Bonelli, storico dell’arte per Vernice Progetti Culturali srlu. La mostra più riuscita è stata forse “Da Jacopo della Quercia a Donatello. Le arti a Siena nel primo Rinascimento” (2010), anche per le collaborazioni internazionali e i restauri realizzati». Ed è stata anche l’ultima di ampio respiro. La stagione dei grandi eventi è finita: mancano le risorse. A Vernice non c’è più consiglio di amministrazione, l’amministratore unico è prestato dalla Fondazione. La società oggi cerca soggetti terzi in operazioni di fundraising e si impegna nell’erogazione di «servizi non monetari», ad esempio consulenze specialistiche, per il territorio.
Guardando avanti, ci si chiede quale debba essere la vocazione del Sms, la sua identità futura. Per Marco Pierini (già direttore del Centro di Arte contemporanea a Palazzo delle Papesse e poi di Sms Contemporanea, ora direttore della Galleria Civica di Modena) è essenziale rafforzare il progetto museale: «Si è pensato solo alle mostre. Rispetto agli studi e alle indagini si è fatto tanto, ma l’Ospedale è un contenitore vuoto. Manca un progetto complessivo di museo: non c’è la Pinacoteca, non c’è il racconto della storia sanitaria del Medioevo e dell’età moderna. Gli spazi sono stati spesso recuperati senza pensare alla loro funzione». Per Anna Carli, già rettore del Sms, ora coordinatrice dell’unità operativa per Siena candidata a Capitale della Cultura 2019, «l’Ospedale sarà il luogo di eccellenza dei tanti progetti per Siena 2019. Il punto è ritrovare una progettualità forte, che valorizzi l’identità storica del bene, ma lo proietti anche nella contemporaneità. Il problema è la visione: davanti a un progetto d’eccellenza le fonti di finanziamento si trovano. E poi si deve attingere alle competenze del territorio a partire dall’Università, con cui ci sono già state collaborazioni, ad esempio per i restauri degli affreschi della Cappella del Manto, per cui è stata realizzata una nuova tecnologia laser». Pier Luigi Sacco, direttore di candidatura per Siena 2019, lancia idee guida, che si potranno tradurre in una progettazione più dettagliata nelle fasi successive. Per Sacco valorizzazione dell’identità storica e innovazione si uniscono: «Ricostruire la vocazione originaria, uno spazio di cura, diventa attuale nella prospettiva dei benefici anche di salute portati dalla cultura, su cui ci sono diversi studi. Le modalità passive di fruizione museale non funzionano più. Si devono studiare, anche in connessione con il web 2.0, soluzioni innovative: attività fondate sulla partecipazione, spazi laboratoriali dove le persone producono contenuti». È ancora presto per dire se Siena 2019 sarà un’occasione di ripresa per la città. Nell’attesa, gli intonaci nella sala del Passeggio continuano a cadere senza i soldi per intervenire e molte persone che hanno lavorato al Sms si chiedono quale sarà il loro futuro.

Il Pellegrinaio all’interno del complesso museale Santa Maria della Scala. Foto Joachim Bednorz
Altri articoli dell'autore
Bando aperto fino al 21 settembre per Santa Maria della Scala