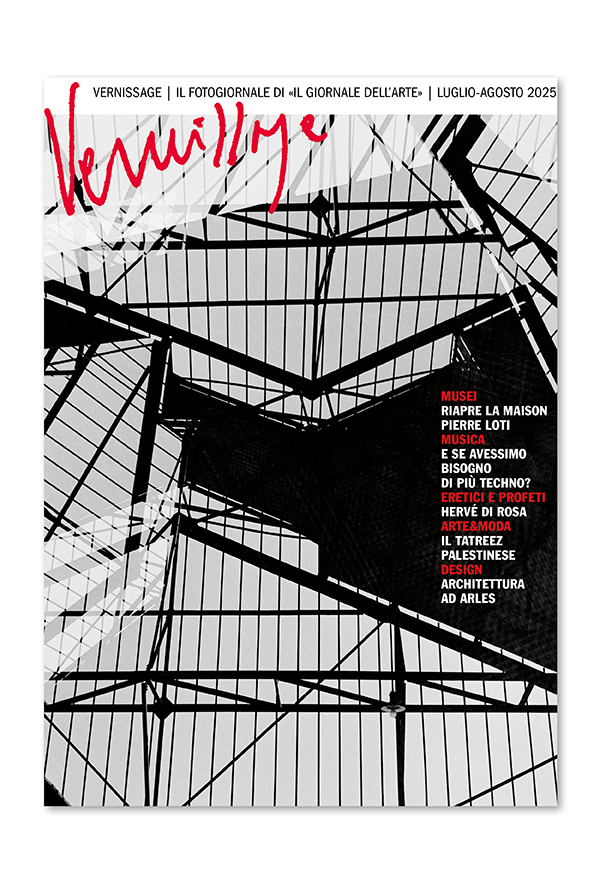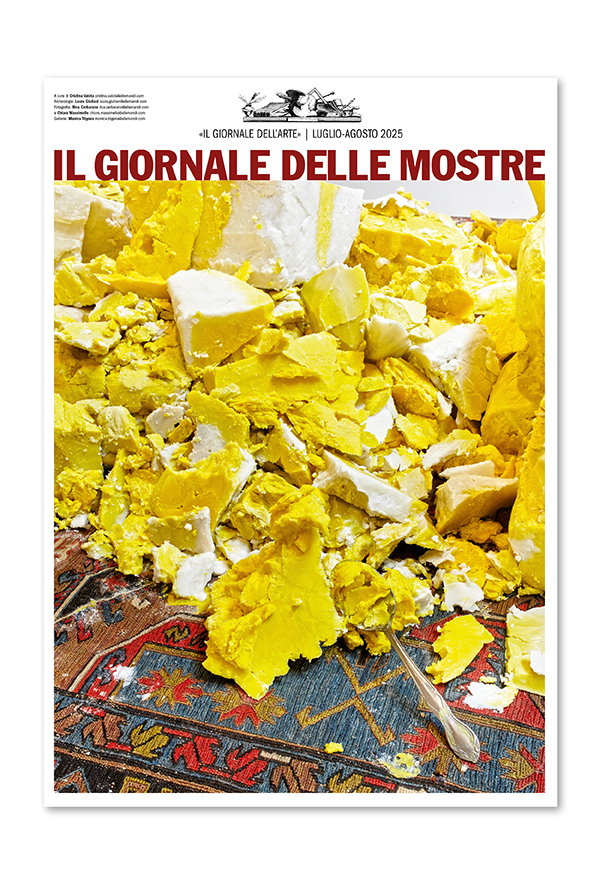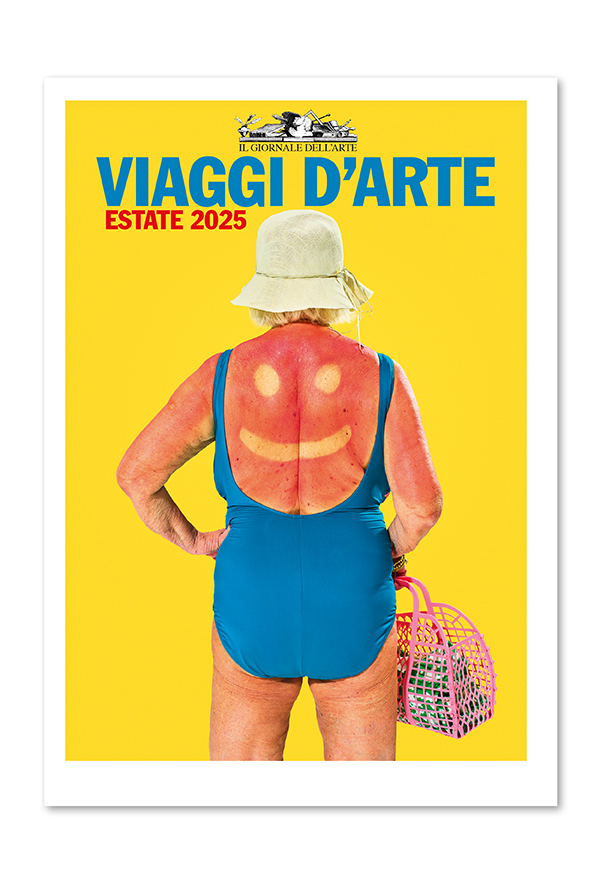Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Matteo Bergamini
Leggi i suoi articoliHa aperto lo scorso 27 marzo a Porto Alegre, ultima metropoli brasiliana del sud del Paese, quasi al confine con l’Uruguay, la 14ma Biennale del Mercosul (chiamata così per rappresentare, originariamente, tutti i Paesi facenti parte del blocco economico, Ndr) che oggi si espande idealmente fino agli Stati Uniti, alla Cina e alla Corea, come del resto fa l’export brasiliano, portando per la prima volta in America Latina molti dei 77 artisti partecipanti, per un totale di oltre 60 opere commissionate per l’occasione divise in 18 spazi diversissimi per storia e funzione, dal centro alla periferia della città gaúcha.
Tra le varie personalità che stanno dietro le quinte della manifestazione c’è Carmen Ferrão, imprenditrice e attualmente ceo del gruppo Lins Ferrão, del quale fanno parte i brand di moda Pompéia e Gang, attuale presidente della Biennale del Mercosul, incarico che lascerà prossimamente dopo aver guidato le ultime due complesse edizioni: quella del 2022, preparata sotto lo spettro della pandemia, e l’attuale «Estalo», aperta fino al primo giugno, che si sarebbe dovuta aprire lo scorso settembre ma che è stata rimandata di sei mesi a causa dell’inondazione che ha colpito Porto Alegre nel maggio dello scorso anno.
«Organizzare questa 14ma biennale è stato ancora più complesso rispetto a quella precedente in epoca Covid: abbiamo dovuto fare i conti con una città devastata, con artisti che hanno perso la casa o l’atelier, con l’allagamento dei musei e di tutti gli spazi del centro storico... Una sfida emotiva: mentre si ricostruivano le case e Porto Alegre cercava di tornare alla sua vita, si producevano le opere che oggi sono in mostra e il titolo, “Estalo”, che era già stato scelto dai curatori, ha guadagnato ancora più forza», spiega la presidente.

Backstage dell’intervento di Freddy Mamami, Fondazione Ecarta. Foto: Thiele Elissa
Guidata da Raphael Fonseca (1988, curatore del settore Arte Latino-americana al Denver Art Museum, in Colorado, e già entrato per due anni consecutivi nella Power 100 di ArtReview) con i curatori aggiunti Thiago Sant’Ana (1990) e Yina Jiménez Suriel (1994), «Estalo» è una parola traducibile in italiano con espressioni come «scintilla» (nel senso creativo del termine), «scoppio» (metaforicamente usato per un processo trasformativo), «schiocco di dita» per dare il «la» a un’azione. E come ha ricordato il team, in ogni spazio si incontra un «estalo» differente, tanto che tutte le sedi sono state rinominate con un sottotitolo poetico: «Le luci si spegnono ma la festa non finisce»; «Lo scorrere dei granelli di sabbia nel fondo di una clessidra»; «Il colore che cade dal cielo»; «Il dilatarsi delle pupille» e così via. Un modo ulteriore per sottolineare le differenze di una mostra che Porto Alegre ha aspettato come lo scoccare ufficiale della propria rinascita, dopo la tragedia dello scorso anno, costata la vita a più di 180 cittadini e che ne aveva lasciato senza casa oltre 400mila.
«È stato uno sforzo enorme per gli artisti riorganizzarsi per il 2025, ma tutto ha preso una grinta, un’energia insperata: sembra che ognuno abbia voluto fare ancora meglio», continua Ferrão, che durante il suo mandato ha cercato di avvicinare i pubblici, comprendendo chi non ha dimestichezza alcuna con i concetti di «biennale» e «arte contemporanea», inspirandosi molto alle esperienze veneziane, spezzando una lancia per gli omologhi Roberto Cicutto e per l’attuale presidente, Pietrangelo Buttafuoco. Tra le varie idee per il futuro, infatti, c’è anche la necessità di creare una sede permanente della Fondazione Biennale, proprio com’è la nostrana Ca’ Giustinian, per dare la possibilità non solo di fare mostre o ospitare residenze, ma di avere un luogo di formazione continua.
E poi c’è la gratuità di tutte le sedi, che qui non è un differenziale da poco: «Questa è una caratteristica della nostra “Mercosul”, ma ciò significa anche un grande lavoro di fundraising che ha incluso anche la nascita dell’associazione degli “Amici della Biennale”, un vero programma di membership dove ognuno può donare quanto vuole, per portare una possibilità di esistenza permanente alla manifestazione, per farla vivere anche negli anni in cui non è prevista», aggiunge Ferrão. Parlando di cifre in chiaro, la 14ma biennale ha allocato tra fondi pubblici (come la brasiliana Legge Rouanet di incentivo culturale, Ndr) e il sostegno di grandi imprese e istituti bancari dello stato di Rio Grande do Sul, Petrobras e Banrisul, oltre a vari sponsor privati come la catena di abbigliamento Renner e le acciaierie Gendau, 12 milioni di reais (poco meno di due milioni di euro, Ndr): una sfida enorme per coprire produzione, logistica, alloggi, oltre alla parte del programma pubblico ed educativo, che in Brasile è un tema fortissimo sul quale ogni istituzione lavora insistentemente e instancabilmente.

Berenice Olmedo, «Farol Santander». Foto: Thiele Elissa
Ma come è andata l’apertura di questa «Estalo»? Quello che abbiamo osservato, oltre a una perfetta sintonia tra i cittadini e la biennale, è stato proprio l’assalto del pubblico: nel primo fine settimana 6mila persone sono entrate solo al Gasometro, uno dei più iconici spazi cittadini coinvolti dalla biennale, riaperto dopo 10 anni di molte promesse e altrettanti restauri. «Nella tredicesima edizione, la prima che avevo presieduto, abbiamo avuto 860mila visitatori, ma avevamo meno location, per cui quest’anno vorremmo lanciare la previsione di un milioni di visitatori, rimarca la presidente, che ribadisce anche la volontà di uscire dal centro e creare interventi in aree più periferiche per permettere ai cittadini meno avvantaggiati di fruire della mostra e, chissà, di essere incuriositi a esplorare anche le sedi del centro. Questa volontà di espansione va oltre gli artisti, oltre le opere. Sono certa che esista un lato formativo per un bambino, un adolescente, nel visitare una mostra; la cultura amplia gli orizzonti e può davvero cambiare la vita. Ne abbiamo avuto testimonianza diretta con molte delle curatrici e curatori che sono passati da Porto Alegre, in principio formatisi nella mediazione culturale».
Non è un caso che del dipartimento educativo diretto da Andréa Hygino e Michele Ziegt facciano parte decine e decine di mediatori, sparsi in tutti gli spazi. Non solo: appartiene alla biennale anche un programma di eventi pubblici gratuiti, curato da Anna Mattos e Marina Feldens, che prevede una quantità esorbitante di incontri, conversazioni, dibattiti, attivazioni di opere, performance: «Perché è esattamente questo che volevamo: una biennale che parlasse di vita e trasformazione, senza utilizzare la tragedia vissuta lo scorso anno come materiale dell’arte. In fin dei conti il mondo è caotico, il futuro è incognito. Vogliamo veramente che l’arte rincari la dose rispetto ai problemi? Non è meglio cercare soluzioni, dialoghi, bellezza?», conclude Carmen Ferrão.
E questa edizione, su che cosa ha puntato lo sguardo? Sicuramente su alcuni grandi autori che hanno fatto da apripista alle nuove generazioni per quanto riguarda poetiche e audacia: Nam June Paik e Heitor dos Prazeres, riuniti al Margs (Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul); i giovani ma già internazionalmente riconosciuti Gabriel Chaile (Argentina, 1985) e Amol K. Patil (India, 1987) rispettivamente esposti alla 59ma Biennale, «Il latte dei sogni», e all’ultima dOCUMENTA di Kassel, nel 2022; il grande pittore brasiliano Iberê Camargo (1914-94), nella cui fondazione, unica opera architettonica dell’architetto portoghese Álvaro Siza in America Latina, che gli valse il Leone d’Oro alla Biennale di Venezia del 2002, sono riuniti una serie di artisti brasiliani contemporanei tra i più interessanti del panorama attuale: Rodrigo Cass, Darks Miranda, Letícia Lopes o Zé Carlos Garcia. E poi gli interventi urbani: il grande billboard di Felipe Weeck (1996) nel quartiere di Restinga o la facciata della Fondazione Ecarta dipinto dal boliviano Freddy Mamami (1971) con i motivi tipici del pop latino mescolati dalla tradizione andina: una reminescenza Makhu della Biennale di Pedrosa, certo, ma stavolta realmente ai bordi di una delle arterie più trafficate di Porto Alegre. Chissà che a qualcuno, passando di lì, non «estali» un lampo di curiosità.

L’intervento di Christine Sun Kim sulla Casa de Cultura Mario Quintana. Foto: Thiele Elissa