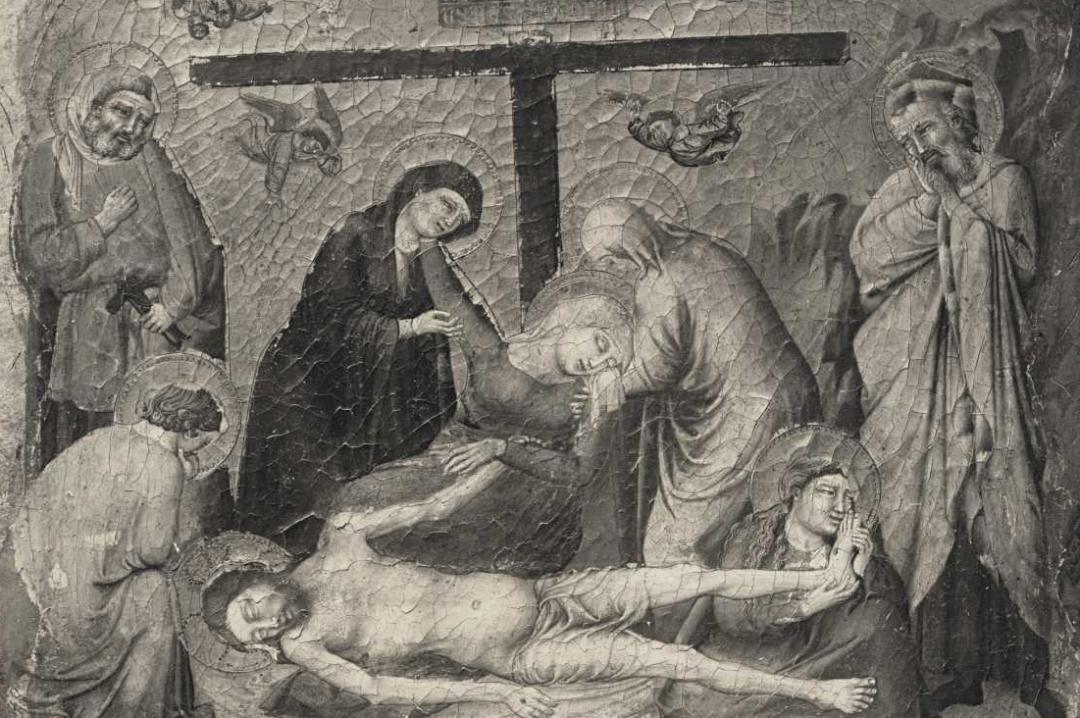Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Giorgio Bonsanti
Leggi i suoi articoliSi fa di necessità virtù, e il Salone del Restauro di Firenze quest’anno ha avuto luogo per via telematica (14-16 ottobre). Fra le iniziative, un convegno promosso dal chimico Mauro Matteini sui consolidamenti inorganici applicati a materiali lapidei carbonatici (in altre parole, i marmi) nel corso del quale sono stati presentati gli esiti di interventi recenti. Non diffidate dell’argomento: è molto importante e concettualmente accessibile.
Si tratta di esplorare le possibilità di ottenere un consolidamento efficace mediante applicazioni di sostanze chimicamente compatibili, tali da offrire risultati utili di carattere chimico, fisico, meccanico, estetico, e da rispondere a principi basilari come la compatibilità, la ritrattabilità e il minimo intervento. Costituiscono pertanto un’alternativa preferibile nei confronti delle applicazioni di resine, prive di compatibilità e ricche di controindicazioni, così come di prodotti come il silicato di etile, oltretutto valido ma solo per le rocce silicee. Le sostanze inorganiche in parola consistono nell’ossalato di ammonio (AmOx) in funzione eminentemente protettiva, e qui le prime applicazioni risalgono a un quarto di secolo fa; e di diammonio fosfato (Dap) come consolidante, accreditato di un effetto di penetrazione nell’ordine dei 4 mm.
Questa seconda sperimentazione è più recente, sostanzialmente dell’ultimo decennio, ma offre uno strumento importante, anche per la possibilità di applicare il difosfato insieme con l’ossalato, aggiungendo, se del caso, un biocida (tipicamente il cloruro di benzalconio). Nel convegno sono state illustrate le casistiche di Santa Croce di Lecce, delle Cattedrali di Lugano, Genova e Monreale e di San Fermo a Verona. Spendo qualche parola su un altro caso, la facciata del Duomo di Monza. L’intervento, terminato molto recentemente, è stato realizzato dalla ditta Estia di Bastia Umbra nelle persone dei titolari, i coniugi Paolo Pecorelli e Nadia Cavallucci, e di Cinzia Parnigoni, tutti a suo tempo diplomati all’Opificio delle Pietre Dure.
La facciata in questione, ove le analisi moderne hanno identificato ben quattordici pietre diverse, fu realizzata in prima istanza da Matteo da Campione poco dopo la metà del Trecento, ma come la vediamo oggi è il risultato dei restauri dovuti a Luigi Beltrami fra Otto e Novecento. I restauratori hanno proceduto in primo luogo alla rimozione di sostanze indesiderate e alla pulitura dei marmi, poi alle stuccature di riempimento.
Ha fatto seguito l’applicazione consolidante-protettiva ottenuta con l’ossalato e il difosfato di ammonio. Qui è stato inventato un metodo di avanguardia che potrà essere utilmente replicato: poiché l’applicazione manuale su una facciata così ricca di decorazioni sarebbe stato un compito improbo e molto costoso, è stata realizzata un’adesione dell’impacco a spruzzo, con concentrazioni del materiale dapprima minori (impacco più fluido) poi aumentate (più denso). La rimozione dopo i tempi dovuti (fino a ventiquattr’ore circa) è stata realizzata, dopo una leggera spazzolatura, con dispositivi ad aspirazione.
Ho potuto constatare personalmente che sulla facciata del Duomo le superfici risultano assolutamente compatte; del resto, nel caso di erosioni meccaniche future, dovute ad esempio all’azione della pioggia, sono trattamenti che possono essere ripetuti senza controindicazione alcuna. L’interazione fra un chimico esperto come Mauro Matteini e restauratori aperti alle innovazioni ha spalancato nuove vie al restauro delle rocce carbonatiche; è auspicabile che il mondo del restauro prenda atto di questi nuovi strumenti e li sperimenti, anche se i dibattiti e i confronti fra le diverse metodologie rimarranno aperti.

La facciata del Duomo di Monza
Altri articoli dell'autore
Aperto per restauri • Diagnosi sul restauro da restaurare di Giorgio Bonsanti, già professore all’Università di Firenze
Aperto per restauri • A un anno dall’inaugurazione del museo, nella nuova sede di Palazzo Cavalli si è tenuto un convegno rivelatosi occasione interessante e piacevole per presentare un’ampia casistica di interventi conservativi infrequenti
Orietta Rossi Pinelli ripercorre le principali tappe di come sono cambiate le regole dalla Carta di Atene del 1931 ad oggi
Operatività, ricerca e didattica hanno improntato l’attività dell’insigne «ambasciatore» del restauro italiano, per quasi quarant’anni attivo all’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, di cui è stato soprintendente per dieci anni