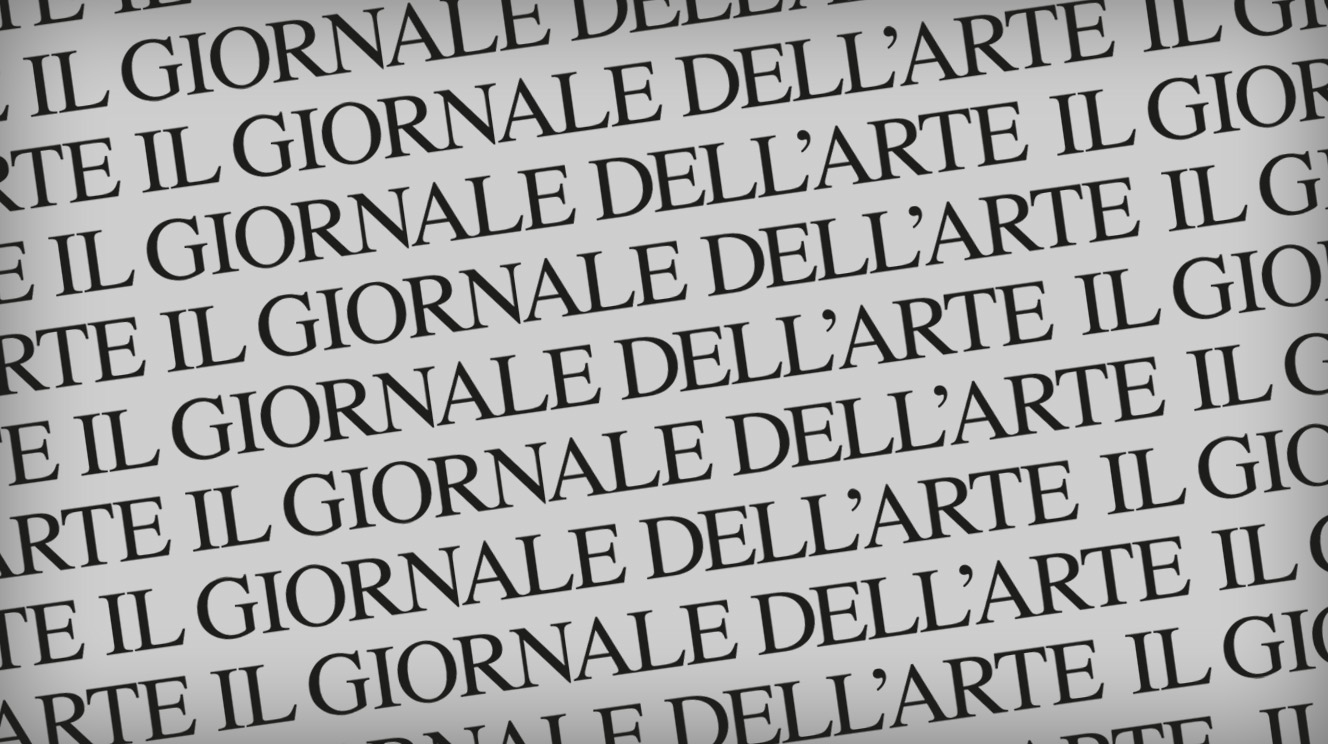Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Massimo Melotti
Leggi i suoi articoliLa città degli anni Duemila sembrava sino a poco fa seguire quell’andamento previsto, e tutto sommato controllato, di luogo in cui le dinamiche di pianificazione urbanistica trovavano, magari tra una speculazione e l’altra, un loro sviluppo. E così parimenti alla globalizzazione finanziaria che elabora dinamiche globali ma scollegate dalla reale economia, lo sviluppo urbanistico delle città, come effetto globalizzante, tendeva a un novello international style che conferisse loro quel carattere «cool» spendibile sul mercato immobiliare e a volte turistico.
Abbiamo visto così vecchie capitali europee cercare di ringiovanirsi come attempate madame con interventi di chirurgia estetica, e proprio come queste sfiorare il ridicolo (ruote giganti da luna park, megasupposte a sfidare i cieli); città del futuro sorgere nel deserto declinando dal nulla una visione della spettacolarizzazione high tech costruita sulla sabbia (in tutti i sensi). E anche caotiche megalopoli africane, sedute sul petrolio, sprofondare nella miseria.
Ma la logica dello sviluppo procede gloriosamente abbinando un’urbanistica sempre più asettica, basata su statistiche e proiezioni, a interventi di pianificazione architettonica in cui il genio dell’archistar pone il suo sigillo di un’estetica dedicata a stupire. A ben vedere tutte con una caratteristica comune ineluttabile: la tendenza a separare i ricchi dai poveri, gli integrati dagli emarginati.
La megalopoli di domani prevista dalla pianificazione urbanistica assegna specifici luoghi abitativi, stabilisce reti di trasporti, determina la dislocazione dei centri di consumo in una sorta di illusoria sistemazione dell’universo-città. Conferisce un ordine di sistemazione in base al quale tutto dovrebbe funzionare, teorizzando e facendo sperare in una urban prosperity.
Sulla carta. In pratica l’urbanistica ha perso o elude la grande sfida di uno sviluppo se non basato sulle risorse disponibili almeno su una corretta valutazione dell’elemento antropologico-sociale presente sul territorio. In parole povere: chi ci vive e con che risorse. Così mentre si teorizzano soluzioni urbanistiche e si celebra il fasto delle futuropoli, vengono ignorati fenomeni di aggregazione e di socializzazione che testimoniano la capacità di cambiamento e di adattamento del tessuto cittadino che si scopre, come segnala Franco La Cecla nel suo saggio Contro l’urbanistica, ricco di risorse culturali e sociali. Il fatto è che ogni città ha un’anima e questa è data dalla somma di quelle dei suoi abitanti.
Parafrasando Shakespeare, «What are cities but people»: le città non sono nient’altro che gente. Ed è stata proprio la gente a ridare un senso a luoghi della città che si credevano ormai morti o soppiantati dalle piazze virtuali del web. Se Facebook ha creato il rafforzarsi della rete di condivisioni, ci sono voluti la presenza e lo scontro fisico di piazza Tahrir per decretare la fine di un regime. Come sottolinea La Cecla, si conferma la centralità dei corpi urbani con gli spazi urbani. «Il diritto di esercitare la propria presenza negli spazi pubblici di una città, un gesto, una pratica che rimette in ballo la fisicità della città e dei suoi cittadini». Così al Cairo come a Gezi Park, a Istanbul come nel centro di Hong Kong.
Smentendo clamorosamente i fautori di una società virtuale in cui i cambiamenti vengono decisi in rete, i cittadini, utilizzando la rete nella sua corretta funzione di connessione tra differenti soggetti, hanno trovato l’arma per far sentire la propria voce nel riappropriarsi degli spazi urbani. Del resto, per chi fosse stato attento a questi fenomeni, le prime dinamiche tra rete e contesto reale si erano già avute agli albori del web con la discesa in piazza nella Corea del Sud di movimenti nati in rete che poi avevano trovato compimento in spazi urbani.
Ma il saggio diviene ancor più interessante quando l’autore ci conduce, con sguardo da antropologo, nei quartieri meno conosciuti permettendoci di scoprire come i tessuti urbani celino modalità di vita ricche di fermenti ma anche di trasformazioni calate dall’alto che lo possono distruggere. Ogni città è una storia. Vi è una grande ricchezza di relazioni sociali negli immensi mercati a cielo aperto di Yojakata a Giava, nell’intrico di stradine dietro ai grattacieli di Fukuoka in Giappone, nella complessità di luoghi e genti di Istanbul. Senza dimenticare la trasformazione di Kuala Lumpur che, nel tentativo di elevarsi a world city, sta barattando il tessuto sociale con il consumismo internazionale, o Tashkent e Minsk appena uscite dalla pianificazione sovietica o Shanghai simbolo del nascente capitalismo socialista, e Milano tra speculazione e «resilient city», ma anche l’urbanità di Ragusa, o Parigi, vecchia signora che alle sfide della multietnicità e della complessità del tessuto cittadino cerca rifugio in un senso di ordine e omologazione.
Oggi le città, nel bene e nel male, sono ancora i luoghi del cambiamento dove sono in ebollizione e dove hanno modo di confrontarsi le idee perché appunto come scriveva Shakespeare la città è fatta di gente.
Altri articoli dell'autore
Alessandro Bergonzoni: «Chi vede le mie opere può entrare in un altro stato di consapevolezza e percezione»
Chen Zhen ci fa capire con la forza dell’arte quanto il mondo stia cambiando
Per lui illustrare libri significava anche l’inizio di una seconda vita
Da Michela Rizzo e nello Spazio Cosmo la collaborazione tra il sound artist e l'artista visivo