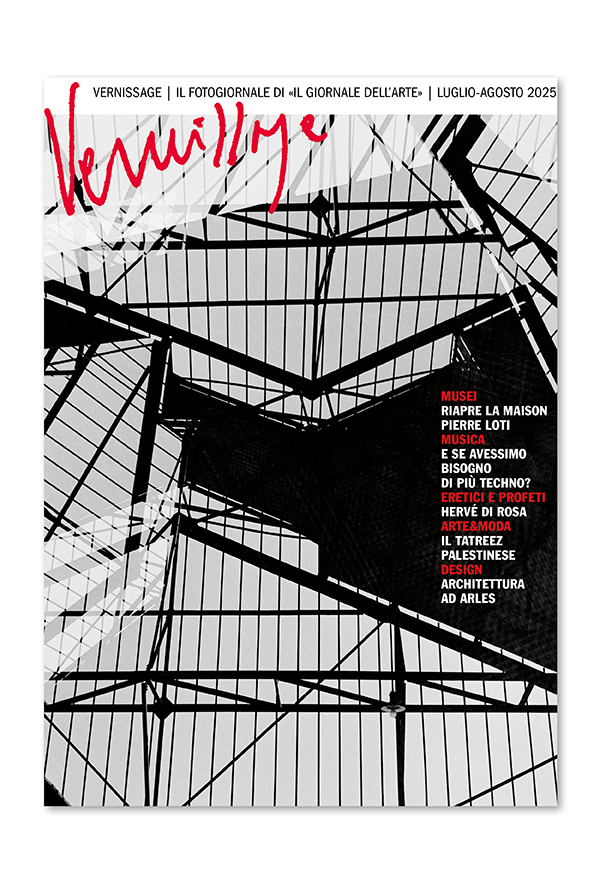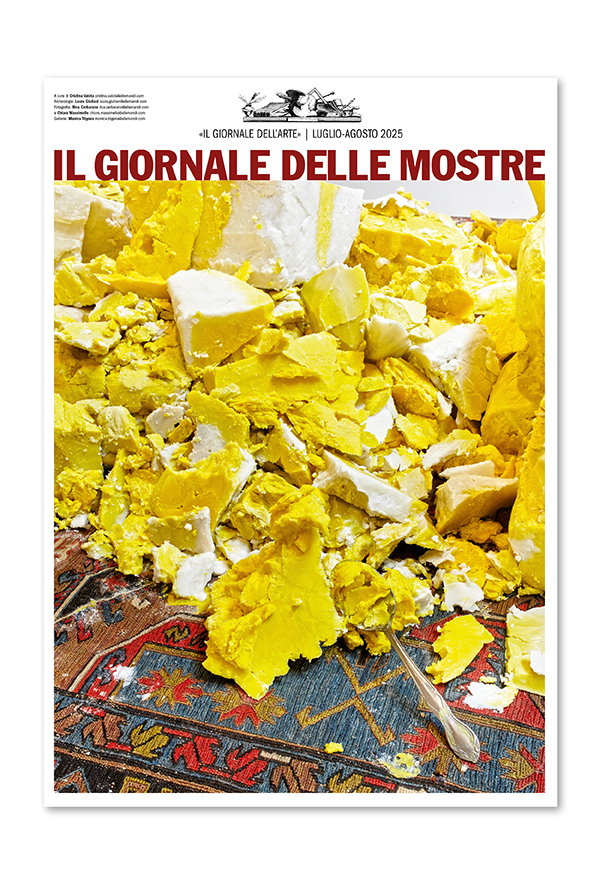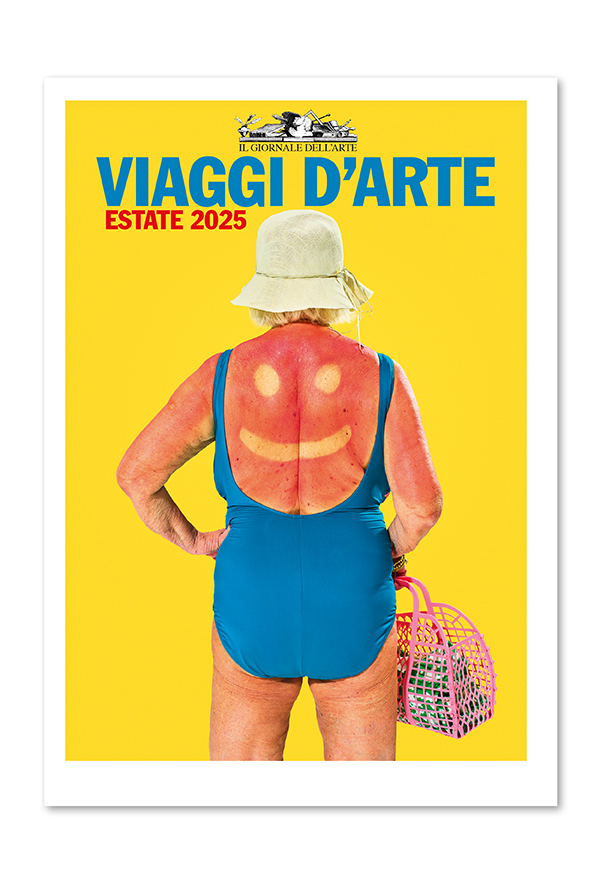Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Giovanni Pellinghelli del Monticello
Leggi i suoi articoliFino al 15 giugno, al Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah-Meis la mostra «Bellissima Ester. Purim, una storia senza tempo» (edizione rivisitata rispetto al Museo Ebraico di Roma, che l'ha ospitata nel 2024) illustra la figura biblica della regina Ester e la festa di Purim (che quest’anno è caduta tra la sera del 13 marzo e il 14) fra storia, tradizione, arte e attualità con opere d’arte rinascimentali, pergamene e rotoli miniati, manufatti storici e installazioni interattive. Curata da Amedeo Spagnoletto, Olga Melasecchi e Marina Caffiero con Sharon Reichel, la mostra presenta la strabiliante vicenda di Ester (in trascrizione più corretta «Esther»), giovane ebrea divenuta moglie del re persiano Assuero, com’è narrato nel Libro di Ester del Tanàkh (versione ebraica ortodossa dell’Antico Testamento, detta «Bibbia ebraica»). Assuero è il nome del re marito di Ester che governava «dall’India fino all’Etiopia, su centoventisette province» (è l’Impero Achemenide) e in lui gli studiosi riconoscono dal XIX secolo lo Shahan Shah (re dei re) Serse I (518-465 a.C.). Storicamente i dinasti achemenidi si sposavano nella stessa famiglia o nell’aristocrazia persiana e appare quindi improbabile una regina di stirpe ebrea: la moglie «storica» di Serse fu Amestris, nel Libro di Ester chiamata Vashti e ripudiata dallo sposo nel 485 a.C. per il rifiuto di esibirsi nuda a un banchetto per mostrare la sua bellezza a gloria del re. Assuero sposò poi Hadasah, fanciulla giudea della tribù di Benyamîn che alle nozze assunse il nome Esther. Da regina, con la sua bellezza e pietas, Ester sventò il genocidio del suo popolo, ordito dal vizir Haman, rivelando allo sposo la propria origine giudea. Da ciò deriva la festa di Purim (letteralmente, «dadi», poiché, nella Bibbia, Haman lanciò i dadi per decidere la data dello sterminio degli Ebrei).

Filippino Lippi, «Vashti lascia il palazzo reale, Italia», 1475 ca, Firenze, Museo Horne
Lo studioso Robert D. Wilson (1856-1930) propose l’identificazione fra Amestris, la biblica Vashti e la stessa Ester. Quale che sia la realtà storica di Ester, la sua è una vicenda di coraggio celebrata da secoli con la Festa di Purim che onora la donna e il suo ruolo sempre cruciale nelle sorti del popolo ebraico. La mostra è suddivisa in quattro sezioni per altrettanti temi fra loro intersecati e, spiega Rav Amedeo Spagnoletto, direttore del Meis, «parte dalla figura di Ester e la sua fortuna nella pittura rinascimentale; spiega la festa di Purim con precetti, costumi e tradizioni e i Purim shenì, commemorazioni di altri eventi in cui gli Ebrei scamparono miracolosamente al pericolo; e dà infine la lettura contemporanea e interattiva della festa con installazioni e le illustrazioni di Laura Guglielmo». Grazie a prestiti italiani ed esteri, la mostra raccoglie pezzi preziosi a raccontare le tradizioni ebraiche legate a Purim: dalle tempere su tavola rinascimentali «Ester davanti ad Assuero» (1475-80) di Jacopo del Sellaio (Museo di Belle Arti, Budapest) e «Vashti lascia il palazzo reale» (1475 ca) di Filippino Lippi (Museo Horne di Firenze), a «I numeri di Ester» (2023), catalizzatore UV su alluminio di Tobia Ravà. Superba la selezione di meghillat (rotoli miniati) del Libro di Ester fra i quali, rarissimi, il «Meghillat Momigliano» (1640-50) firmato da Shalom d’Italia (XVII secolo), incisione a bulino acquarellata, inchiostro su pergamena (Museo di Arte e Storia Antica Ebraica, Casale Monferrato) o il «Meghillat di Ester», realizzato a Ferrara (1616-17) da Moshe Ben Avraham Pescarol, inchiostro e acquarello su pergamena avvolta su legno (Gerusalemme, Biblioteca Nazionale di Israel), e gli esempi di «Purim shenì» col Purim di Siracusa (1405) o lo «Shabbat dei Terremoti» di Livorno (1742).

Un dettagli di pergamena esposta nella mostra «Bellissima Ester. Purim, una storia senza tempo». Foto © Tim Berezin