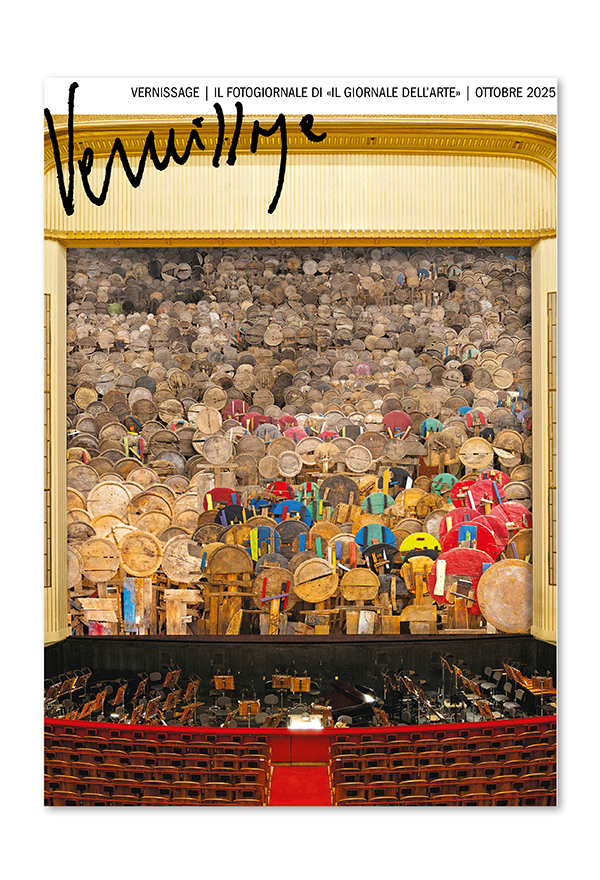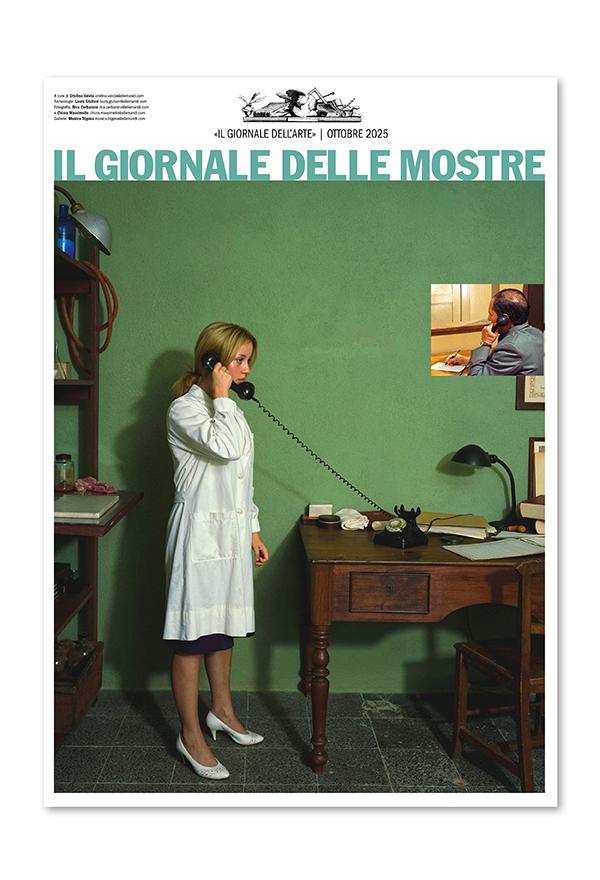Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Giovanni Pellinghelli del Monticello
Leggi i suoi articoliA 350 anni dalla nascita di papa Benedetto XIV (Prospero Lambertini, Bologna, 1675-Roma, 1758), fino al 27 luglio l’Alma Mater Studiorum di Bologna presenta a Palazzo Poggi (Museo di Palazzo Poggi e Biblioteca Universitaria) «Benedetto XIV e Bologna. Arti e scienze nell’Età dei Lumi», mostra che dà conto dell’antesignana opera culturale innovatrice e riformista svolta a metà Settecento dal pontefice bolognese e di forte influenza tanto sulla Chiesa (sua l’invenzione delle «encicliche») quanto sulla città.
Benedetto XIV, arcivescovo di Bologna dal 1731, mantenne il seggio episcopale anche a latere del soglio pontificio (dal 1740, rinunciandovi solo nel 1754) e vi tenne un’illuminata politica pastorale, nella cura non solo della diocesi ma anche delle illustri imprese culturali.
È dunque a lui che Bologna deve il sostegno costante all’Accademia dell’Istituto delle Scienze, istituzione votata alla ricerca sperimentale galileiana, nata nel 1714 dalla fusione di Accademia degli Inquieti, fondata a Bologna nel 1690, e Istituto delle Scienze e delle Arti, creazione del 1705 di Luigi Ferdinando Marsili (1658-1730, che lo dotò della sua intera, e per allora enorme, biblioteca); l’avvio della Scuola di Chirurgia; l’assetto attuale del Teatro Anatomico dell’Archiginnasio (1733-36), con le due statue degli Spellati scolpite nel 1734 dal ceroplasta Ercole Lelli (1702-66) a visualizzare l’intero corpo umano; l’acquisizione all’Accademia delle Scienze della «Suppellex Obstetricia» (raccolta di strumenti e manufatti pratico-didattici in cristallo, metalli preziosi, terracotta e cera) del chirurgo Giovanni Antonio Galli (1708-82) chiamato a tenere il primo corso di ostetricia all’Alma Mater (aperto anche alle comuni levatrici). Lui volle Laura Bassi (1711-78, bolognese, seconda donna laureata dell’Età Moderna, 1732) a insegnare Fisica sperimentale all’Università, facendone la prima donna al mondo investita di cattedra universitaria (1733). Bibliofilo e bibliomane, nel 1755 donò la Biblioteca personale (25mila volumi e 400 manoscritti) all’Accademia delle Scienze, dopo averle ottenuto nel 1749 il lascito della preziosa ancor più vasta ed eclettica raccolta del cardinale Filippo Maria Monti (1675-1754, bolognese amico e compagno di studi).
La mostra (dalle 17 sale di Palazzo Poggi estesa anche a Museo Civico Medievale, Museo Civico Archeologico e Collezione di Zoologia) presenta libri, manoscritti, stampe, dipinti, le straordinarie ceroplastiche della «Stanza di Anatomia» dei coniugi Giovanni Manzolini, scultore collaboratore di Ercole Lelli, e Anna Morandi, ceroplasta e anatomista di portentosa mimesi, strumenti scientifici d’avanguardia; dalla Camera di Geografia e Nautica dell’Istituto (creata nel 1724) i due globi (legno e cartapesta ricoperti da carta stampata) dono del 1752 (opera ultima di John Senex, 1678-1740, cartografo e astronomo dell’inglese regina Anna): il globo celeste con oltre 2mila stelle nominate in latino, greco e arabo; la Carta d’Europa di Frederick de Witt (Amsterdam, 1719) donata nel 1726 e la Carta Nautica di Banet Panadès (XVI sec.), che dispiega il Mediterraneo e parte dell’Oceano Atlantico, questa dal Museo Cospiano (Wunderkammer fra le più importanti del XVII secolo del bolognese marchese Ferdinando Cospi, 1606-86) che nel 1743 Benedetto confluì nell’Istituto delle Scienze. Altri doni di Benedetto (1751) furono la tartaruga Liuto in quell’anno arenatasi sulle spiagge di Nettuno (il più antico reperto in Italia della più grande specie di testuggine, Collezione di Zoologia) e il coccodrillo del Nilo, esposti accanto al «Ritratto di Benedetto XIV» (1744), mosaico a tessere di smalto tagliate di Giacomo Zoboli (1681-1767).
Tutti a raccontare la sfaccettata visione culturale di Benedetto XIV e la sua illuminata generosità d’intelletto e di governo, nata dall’ottica sua personale di cooperazione fra Chiesa e Società Civile, fra tolleranza e pacificazione.
Benedetto XIV fu oggetto costante di dispute tra favore per l’istinto profetico nell'amministrazione della Chiesa e critica, soprattutto dalle alte gerarchie ecclesiastiche, per l’azione politica troppo arrendevole e conciliante verso il laicismo imperante dell’Illuminismo radicale (e il suo immediato successore Clemente XIII Rezzonico annullò di furia le maggiori riforme di Benedetto, salvandone di fatto solo i romani Musei Sacri e Profani, oggi parte dei Musei Vaticani).
Resta curioso il fatto che la maggior stima e approvazione a Papa Lambertini vennero dall’Europa Riformata e in specie dall’establishment anglicano: per tutti, lo scrittore tuttologo Horace Walpole (1717-97) all’indomani della morte lo definì «amato dai papisti, stimato dai protestanti, un prete senza insolenza o interesse, un principe senza favoritismi, un papa senza nepotismo, un autore senza vanità, un uomo che né l'intelletto né il potere poterono corrompere».

Carlo Costanzi, «Smeraldo intagliato», 1745, Bologna, Tesoro della Cattedrale di San Pietro