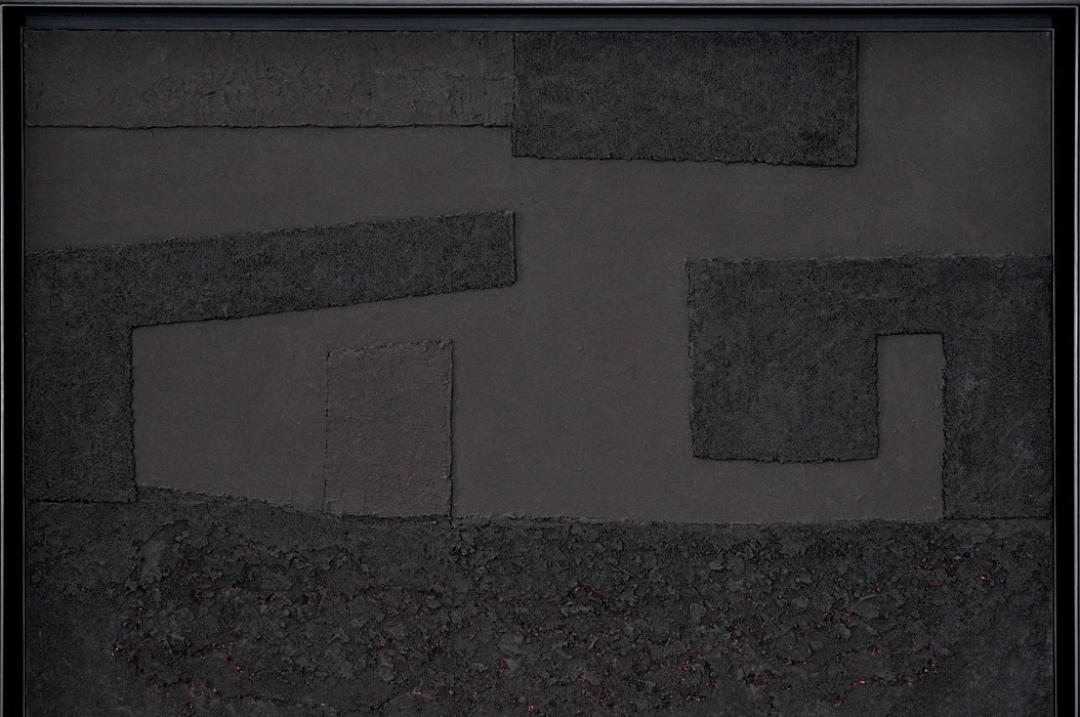Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Francesco Maria Orsolini
Leggi i suoi articoliCommissionato dal Museo del Novecento di Milano, il cantiere di restauro della «Giraffa artificiale» di Gino Marotta, allestito al Mudec e conclusosi alla fine della scorsa primavera, è stato un interessante osservatorio sull’uso espressivo del materiale plastico nell’arte contemporanea. Ce ne parla Anna Laganà, che l’ha diretto per il Getty Conservation Institute.
Com’è nato questo intervento di restauro?
Di proprietà del Museo del Novecento di Milano, l’opera di Marotta si trovava in deposito da vent’anni, perché aveva alcune parti spezzate, le due code e soprattutto una zampa; quest’ultima ne aveva compromesso anche la statica. Inoltre, in questo arco temporale si erano sedimentati sulle superfici dell’opera polvere e altri depositi incoerenti, come pure si erano accumulate abrasioni superficiali, che ne avevano fortemente alterato la trasparenza. Quindi, gli obiettivi fondamentali del restauro sono stati: ripristinare l’integrità fisica della scultura per riportarla al suo originario equilibrio statico ed eliminare l’opacizzazione che aveva compromesso la trasparenza in molti parti della plastica, o meglio del polimetilmetacrilato, il polimero termoplastico utilizzato per la realizzazione dell’opera.
Quali sono le difficoltà più rilevanti che avete incontrato nel restauro?
Questo restauro è un caso di studio, sul quale abbiamo anche svolto uno specifico intervento di formazione per restauratori dell’arte contemporanea. Quella di Marotta è una delle tante opere in plastica che si trovano nei depositi museali, perché interessate dagli stessi elementi di degrado. Finora era molto difficile ripristinare la trasparenza in opere danneggiate, perché non si sapeva con quali materiali e metodi idonei intervenire, in quanto il restauro della plastica è una disciplina nuova rispetto al restauro di altri materiali tradizionali.
In particolare, la mia personale ricerca è iniziata in Olanda e da sei anni sta proseguendo al Getty Conservation Institute, dove abbiamo sviluppato molta esperienza nel ripristino della trasparenza, in particolare della resina poliestere insatura e del polimetilmetacrilato, intervenendo sulle varie tipologie di danno, dalle scheggiature ai graffi, alle abrasioni, ma anche sull’incollaggio delle parti spezzate con adesivi idonei. Per i risultati davvero importanti che sono stati raggiunti in questa ricerca è stata decisiva la comparazione con il restauro del vetro e l’applicazione della procedura ad equivalenza dell’indice di rifrazione dei materiali utilizzati nel restauro e dei materiali originali dell’opera.
Il restauro del vetro e della plastica, finalizzato al ripristino della loro trasparenza, si basa sul principio dell’indice di rifrazione della luce. Quindi è sostanzialmente diverso dal restauro dei materiali tradizionali, per i quali l’intervento viene predisposto in modo tale da renderlo intenzionalmente riconoscibile, come per esempio la tecnica del «rigatino» nel restauro pittorico.
Infatti, si tratta di due protocolli diversi, in modo particolare quello per il restauro della plastica, i cui materiali, che sia un adesivo o un riempitivo, sono polimeri sintetici come quelli dell’opera, e quindi i due rispettivi indici di rifrazione debbono essere i più corrispondenti possibile, affinché sia ripristinata la trasparenza. Inoltre, c’è una differenza ancor più radicale nel restauro della plastica, che ovviamente riguarda sempre e solo l’arte contemporanea, vale a dire: non tutte quelle che potrebbero essere interpretate come anomalie dell’integrità fisica dell’opera, come ad esempio una linea di fessurazione, sono dovute al suo degrado fisico.
E la complessità specifica del restauro del contemporaneo è proprio questa: saper distinguere i casi di degrado da quelli che invece corrispondono a segni dell’intenzionalità espressiva, che quindi attengono alla tecnica artistica con cui l’opera è stata creata. In questa di Marotta, ad esempio, ci sono fili di colla, colla abrasa in corrispondenza delle giunture per abbassarne il rilievo, graffi lasciati dai morsetti per l’incollaggio delle varie lastre che compongono la scultura, esattamente 64, persino alcune impronte digitali dell’artista nelle parti degli incollaggi.
Quindi si può dire che i materiali plastici, all’epoca espliciti riferimenti alla civiltà industriale, in realtà sono stati lavorati e formati dall’artista con una forte impronta manuale-artigianale?
Sì, questo è un dato che emerge con evidenza dal restauro. È fantastico come Gino Marotta operasse su queste lastre, spesse due centimetri, molto pesanti e molto resistenti, anche se non ai danni meccanici superficiali, come se fossero di legno, usando seghe circolari, a nastro e procedendo con assemblaggi di parti che non rispettano nemmeno la simmetria, con una tecnica artistica molto lontana dalla produzione in serie e invece tipica del pezzo unico. Addirittura evidenziando, invece che nascondendo, i difetti di produzione delle lastre, facendoli apparire come segni dell’opera, oppure servendosi delle sbavature di colla carteggiata come fossero le maculazioni tipiche della giraffa.
Che effetto le fa restaurare le plastiche affinché possano resistere all’usura del tempo, quando invece in via ordinaria ci confrontiamo con la plastica nel modo diametralmente opposto?
Non è la prima volta che mi viene posta questa domanda e la risposta che do in questi casi è che il restauro riguarda l’opera d’arte, a prescindere dal materiale con cui è stata realizzata, e la possibilità che possa essere ammirata nelle sale dei musei, invece che solo custodita nei loro depositi. Realizzata con lastre di metacrilato di color rosso, l’opera fu donata da Marotta al Comune di Milano, dopo essere stata esposta all’antologica promossa alla Rotonda della Besana nel 1973, lo stesso anno in cui l’artista partecipò alla XV Triennale con la serie di opere «Eden artificiale».
Per una storia della plastica nell’arte
L’abbreviazione «metacrilato», con cui viene perlopiù indicato il materiale del «polimetilmetacrilato», risulta acquisita dal lessico della lingua italiana solo nel 1965. Ma l’uso dei polimeri plastici in ambito artistico è di molto precedente e, come richiamato anche da Anna Laganà nel corso dell’intervista, risale agli anni Trenta del Novecento, con le prime sperimentazioni dei fratelli costruttivisti russi Naum Gabo, Antoni Pevsner e dell’ungherese László Moholy-Nagy, che nel 1936 realizzò a Londra i suoi «Space modulators» in plexiglas.
La prima lastra di polimetilmetacrilato venne prodotta nel 1932 dagli stabilimenti inglesi della Imperial Chemical Industries e il materiale venne denominato «perspex», dal latino «perspicio» («vedere attraverso»), con riferimento alla sua qualità specifica della trasparenza che, unita a quella della resistenza, altrettanto elevata, incentivò la produzione del materiale in alternativa a quella del vetro, per le applicazioni che richiedevano entrambe le qualità, come i cupolini degli aerei da caccia Spitfire della seconda guerra mondiale.
Alla metà degli anni ’60, nel pieno del boom economico, gli artisti italiani cominciano a sperimentare l’uso del metacrilato. Sono gli stessi anni in cui l’industria chimica italiana s’impone a livello mondiale, soprattutto mettendo in produzione i brevetti dei polimeri scoperti da Giulio Natta, premio Nobel per la chimica nel 1963, grazie ai quali si costituì la Montedison.
La mostra del 1969 «Nuovi materiali, nuove tecniche», curata tra gli altri da Lorenza Trucchi a Caorle, e il catalogo Arte - Plastica 1969-1984 del Polimero Arte di Castiglione Olona, edito da Scheiwiller con prefazione di Gillo Dorfles, documentano che per i pittori e gli scultori della generazione di Marotta la sperimentazione della plastica divenne una soglia quasi obbligata per entrare nel vivo del dibattito artistico, affrontandone i temi più attuali: la sinisgalliana «Civiltà delle macchine», il rapporto arte-industria, l’arte pop e la sua intrinseca riproducibilità, lo spazio-immagine e l’arte-ambiente che, fuoriuscita dalla cornice dell’opera, ridisegna lo spazio di vita dell’uomo contemporaneo al fianco dell’architettura e dell’urbanistica.
Questi i nodi al pettine da sciogliere per allontanare il cono d’ombra dell’hegeliana morte dell’arte e per dimostrare, al contrario, una vitalità, magari «del negativo» che allontanasse l’arte dalla dimensione del «destino», facendola procedere ancora verso quella del «progetto», i termini opposti richiamati dal saggio famoso di Giulio Carlo Argan. Questi erano anche i nodi con cui si era stretta, oltre a quella coniugale, l’unione intellettuale e creativa tra Nancy Strampelli e Gino Marotta, che insieme dettero vita al «Mana Art Market».
In questa galleria-laboratorio d’idee e di artefatti, inaugurata a Roma il 29 febbraio del 1968, sono stati presentati gli autori più significativi della scena artistica italiana, ma anche internazionale, tra i quali Alviani, Angeli, Burri, Bussotti, Cage, Castellani, Ceroli, Colla, Colombo, Festa, Fioroni, Kounellis, La Pietra, Manzoni, Mauri, Pascali, Pistoletto, Rauschenberg, Rotella, Schifano, Twombly, Xerra. Nelle foto dell’inaugurazione si riconoscono tra gli altri Corrado Cagli, Roberto Calasso, Maurizio Calvesi, Plinio De Martiis, Gillo Dorfles.
Il lungo elenco delle mostre e delle performance allestite nella Galleria fino al 1978 è consultabile nel catalogo Il “Mana” di Nancy Marotta. 1968-1978: dieci anni di attività della Galleria “Mana Arta Market” a Roma, ES Architetture, Roma 1996. In questa pubblicazione è lo stesso Marotta a richiamare la linea di tendenza della galleria: ribaltare il mito dell’artista bohémien e dell’unicum costituito dalla sua opera, rinegoziare gli ambiti e i limiti dei contesti espositivi, come pure i soggetti della committenza, includendo tra questi il mondo aziendale (emblematicamente associato alla Olivetti di Adriano), sperimentare la produzione di opere multiple, che potessero inserirsi e, almeno in parte, sostituire gli elementi tradizionali di arredo dello spazio domestico, come di quello urbano.
Vennero così prodotte in modello una porta di Lucio Fontana e una di Enrico Castellani, che però restarono pezzi unici, come pure vennero esposti i modelli e i progetti degli studi Archizoom e Superstudio. Non dimenticando che il termine «mana», ripreso dagli studi etno-antropologici di Malinowski, Mauss e Lévi-Strauss, presidiava un valore considerato irrinunciabile, ovvero il permanere nell’opera d’arte contemporanea di una forte energia psichica e di una dimensione simbolica, erede di quella primitivo-animistica, come riformulazione dello «spirituale nell’arte».
«Pensavamo a un’opera d’arte che fosse riproducibile in serie, utilizzando le risorse e il linguaggio che derivavano dalle tecnologie industriali… Io conoscevo le fabbriche, i cicli produttivi, le tecnologie avanzate, così come oggi conosco le tecniche della pittura antica e questo ha certo consentito a me e a Nancy di realizzare qualcosa che altrimenti non avremmo potuto fare». Un fare i cui princìpi e metodi si erano espressi nell’esperienza progettuale della mostra «Lo spazio dell’immagine», allestita a Palazzo Trinci di Foligno nell’estate del 1967. Gino Marotta vi presenta l’opera «Naturale-Artificiale», un insieme di cellule spaziali riunite con superfici speculari ed elementi arborei modulari in metacrilato, termoformato, trasparente e incolore.
Un’affascinante interpretazione del tema «environment art» al centro della rassegna, nel quale l’esserci fenomenologico dello spettatore-osservatore è la sintesi tra l’esperienza percettiva dello spazio, denaturalizzato dall’immagine speculare che lo frammenta e lo riproduce ad libitum nel suo doppio, e la dimensione simbolica della natura vista «attraverso» la trasparenza, tutt’altro che inerte e indifferente, della tecnologia-plastica. Decisivo, per la dichiarazione di poetica della mostra, il richiamo-omaggio a Giacomo Balla, conosciuto e frequentato da Gino Marotta negli anni ’50, poco dopo essere approdato a Roma da Campobasso, che aveva usato l’espressione «paesaggio artificiale» già nel Manifesto della ricostruzione futurista del 1915.
Gli stampi in legno e gesso, propedeutici della termoformatura generativa di «Naturale-Artificiale», erano stati anch’essi elaborati da Gino Marotta, che per l’intero procedimento tecnologico aveva ottenuto la disponibilità a sperimentare nuovi colori e spessori delle lastre di metacrilato prodotte dall’azienda Simeplas di Pomezia. A ricordarlo è lo scultore inglese David Morris, che all’epoca collaborava con Marotta allo studio del Labaro e alla Galleria Mana Art Market, per sviluppare la sua ricerca sui materiali plastici e sulla loro illuminazione artificiale con la fibra di vetro, iniziata nel Regno Unito ispirandosi alle opere di William Tucker, David Annesley, Dante Leonelli, di Tim Scott e del Continuum group.
Nel 1969 Marotta partecipa alla mostra di Caorle con teche illuminate di metacrilato, questa volta colorato, che contengono le sagome, radicalmente iconizzate, come una segnaletica per emblemi, di forme naturalistiche del mondo atmosferico, vegetale e animale. Il tutto proposto come rivisitazione in termini mitopoietici di un’avveniristica Wunderkammer, nella quale non sono più le curiosità della natura a essere osservate, ma è la natura stessa, in quanto tale e nella sua universalità a esporsi come oggetto singolare alla visione di uno sguardo umano o post-umano. Nel 1971 il «Naturale-Artificiale» di Foligno viene riplasmato presso gli stabilimenti della Montedison e riproposto, con il titolo «Bosco naturale-artificiale», in uno spazio espositivo allestito appositamente dal colosso petrolchimico italiano per la Kunststoffe ’71 a Düsseldorf.
Alludendo alle qualità della plasmabilità e trasparenza del polimetilmetacrilato, per certi versi analoghe a quelle del vetro, nell’introduzione istituzionale del catalogo il materiale dell’opera viene denominato «vedril», mentre nel testo critico di presentazione Gillo Dorfles si concentra su tre temi essenziali dell’opera di Marotta: la trasmutazione della cosalità fredda e inerte della plastica che s’invera quando l’arte viene iniettata nella mescola, rendendola viva e reattiva al senso; la nostalgia dell’osservatore per la «genuina natura che ha smarrito (o che sta per smarrire)»; il riferimento allo spazio-immagine creato da Marotta come scenografia, non più «veduta» dall’esterno come a teatro, ma «vissuta» nel trovarvicisi dentro dell’osservatore.
Peraltro, a consentire un’ulteriore sperimentazione espressiva del metacrilato fu proprio la scenografia per il film di Carmelo Bene «Salomè», presentato nel 1972 alla Biennale Cinema di Venezia. Poi, nel 1973, animali, piante e fenomeni naturali escono dalle rispettive teche per invadere lo spazio all’aperto della Besana a Milano e, nel 1975, dell’intero centro storico di Camerino. Le apparizioni iconiche di emblemi e segnali si trasformano in tangibili oggetti plastici dalle cromie pop-saviniane, che giocano a nascondino con la loro dimensione spettrale.
Il corpo plastico è decostruito ed evocato grazie al ritaglio delle forme su piani-sezioni intersecanti, secondo una metodologia di individuazione e proiezione di punti, che da Leon Battista Alberti e Piero della Francesca si sviluppa fino al Vignola. La scultura del plastico-plasmare si dissolve nell’astratto-proiettivo del disegno e nel colore della pittura, scardinando la divisione delle arti e ponendo al centro dell’arte il suo essere un metalinguaggio, non altrimenti accessibile e comprensibile se non «attraverso» la visione lirica della contemplazione.

La direttrice del restauro Anna Laganà al lavoro sull’opera «Giraffa artificiale». Gino Marotta, «Giraffa artificiale», 1973, polimetilmetacrilato, Museo del Novecento, Milano. Courtesy of the J. Paul Getty Trust.
Altri articoli dell'autore
La doppia personale alla Galleria Spazia di Bologna è una storia anni Cinquanta
Senza acqua potabile l’opera perde il suo significato simbolico rigenerante, mentre un megaprogetto rischia di stravolgere tutta l’area del porto antico, dove essa è stata realizzata nel 2017
Documenti dell’Archivio di Stato di Ancona li rappresentano nel contesto storico del regime fascista