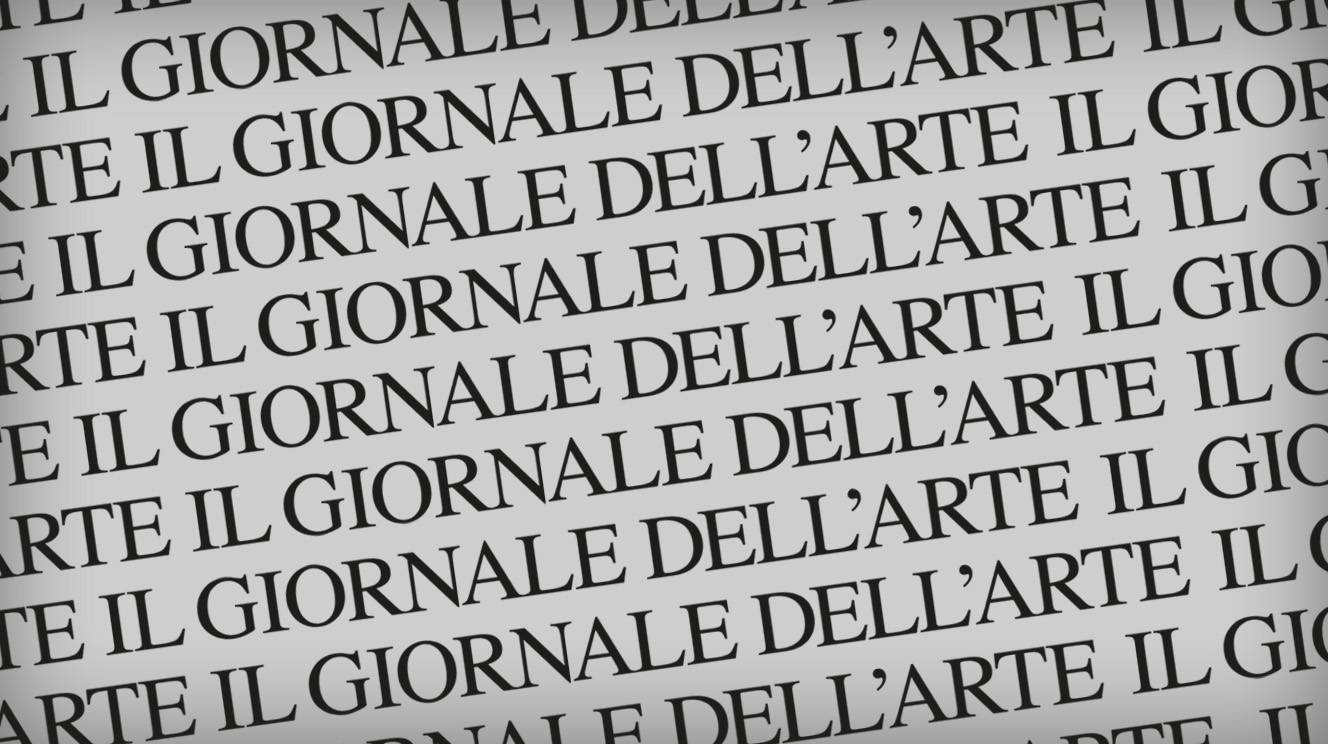Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Luana De Micco
Leggi i suoi articoliÈ l’uomo che ha osato apporre il logo del Musée d’Orsay sulle immagini di un’orgia di massa per promuovere la mostra sul Marchese de Sade nel 2014. Ora è riuscito a riaprire nelle sale del museo le porte dei bordelli parigini della Belle Époque («Splendori e miserie», fino al 17 gennaio; cfr. n. 356, set. ’15, p. 32). Uno scandalo dopo l’altro. Non si può certo dire che il presidente del Musée d’Orsay, Guy Cogeval, sia un fautore del politically correct. C’è chi non vede del resto di buon occhio il suo parlare schietto, il suo rompere gli schemi infischiandosene di scioccare i conservatori benpensanti. Lui porta a casa i risultati: da due anni il numero di visitatori del museo non scende al di sotto dei tre milioni e mezzo. «Sono stato io a svecchiare questo museo, lo sto trasformando per il XXI secolo», dice senza falsa modestia. La collezione viaggia tra Seul e Fort Worth. La mostra sulla «Nascita dell’Impressionismo» al National Art Center di Tokyo ha accolto in tre mesi 710mila visitatori.
L’Italia è un eccellente cliente e qui quest’anno il Musée d’Orsay è onnipresente. Dopo la mostra su Henri Rousseau al Palazzo Ducale di Venezia (che si è chiusa a settembre e arriverà a marzo a Parigi), si tengono in questo momento a Roma «Impressionisti. Tête-à-tête» al Vittoriano e «Una dolce vita?» al Palazzo delle Esposizioni. Alla Galleria d’Arte moderna di Torino è esposto per la prima volta in Italia «Le déjeuner sur l’herbe» di Monet (cfr. n. 356, set. ’15, p. 31). Il 27 novembre si aprirà alla Gam di Milano «Adolfo Wildt. L’ultimo simbolista» (cfr. articolo a p. 36). L’Italia lo adora: non solo paga per le sue mostre, ma il 4 novembre l’Ambasciata italiana a Parigi lo nominerà commendatore dell’Ordine della Stella d’Italia. Il 18, riceverà il diploma honoris causa dell’Accademia Albertina di Torino, dove terrà una lezione sul design italiano.
Di madre piemontese, specialista di Édouard Vuillard, dichiaratamente gay (si è sposato con il compagno dopo il voto in Francia della legge sul «matrimonio per tutti»), Guy Cogeval ci tiene a definirsi «uno dei pochi storici dell’arte ancora alla testa di un museo». Presidente del tempio parigino dell’Impressionismo dal 2008, non si fa problemi a confessare: «Non sono ossessionato da Monet».
A tre anni dalla scomparsa dell’architetto Gae Aulenti, che ha trasformato la Gare d’Orsay in museo nei primi anni ’80, Cogeval nel suo ufficio tappezzato di cataloghi d’arte ci annuncia che sta per dare il via all’ultima grande fase di lavori del «nuovo Orsay», un progetto di riallestimento completo della collezione lanciato nel 2011. Nel 2012 sono state inaugurate le nuove sale del Postimpressionismo al primo piano, il nuovo spazio per le mostre temporanee nell’antica Galleria delle Colonne e soprattutto la nuova Galleria degli Impressionisti, al quinto piano. «Ora bisogna intervenire sull’ala che si affaccia sulla Senna, dove si trovano le sale delle Cupole, che accolgono i grandi formati e le arti decorative, spiega. L’allestimento di Gae Aulenti era rivoluzionario per la sua epoca, ma nessun progetto museografico può durare più di trent’anni. Bisogna correggere l’illuminazione, rinnovare i colori e le vetrine. Nel 2016 partiranno gli studi, per una consegna dei lavori prevista a fine 2017, inizio 2018. Quanto alla navata centrale, spero che non verrà mai modificata».
Direttore Cogeval, il progetto si proietta su tre anni, ma il suo mandato scade a marzo 2016. Sarà rieletto?
Se il presidente della Repubblica mi riconferma sarà il mio terzo e ultimo mandato. Sono fiducioso. E poi ho ancora molte cose da fare. Ci sono per esempio da allestire nuovi spazi per accogliere le collezioni di due donatori. La prima è un’importante collezione di Bonnard e Vuillard. La donazione con riserva di usufrutto è stata firmata nel 2011. La collezione raggiungerà dunque il museo alla morte del proprietario, che per il momento desidera restare anonimo. La seconda, sempre di arte francese, appartiene a un privato americano. La donazione in questo caso non è ancora stata firmata, ma se l’operazione verrà confermata, sarà la prima volta che una collezione francese rientra dagli Stati Uniti.
Negli ultimi anni ha portato avanti un’audace politica di esposizioni, da lei pensate come un grande impresario, un Barnum. Dopo il nudo maschile, Sade e le case chiuse, a quale altro tema shock sta pensando?
D’ora in poi sarò più saggio. Ho 60 anni, un’età rispettabile, è il momento di tornare a temi più accettati dal pubblico. Le prossime mostre saranno su Tissot, l’Accademismo, il Secondo Impero. Mi piacerebbe anche organizzare più in là una mostra su Puccini, sulla scia dei miei primi studi in Italia sui decori del teatro dell’opera e di un’esposizione su Debussy che abbiamo presentato qui nel 2012.
Le piace scioccare?
La mostra «Masculin/Masculin» è stata un grande successo (più di 400mila visitatori da settembre 2013 a gennaio 2014; cfr. «Vernissage», sett. ’13, pp. 3-4, Ndr) e ora quella sulla prostituzione è sempre piena. Sfido gli altri musei a riuscire a fare altrettanto con temi così inconsueti. Ho osato e ha funzionato. Non mi si può rimproverare nulla. Molti uomini politici sono stati riluttanti a partecipare alle nostre inaugurazioni, ma poi vengono a vedere le mostre dopo che sono iniziate.
Dopo Degas, Renoir e ora Monet, ha di recente annunciato a Torino un’altra mostra su Manet. Due anni dopo quella del Palazzo Ducale di Venezia. Come spiega che gli impressionisti continuino ad avere tanto successo?
Il pubblico ha sempre bisogno di grandi nomi. Ma che dirle? Il XIX secolo è la mia specializzazione. Sono arrivato al d’Orsay con una forte esperienza internazionale e un certo fiuto per l’economia. E poi abbiamo la fortuna di possedere una delle più grandi collezioni al mondo di pittura impressionista. È la nostra manna finanziaria. Ma non sono un fanatico degli Impressionisti. Abbiamo altro e ho voglia di mostrarlo.
Però i turisti di tutto il mondo vengono qui per vedere Monet…
Perché si parla solo di questo. Nessuno sa che abbiamo anche una grande collezione accademica e simbolista. Riportarla in voga è ora la mia missione. Quest’anno abbiamo organizzato alla Fundacion Mapfre di Madrid una mostra sull’Accademismo francese, «Il canto del cigno», che sarà allestita anche in Brasile. Negli ultimi anni abbiamo arricchito la nostra collezione con tele di William Bouguereau, Maurice Denis, Rippl-Rónai, Édouard Vuillard. Opere che in passato non interessavano nessuno e che ora tornano di moda. In materia di acquisizioni siamo tra i più dinamici in Europa.
Come vive la concorrenza delle ricche fondazioni private che possono permettersi prestiti astronomici?
Le due realtà non sono paragonabili, hanno ruoli diversi. I musei svolgono un lavoro intellettuale. Anche le mostre dette «blockbuster» non sono solo marketing, ma c’è un reale lavoro di specialisti e storici dell’arte. Lo scopo delle fondazioni è un altro. Comunque non ci è mai stato rifiutato un prestito. La notorietà del museo conta molto. Detto questo, anche noi abbiamo prestato le nostre «Ninfee» di Monet alla Fondation Vuitton per la mostra sui capolavori («Le chiavi di una passione», da aprile a luglio 2015, Ndr).
Quale programma ha per l’Orangerie?
Da quando le collezioni dell’Orangerie sono state assorbite dal Musée d’Orsay, nel 2010, il numero di visitatori è raddoppiato. È raro che un museo così piccolo accolga 800mila visitatori all’anno. Ma proprio perché gli spazi sono ridotti, più di due mostre all’anno non sono possibili. Un progetto a cui tengo molto è una mostra su Boccioni, da fare in collaborazione con i musei di Milano, nel 2017, in occasione del bicentenario della morte dell’artista.
Perché la presenza del Musée d’Orsay in Italia è cresciuta negli ultimi anni? In realtà prima del mio arrivo il museo era praticamente assente dall’Italia. Quando ne ho preso la presidenza, ho deciso di «latinizzarlo», avvicinandolo anche alla Spagna, al Portogallo e ai Paesi dell’America Latina.
È una politica un po’ colonialista. Con quale museo italiano sente più affinità?
Con i Musei Civici di Venezia. Gabriella Belli è una grande direttrice. Ci siamo incontrati quando lei era al Mart e da allora lavoriamo molto insieme.
Come sa in Italia sono stati eletti per concorso i direttori di venti musei statali. Che cosa ne pensa?
È una scelta che parte da buoni principi. È giusto che lo Stato intervenga per difendere le sue istituzioni. Ma non sono sicuro che siano state fatte ovunque le scelte giuste. Purtroppo non credo sia stato fatto nulla in materia di autonomia finanziaria, come l’abbiamo noi nelle istituzioni pubbliche francesi e anche qui al Musée d’Orsay. Tutte le acquisizioni e gli investimenti, oltre che il funzionamento del museo, sono interamente finanziati dalle nostre risorse, dalla vendita dei biglietti e dall’esportazione di mostre all’estero.
Di recente alcuni siti museali e turistici europei sono stati chiusi per scioperi. La chiusura del Colosseo per diverse ore ha fatto scandalo in Italia tanto che il Governo ha approvato un decreto legge per equiparare i musei ad altri servizi pubblici, come ospedali e trasporti. Anche il d’Orsay è rimasto chiuso due giorni. Che cosa ne pensa?
Non mi sembra che ci siano così tanti scioperi nei musei. Non in Francia almeno. Per quanto ci riguarda, i sindacati hanno protestato contro la politica del Governo di aprire il museo 7 giorni su 7. In Italia per esempio non c’è un solo museo che resti aperto tutti i giorni. L’unico esempio in Europa è il Prado, ma loro non hanno un programma di esposizioni all’estero dinamico come il nostro. Il Musée d’Orsay invece presta 2mila opere all’anno. Quando possiamo fare tutto questo lavoro? Bisogna davvero sempre dare torto ai sindacati?
Pensa di «delocalizzare» il museo come hanno fatto il Louvre e il Pompidou?
Non penso che il d’Orsay sia abbastanza grande per creare una filiale e poi la mia politica è sempre stata di aiutare i musei regionali. Abbiamo ottimi partenariati con il Musée des Impressionismes di Giverny, il Musée Courbet di Ornan e il Bonnard di Le Cannet. E proprio in questo periodo abbiamo una mostra itinerante sugli autoritratti del Musée d’Orsay che dopo Nancy andrà a Clermont-Ferrand e a Quimper.
Che mostra vorrebbe fare che ancora non è riuscito a realizzare?
Ho fatto praticamente tutte le mostre che volevo. Ma qui al d’Orsay non c’è mai stata una grande esposizione sul Simbolismo. Sarà il mio ultimo grande progetto.
Altri articoli dell'autore
Attraverso 260 opere il Louvre traccia il ritratto di una civiltà «rimasta a lungo ai margini degli studi accademici», un popolo di soldati, ma anche di commercianti, architetti, scienziati e artisti
A quarant’anni dalla pubblicazione, le fotografie raccolte nel libro «In the American West» vengono esposte, per la prima volta in Europa, alla Fondation Henri Cartier-Bresson
L’artista iraniana presenta per la prima volta in Belgio le sue figure femminili, i cui volti sembrano scolpiti dal pennello alle soglie dell’iperrealismo
Delle 240 opere esposte a Parigi, 126 provengono dal Museo nazionale di Cambogia di Phnom Penh. Seguirà un tour negli Stati Uniti