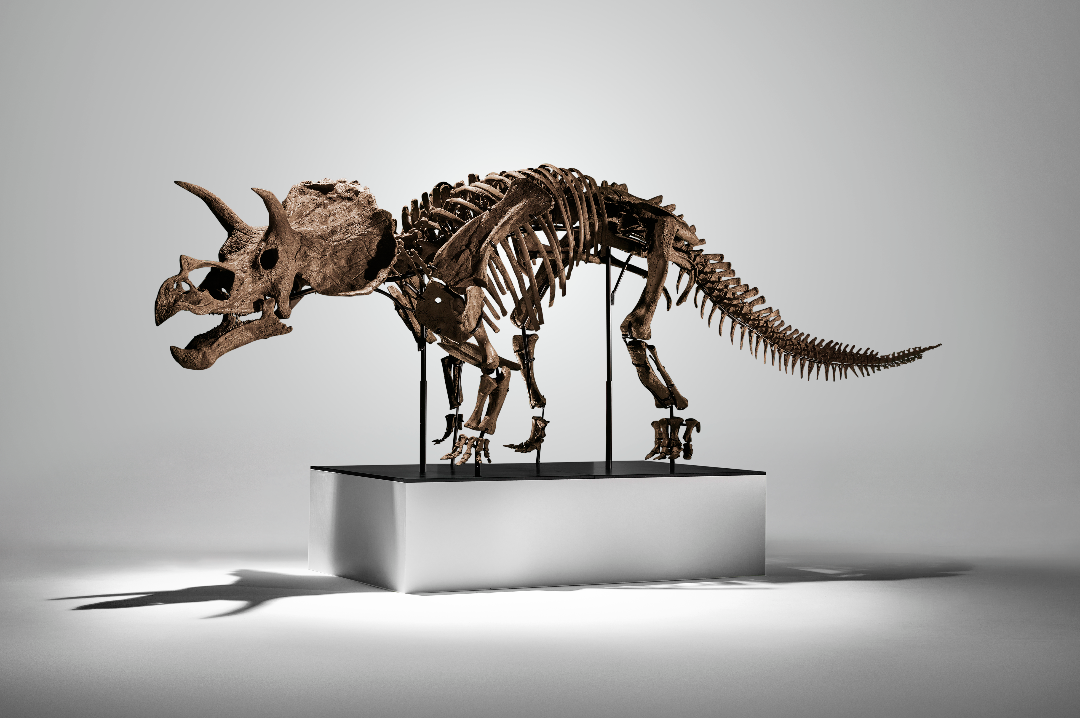Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Redazione
Leggi i suoi articoli«È con profondo dolore che annunciamo la scomparsa del nostro amato Mario Diacono, avvenuta giovedì 30 ottobre 2025. Gallerista, storico dell'arte, poeta e artista, Mario aveva una visione singolare dell'arte contemporanea e un bagaglio di conoscenze senza pari. Con occhio critico e cuore generoso, ha sostenuto molti artisti nel corso della loro carriera, condividendo con loro la sua saggezza, la sua passione e la sua gentilezza. Mario Diacono è stato fonte di ispirazione per tutti coloro che lo hanno conosciuto. La sua anima meravigliosa continua a vivere nelle sue opere rivoluzionarie e nelle vite che ha profondamente toccato. Ha amato ed è stato molto amato»: con questo commosso messaggio Amanda K. Burke, direttrice della Mario Diacono Gallery, ha detto addio a una delle figure più singolari, e internazionali, del mondo dell’arte.
Critico, curatore, gallerista, letterato, traduttore (di Antonin Artaud, James Joyce, Ezra Pound, Michaux) autore di poemi visuali e libri oggetto, Diacono, nato a Roma nel 1930 e scomparso a Boston, ha attraversato decenni di culture e geografie differenti, tra l’Italia e gli Stati Uniti. A Roma si laurea con Giuseppe Ungaretti (di cui diventerà segretario), con una tesi sul Futurismo e la rivista fiorentina «Lacerba» («È stata un’esperienza importante per me, ha ricordato in un’intervista con Giuseppe Frangi, perché ho potuto esplorare una rivista dove letteratura e arti figurative vivevano su uno stesso terreno. È stata un’intuizione del futurismo, con la quale mi sono sentito in sintonia e che poi ho sempre cercato di portare avanti. Anche se per me il linguaggio letterario e quello figurativo restavano due linguaggi separati»).
Nel corso degli anni Cinquanta frequenta poeti e artisti, visita gallerie, come La Vetrina, dove conosce Sandro Penna, che all’epoca si dedicava privatamente anche al commercio d’arte. In un’intervista con Laura Cherubini Diacono ricordava che «col mio primo stipendio d’insegnante comprai da Sandro Penna, nel 1957, un disegno di Sironi: 18 mila lire)». L’anno successivo avrebbe curato per l’amico Croce e delizia, raccolta di poesie dal 1927 al 1957 pubblicata da Longanesi. Da La Vetrina l'interesse si sposta verso La Tartaruga, la galleria di Plinio De Martiis, che esponeva Achille Perilli e Cy Twombly: «La Vetrina di Chiurazzi era la galleria del Novecento italiano. De Martiis tra il 1954 e il 1956 esponeva Mafai e altri pittori della scuola romana, ma cominciava a collaborare con Dorazio, Perilli, Novelli, tutti artisti con i quali sono poi diventato amico anche se non mi sono investito nel loro lavoro, ha dichiarato a Luca Lo Pinto. Il primo artista con cui mi sono veramente identificato è stato Cy Twombly. Per me Twombly ha rappresentato l’entrata di un vero clima internazionale a Roma. Allo stesso tempo, sempre nel 1958, grazie a Mohammed Melehi, un artista marocchino che studiava con Scialoja, sono andato nello studio di Kounellis in Piazza Firenze, che era arrivato a Roma da poco. Con Kounellis e Twombly ho cominciato a frequentare degli artisti d’avanguardia che consideravo veramente tali».
Collabora a riviste, «Il Caffè», «Tempo Presente», «Italia Domani», «La Tartaruga», «Ana Eccetera», «Quaderno», codiretto insieme a Stelio Maria Martini, «Continuum» (ancora con Martini e Luciano Caruso), «Linea-Sud», «Bollettino Tool», «Marcatré». Incontra altri poeti, come Emilio Villa, con il quale fonderà la rivista «Ex», o Edoardo Sanguineti, che firmerà con lui e con Cesare Vivaldi un libro su Scialoja, pubblicato dalla Galleria La Salita.
A Milano, dove vive nel 1966 e 1967, altre riviste: l’effimera «Da-a/u delà» (un solo numero); con Daniela Palazzoli, anche lei da poco scomparsa, vive l’esperienza di «Bit. Arte oggi in Italia», rivista di cultura contemporanea d’avanguardia pubblicata tra marzo 1967 e settembre 1968 (nove numeri in tutto);
Trasferitosi negli Stati Uniti per insegnare Letteratura italiana all’Università californiana di Berkeley, vi rimane dal 1968 al 1970, quando la sua borsa di studio Fulbright scade. Rientra a Roma, dove collabora con artisti e si dedica alla raccolta dei saggi di Ungaretti (Vita d’un uomo), che uscirà nel 1974 presso Mondadori. Alterna periodi americani e periodi italiani, riportando in Italia ciò che vede negli studi degli artisti americani e offrendo agli Stati Uniti una lettura articolata delle ricerche italiane. Negli States tornerà dal 1972 al 1976, insegnando al Sarah Lawrence College di New York. Qui, nel 1969, aveva conosciuto molti artisti statunitensi, tra cui Joseph Kosuth e Vito Acconci, sul quale sei anni dopo pubblica una monografia (Vito Acconci. Dal testo-azione al corpo come testo, Out of London Press, 1975), dirige la rivista «Tau/ma» insieme a Claudio Parmiggiani e pubblica alcuni saggi su «Collage».
Rientrato in Italia nel 1976, decide di aprire la sua prima galleria a Bologna, che rimarrà in attività dal 1978 al 1979. Seguirà, dal 1980 al 1984, uno spazio a Roma. «Nella mia galleria di Bologna, ricordava in un’intervista con Bob Nickas, esponevo principalmente artisti dell'Arte Povera, mentre nella mia galleria di Roma soprattutto pittori neoespressionisti: Sandro Chia, Enzo Cucchi, Francesco Clemente, Mimmo Paladino, Nicola De Maria, Bruno Ceccobelli, Jean-Michel Basquiat, Julian Schnabel, David Salle, Eric Fischl. Direi, tuttavia, che la parte più significativa della mia collezione è stata costituita mentre mi trovavo negli Stati Uniti. [...] Avere una galleria d'arte in un periodo in cui c'erano collezionisti appassionati mi ha fornito fondi che non avrei potuto guadagnare come professore universitario all’epoca».
Di ritorno in America, a Boston, per assistere in ospedale la moglie Claudette, studiosa franco-canadese con un dottorato in letteratura italiana conseguito alla Columbia University, Diacono apre una galleria anche nella capitale del Massachusetts. Sarà uno shock, dirà a Nickas, scoprirla tanto arretrata rispetto a New York. «La vitalità del mondo dell'arte newyorkese era costituita da tre elementi: gli artisti, i collezionisti e i musei. A Boston, nel 1985, non c'erano quasi artisti, collezionisti o musei che seguissero ciò che stava accadendo nell’arte contemporanea. Non includo l’ICA, che era l'unica istituzione che seguiva l'arte del momento. In particolare l’ICA di David Ross ed Elizabeth Sussman». La galleria divenne, negli anni Ottanta e Novanta, un punto di riferimento per l’arte più avanzata. La sua attività di gallerista non fu mai puramente commerciale: la galleria era un laboratorio critico, un dispositivo di pensiero dove le opere erano occasioni di riflessione teorica sulla natura dell’immagine e sul ruolo del linguaggio artistico.
Del resto, come sottolinea Mary Sherman, nel suo caso anche parlare di mostre è «improprio»: «Le esposizioni nelle gallerie di Mario consistevano tipicamente in una singola opera d'arte: un dipinto appeso a una parete. Ad accompagnarle c’era un piccolo opuscolo in cui egli descriveva l'opera, con un testo denso quasi quanto quelli di James Joyce. Era necessario leggere i suoi saggi come si legge una poesia: una volta per coglierne l'idea generale e poi molte altre volte fino a quando il significato non veniva finalmente compreso, anche se il suo contenuto non poteva mai essere sintetizzato in modo conciso. Forse non sorprende: Mario, oltre ad essere un gallerista, era un noto poeta verbo-visivo». Gli affari non andavano bene: «Quando ho inaugurato la galleria nel settembre 1990, ricordava in una conversazione con Charles Giuliano, era in corso la Guerra del Golfo. Saddam Hussein aveva invaso il Kuwait e il mercato era crollato. La mia prima mostra era dedicata ad Annette Lemieux e non ho venduto nulla, tranne che ad Achille Maramotti. Da allora, gli ho venduto le opere di tutte le mie mostre, che ora sono esposte a Reggio Emilia».
È proprio per l’amico Maramotti, fondatore del gruppo Max Mara, che negli anni Duemila Diacono torna con maggiore frequenza in Italia (Il collezionista, che era anche un caro amico, scompare nel 2005 a 78 anni). Contribuisce alla definizione dell’identità concettuale della Collezione Maramotti a Reggio Emilia, inaugurata nel 2007, pensandola come un luogo non solo di esposizione ma di riflessione sull’arte contemporanea. Insieme hanno dato vita a progetti che mettevano in dialogo la pittura analitica italiana con le ricerche internazionali, sottolineando la continuità tra la tradizione europea e le tensioni del presente.
Nel 2024, l’ultima avventura: una nuova galleria a Boston, a Beacon Hill. «Come da tradizione, ricorda ancora Sherman, per la prima mostra è stata esposta un’unica opera, accompagnata da uno dei suoi brillanti testi. Il pubblico è accorso da ogni dove per rendere omaggio all'artista. Successivamente, come era già accaduto con le sue mostre in South Street, la galleria è tornata nella quiete».
Altri articoli dell'autore
La maison ha ampliato la propria visione di cosa possa essere una casa d’aste del XXI secolo: intrecciando arte, design e oggetti di lusso e intercettando una nuova generazione di collezionisti orientati al digitale
Le audizioni hanno portato alla luce una serie di audit, alcuni risalenti al 2017 e 2018, che segnalavano vulnerabilità precise nei sistemi di sicurezza del museo, mai affrontate in modo risolutivo
In programma dal 17 gennaio al 12 marzo 2026 negli spazi di Platea | Palazzo Galeano, la personale, curata da Gaspare Luigi Marcone, inaugura la stagione espositiva dell’associazione lodigiana
Lungo le Navate di Pirelli HangarBicocca, l'esposizione ripercorrerà la pratica dell’artista cilena tra memoria indigena, spiritualità ed ecologia