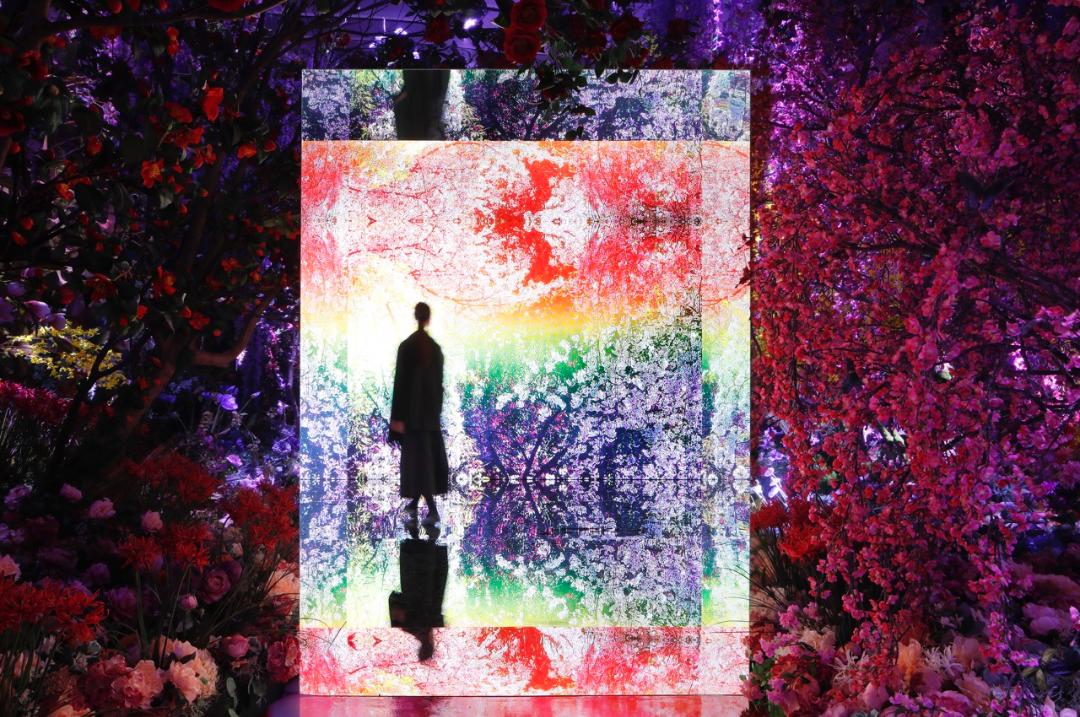Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Veronica Rodenigo, Jenny Dogliani
Leggi i suoi articoliARTICOLI CORRELATI
Dopo 25 anni (l’ultimo fu Massimiliano Fuksas) la curatela della Mostra Internazionale di Architettura di Venezia torna a un italiano: Carlo Ratti, torinese (classe 1971), ingegnere e architetto dalla formazione internazionale (dopo la laurea al Politecnico di Torino seguono Parigi, Cambridge e Boston, dove oggi dirige il Senseable City Lab del Massachusetts Institute of Technology). È anche fondatore dello Studio Carlo Ratti Associati (Cra) con sedi a Torino, Londra, New York. Il titolo scelto per la 19ma edizione è «Intelligens. Natural. Artificial. Collective», che il curatore giustifica con una straniante quanto discussa interpretazione, perché se il participio presente del latino intelligere certo non può tradursi con il sostantivo italiano «intelligenza», foneticamente il termine strizza l’occhio all’inglese Intelligence. «Ciò che vedremo a maggio sono persone e progetti che, partendo dal tema “Intelligens. Natural. Artificial. Collective”, lo elaborano in modo nuovo. Al centro è la molteplicità dell’intelligenza che non è ciò che molti oggi sono portati a pensare, cioè l’Intelligenza Artificiale e ChatGPT... C’è moltissima intelligenza anche nella natura, ad esempio, e in quella collettiva. E tutte insieme sono impegnate a gestire le sfide di un mondo che sta cambiando. La Biennale proporrà una serie di esperimenti che vanno proprio in questa direzione», spiega Carlo Ratti. Il direttore artistico immagina un’espansione di associazioni di significati di una parola che di «intelligenza» mantiene la stessa radice semantica e vi estrapola, quasi considerandolo un sostantivo a parte, il latino gens.
Nell’atto pratico Ratti, considerato uno dei dieci studiosi più citati a livello internazionale nel campo della pianificazione urbana, trasferisce in questa Biennale l’esito delle sue ricerche. La città, in cui coesistono natura e tecnologia, è concepita come un organismo vivente e i diversi tipi di intelligenza sono il codice per poterla leggere e comprendere. L’architetto e la sua disciplina (che pur mantiene un ruolo centrale) non bastano più. Per affrontare le urgenze del presente è necessario un approccio transdisciplinare ed è per questo che Ratti chiama a raccolta una vastissima compagine tra ingegneri, matematici e scienziati del clima, filosofi e artisti, cuochi e programmatori, scrittori e intagliatori, agricoltori e stilisti. La formula è quella della open call (poi adottata anche dalla curatrice del Padiglione Italia) su una piattaforma, uno spazio per le idee rimasto aperto dal 7 maggio al 21 giugno 2024. Risultato della scrematura: 755 partecipanti. Mai così tanti nella storia della Biennale.
Tra le priorità da affrontare: la crisi climatica «alla quale, afferma Ratti, l’architettura ha risposto per decenni con la mitigazione, approccio non più sufficiente. È il momento che l’architettura passi dalla mitigazione all’adattamento: nell’età dell’adattamento, l’architettura deve attingere a tutte le forme di intelligenza». Così in un allestimento modulare e frattale su progetto dello studio berlinese Sub, Ratti schiera alle Corderie dell’Arsenale i tre nodi tematici di questa edizione: Natural Intelligence, Artificial Intelligence, Collective Intelligence e una sezione Out, animata dalla struttura sonora di Jean-Michel Jarre. L’inizio del percorso è scandito da alcuni interrogativi: Come sarà il clima di domani? Che cosa succede quando la crescita della popolazione raggiunge un picco per poi crollare? Il tutto si concretizza, per esempio, in inondazioni artificiali e vortici d’aria rovente (risultato della collaborazione tra Cittadellarte-Fondazione Pistoletto con gli ingegneri climatici Transsolar e Daniel A. Barber) e nel progetto (guidato dal fisico Geoffrey West con Roberto Kolter, Beatriz Colomina e Mark Wigley) che ripensa i principi della vita sulla Terra esplorando comunità microbiche.
Poi ci si addentra nel concept curatoriale in cui s’incontrano Kengo Kuma and Associates (con Sekisui House-Kuma Lab & Iwasawa Lab e Ejiri Structural Engineers) impegnati a esplorare tecniche di falegnameria giapponesi fuse con l’Intelligenza Artificiale che trasformano il legno in materiale strutturale; il futuro delle costruzioni (biocalcestruzzo, fibra di banana, grafene…) con Ingrid Paoletti, Stefano Capolongo, il premio Nobel Konstantin Novosëlov e la scenografa Margherita Palli Rota; i robot umanoidi utilizzabili nel futuro dell’edilizia (Philip Yuan, Tongji University, Gramazio Kohler Research del Politecnico di Zurigo, Mesh e Studio Armin Linke); lo speakers’ corner disegnato da Christopher Hawthorne, Johnston Marklee e Florencia Rodriguez come spazio dedicato a discussioni e workshop. Per supplire all’assenza del Padiglione Centrale ai Giardini (chiuso per restauro), Ratti dissemina inoltre ulteriori contenuti in città (Caffè Quadri in Piazza San Marco, Ca’ Giustinian e IUAV, sede di Ca’ Tron), ai Giardini e in Arsenale. Tra questi, presso il bacino acqueo dell’Arsenale, «Gateway To Venice’s Waterways», rivolto a una futura mobilità acquatica sostenibile e «Canal Café», visionario progetto di depurazione delle acque dei canali veneziani al fine di trarne «il miglior caffè espresso d’Italia». Undici gli eventi collaterali ufficiali, distribuiti tra il Sestiere di Castello, Giardini della Marinaressa e diverse sedi veneziane.

«Canal Cafe View», Aaron Betsky Diller Scofidio + Renfro, Natural Systems Utilities Sodai
Le 66 partecipazioni nazionali
Sessantasei (di cui 15 nel centro storico), le altre distribuite come di consueto tra Padiglioni Storici ai Giardini e Arsenale. Quattro le nuove partecipazioni: Repubblica dell’Azerbaigian, Sultanato dell’Oman, Togo e Qatar. Tra i veterani, invece, la Francia presenta la mostra «Vivre avec/Living with», un’installazione effimera en plein air tra il padiglione francese (chiuso per ristrutturazione) e il canale che attraversa i Giardini: un padiglione sperimentale concepito dagli architetti Dominique Jakob e Brendan MacFarlane, in collaborazione con Martin Duplantier ed Éric Daniel-Lacombe, come rifugio aperto e inclusivo che incarna il concetto del vivere con l’ambiente e il paesaggio. Gli Stati Uniti esplorano invece le tipologie architettoniche del Sud America, con una mostra organizzata dalla Fay Jones School of Architecture and Design dell’Università dell’Arkansas in collaborazione con DesignConnects e il Crystal Bridges Museum of American Art.
In tutto 54 vetrine «finestre da portico» esporranno progetti architettonici, modelli e altri manufatti. «Gbr: Geology of Britannic Repair» è il progetto con cui la Gran Bretagna indaga le risposte dell’architettura alle eredità coloniali dell’estrazione geologica. Nato da una collaborazione tra Regno Unito e Kenya, il Padiglione sarà trasformato in uno spazio dedicato a geologie alternative, giustizia planetaria e una pratica architettonica basata sulla terra. La Germania, infine, esporrà i visitatori a uno stresstest fisico e psicologico sugli effetti del cambiamento climatico urbano, sottolineando come questa realtà minacci la vita sociale urbana, la produttività, la salute e la sopravvivenza dei cittadini (a cura di curatori Nicola Borgmann, Elisabeth Endres, Gabriele G. Kiefer e Daniele Santucci).
Riparazioni spirituali e materiali
Il Padiglione della Santa Sede, alla sua terza partecipazione alla Biennale di Architettura, quest’anno lascia l’Isola di San Giorgio per insediarsi nel complesso di Santa Maria Ausiliatrice a Castello. «Opera Aperta» vede coinvolti Tatiana Bilbao Estudio (Città del Messico, Messico), Maio Architects (Barcellona, Spagna) per la curatela di Marina Otero Verzier e Giovanna Zabotti e si concentra sull’intervento di restauro della cappella del complesso religioso e della pavimentazione del chiostro. Un atto di riparazione che assume anche un alto significato valoriale: quello di riconnettere visitatori e comunità. Il programma prevede visite guidate ai cantieri, esperienze laboratoriali (a cura dell’Università Internazionale dell’Arte, Uia, Venezia) aperte anche al mondo dell’associazionismo veneziano, momenti conviviali e l’opportunità, per giovani musicisti, di poter fruire di strumenti dislocati in diversi spazi (in collaborazione con il Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia). «Un padiglione concepito come un cantiere, ha spiegato Sua Eminenza Cardinal José Tolentino de Mendonça, come un processo in corso a cui tutti sono invitati a collaborare. Allo stesso tempo in cui si riparano i muri e i dettagli architettonici dell’edificio, si ripareranno anche le relazioni di vicinato e l’ospitalità intergenerazionale, ricostruendo simultaneamente lo spazio fisico e lo spazio sociale. Il nostro desiderio è che questo padiglione-parabola possa dare espressione concreta, nel campo dell’architettura, alle intuizioni profetiche contenute nell’enciclica Laudato si’, un magnifico testo religioso, ma anche un manifesto culturale e politico».
Un leone e una leonessa (d’oro)
Attribuito alla filosofa statunitense Donna Haraway il Leone d’Oro alla Carriera e all’architetto Italo Rota il Leone d’Oro Speciale alla Memoria della 19ma Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia - Intelligens. Naturale. Artificiale. Collettiva. (Giardini e Arsenale, 10 maggio-23 novembre). La decisione è stata approvata dal Cda della Biennale presieduto da Pietrangelo Buttafuoco, su proposta di Carlo Ratti. La cerimonia di premiazione e inaugurazione della Biennale Architettura 2025 si terrà sabato 10 maggio a Ca’ Giustinian, sede della Biennale di Venezia.