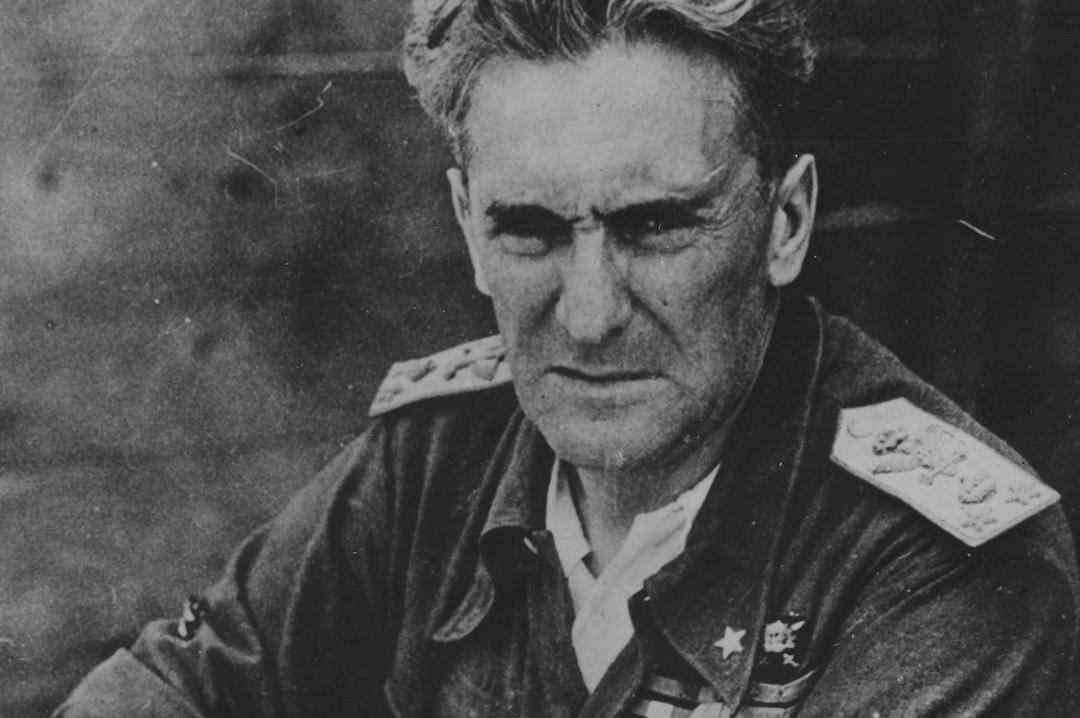Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Edek Osser
Leggi i suoi articoliGabriella Caramore (Venezia, 1945) è stata «profetica» quando, nel 1993, decise di abbandonare le vecchie formule, di innovare radicalmente, raccontare e spiegare al vasto pubblico della radio il significato delle grandi religioni del mondo. Lo ha fatto conducendo per ventitré anni la rubrica di Radio3 Rai «Uomini e profeti». Ma ora affida questo compito ad altri, anche se resterà curatrice del programma. «Uomini e profeti» ha anticipato i tempi per parlare non di religione ma di cultura religiosa, estesa ben oltre l’orizzonte della dottrina cattolica. Per questo ha chiamato ai microfoni esperti laici e religiosi cristiani, induisti, buddhisti, islamici e non solo.
D’ora in poi Gabriella Caramore si dedicherà soprattutto alla scrittura: è già autrice di numerosi libri nei quali ha mescolato filosofia, religione, una forte passione civile e un’infinita curiosità di conoscere. È appena uscito il suo ultimo volume La vita non è il male. «È un libro sul “bene” che ho scritto con mio marito, Maurizio Ciampa, afferma la Caramore. Come mai nel mondo, che sembra dominato dal male, esistono gesti individuali cui possiamo dare il nome di “bene”? Tutta la tradizione filosofica e teologica, da Agostino in poi, si è sempre interrogata sul male. Si è chiesta “unde malum”, perché il male se Dio è il bene? Noi abbiamo cercato di capovolgere il problema, tentando di capire perché nasce e resiste il bene, comunque, anche in mezzo al male: si annida dentro il cuore di ogni essere umano? È possibile agire il bene anche sul piano della polis, della comunità, visto che tutte le grandi ideologie, i grandi sogni e progetti politici sono falliti? Abbiamo cercato di indicare percorsi, di dare tracce e risposte provvisorie».
Che ruolo può avere la religione in tutto questo?
Credo che le religioni nascano da un tentativo di porre riparo al male, oltre che da un grande stupore e desiderio di conoscenza. Però ogni religione si incarna nella storia, nelle istituzioni, ha bisogno dei suoi apparati e così diventa qualcos’altro. Da tutte le grandi religioni possiamo estrarre forti segni di sapienza e di orientamento al bene. La frase «ama il prossimo tuo perché egli è te stesso», attribuita a Gesù, proviene dai libri dell’Antico Testamento ma la troviamo in tutte le grandi tradizioni religiose. Non ti salvi perché sei buddhista, cristiano, indù, ma puoi sperare di salvare qualcosa dell’umano che è in te solo se accogli questo germe di uguaglianza tra tutti gli esseri umani.
Viene da qui il suo sforzo di divulgare senso e storia delle grandi religioni?
Possiamo anche chiamarle «grandi sapienze»: pensiamo ai Veda, alle interrogazioni sulla nascita del mondo, o sul significato della vita umana, esse esprimono lo stupore difronte alla complessità del mondo, alla sorpresa di trovarsi vivi. E in questo ciascuno di esse ha tracciato una strada. E proprio oggi, che viviamo in un’epoca globale, dovremmo cercare di dare la stessa dignità a tutti i percorsi sapienziali. Non perché siano tutti uguali, ma proprio perché le tradizioni sono tante e diverse e dobbiamo guardare anche alle altre con la stessa attenzione con cui guardiamo alla nostra, che del resto neppure conosciamo tanto bene. Quindi bisogna sempre ricominciare da capo, dai testi fondativi delle grandi religioni e dalla loro storia intrisa di bene e di male, di figure belle e orrende, com’è l’impasto umano.
Lei ha tenuto diverse conferenze e ha poi scritto un libro partendo da questa affermazione del Vangelo di Giovanni: «Nessuno ha mai visto Dio». Ma per secoli ci ha pensato l’arte. Attraverso l’arte tutti hanno «visto» e riconosciuto una quantità di immagini di Dio. Com’è stato possibile?
Bisogna distinguere. Il divieto dell’immagine di Dio è un comandamento, anche se nella versione cattolica è stato censurato ed è scomparso. Questo divieto è una «raccomandazione» anti idolatrica: non fate idoli e non adorate «immagini» di Dio. L’arte cristiana ha, in un certo senso, contraddetto questo «comando». Di qui la lotta iconoclasta nei primi secoli cristiani, un’azione più legittima di quanto si creda. Tuttavia gli anti iconoclasti ribadivano che quello che veniva raffigurato non era Dio ma la figura umana del Cristo. L’immagine di Dio è stata poi risolta in maniera a volte goffa con un volto barbuto, un occhio dentro un triangolo ecc. Nelle icone ortodosse, più rispettose della tradizione, infatti non c’è mai l’immagine di Dio, ma solo quella del Cristo.
Comunque l’arte ha avuto un ruolo importante, didattico e «propagandistico» nel rappresentare per immagini la storia e le storie della religione.
Era la «Bibbia dei poveri». Grandi narrazioni, volute dai committenti, ma attraverso le quali il talento degli artisti ha fatto passare sottili e molteplici interpretazioni, a volte molto potenti. Tutto è stato trasmesso dalla volontà dei committenti, dalla Chiesa e dal talento degli artisti. E vi sono state anche interpretazioni fuorvianti come sul tema della resurrezione, con immagini a volte molto forti, molto potenti. Penso al «Compianto sul Cristo morto» di Matthias Grünewald, dove c’è un corpo martoriato, lebbroso, livido che rivela una morte definitiva, senza resurrezione.
Lo stesso avviene nel «Cristo morto» di Hans Holbein, un capolavoro ma anche qui un cadavere in putrefazione.
Osservando questo quadro Dostoevskij ha scritto «c’è da perdere ogni fede». Sul tema della resurrezione invece i pittori hanno lavorato di fantasia: i Vangeli non descrivono nubi né immagini straordinarie. Ma ci sono altre narrazioni per immagini nelle quali piccoli particolari, una luce, un colore, possono essere indicativi e forti come una parola. Dipende dallo spirito del tempo e dal talento dell’artista.
Proprio l’artista è da sempre indicato come un «creatore».Non le pare che questa parola possa avere un significato ambiguo?
No, è bella. Creare, inventare, dare forma a qualcosa che non ha forma, mettere il proprio pensiero, la propria arte, le proprie parole per dare espressione al nuovo è una bella immagine del creare. Ed è forse, lo dico senza enfasi, il compito dell’umano.
La religione si è mescolata all’arte, ha incrociato e ha condizionato la creatività degli artisti. Secondo lei l’ha anche favorita?
La religione è entrata nel linguaggio degli artisti a seconda della fase storica che si sono trovati a vivere. Quando la visione religiosa era il linguaggio dominante, ogni artista ha elaborato la propria capacità in relazione a questo. Dipingere è pensare con la materia. Come il poeta pensa con le parole l’artista pensa con la materia del colore, delle luci e delle ombre, e ovviamente delle storie che vuole rappresentare. Antonello da Messina dipinge una vergine misteriosa con un velo azzurro e la mano che lo tiene fermo. Certo, c’è la religione: certo, il soggetto è religioso, ma in quel quadro Antonello racconta la storia di una ragazza che contiene un mistero, qualcosa di più grande di lei, una ragazza semplice, umanissima.
E l’arte contemporanea, la conosce, le interessa, che cosa ne pensa?
Mi riesce un po’ difficile parlare di quella di oggi. Oggi forse mi incanta di più la grande e innovativa architettura che si produce nel mondo. Per la pittura non mi spingo oltre il ’900. Amo molto Rothko per esempio, che conserva nei suoi quadri le ombre e le luci dei Paesi baltici da cui proveniva. Racconta la potenza e la fragilità della luce, il buio e i bagliori della ragione. In alcuni artisti tutto è essenziale, meno narrativo, la densità della materia si fa maggiore, si fa carne. Il buio è davvero buio, la linea di luce è una linea di luce. Per restare al ’900, sarà scontato ma mi affascina Morandi. Ha raccontato come restava davanti a quelle bottiglie per ore, le dipingeva e ridipingeva. Fuori c’è la guerra, la devastazione, e lui, nel suo studio, salva qualcosa dalla distruzione: la memoria di un oggetto, di una polvere, di una luce bianca. In questo c’è anche l’idea della «pazienza», come nota Philippe Jaccottet. Anche Twombly mi incanta: è lontano da ogni idea religiosa ma rappresenta sogni sparsi, segni leggeri, lettere, fiori, salva qualcosa nel suo pensiero perché rimanga un «piccolo soffio» dell’umano.
Sembra che lei interpreti le immagini attraverso il filtro del suo ricco bagaglio di altre conoscenze.
Sì, restando al ’900 mi colpisce, per esempio, Giacometti: l’uomo che cammina, con fatica, con le spalle curve come camminava lui, inclinato in avanti, un omino solitario che sembra portare sulle spalle il peso del mondo. Per me incarna la solitudine dell’uomo contemporaneo, dove Dio è lontano. Oppure pensiamo alla scultura di Brancusi, quei marmi levigati nei quali non si trova espressione ma solo materia: spiegano però l’essenza della vita umana. Sono grandi letture, anche inconsapevoli, in chiave teologica perché ci mostrano la pochezza, la miseria dell’essere umano sulla terra ma anche la sua potenziale bellezza.
La Chiesa cattolica sta tentando di riproporre la possibilità di una sua committenza artistica, interrotta da oltre cent’anni. Nelle ultime due Biennali di Venezia c’era un Padiglione Vaticano. Che cosa ne pensa?
C’è un tentativo di far recuperare alla Chiesa una lunga stasi. Quando il cardinale Martini diceva: «La Chiesa è indietro di 200 anni», ma si potrebbe parlare anche di 400, voleva dire che si è fermata e irrigidita e, pur avendo avuto tanti fermenti positivi al suo interno, non ha seguito l’andamento del mondo, le sue esigenze, le sue domande. Anche dall’elaborazione artistica la Chiesa è rimasta lontana. Questo tentativo è positivo e molto interessante, ma non so se sia destinato a dare frutti. Il mondo oggi esige un approccio diverso anche alla religione. Siamo di fronte a una trasformazione profondissima dello stesso pensiero, a una riflessione sulle scienze inimmaginabile prima e di conseguenza anche a un nuovo linguaggio dell’arte. Mi chiedo se la Chiesa, con il bagaglio che si porta appresso, sia capace di trasformare se stessa e mi chiedo anche se questo sia il suo compito. Papa Francesco sta riportando le parole della Chiesa alla essenzialità del Vangelo, cioè al soccorso degli altri, al primato dell’altro, a mettere in primo piano chi ha fame, chi vive senza libertà, nell’ingiustizia. Se questo è il nucleo del Vangelo, allora la Chiesa fa già molto. Il resto, il linguaggio, seguirà.
Altri articoli dell'autore
Il mausoleo dedicato al «più sanguinario assassino del colonialismo italiano» appena fuori Roma è criticato da molti, ma rimane
Si dà la precedenza agli oggetti per cui sono arrivate le richieste dagli etiopi, per ora senza grandi successi
L’eccidio e saccheggio di Debre Libanos in Etiopia fu «il più grave crimine dell’Italia». Oggi con difficoltà si cerca di rimediare all’«amnesia collettiva» che ha cancellato la memoria dell’ordine di sterminio illimitato per il quale il colonialismo italiano si macchiò dell’infamia più vergognosa. Ora si impone la complicatissima ricerca di opere e oggetti razziati o ricevuti in dono, andati dispersi. Dove sono?
Era il marzo 1974 quando dagli scavi della necropoli sarda affiorarono 16 pugilatori, 6 arcieri e 6 guerrieri: 44 sculture in frammenti. Stanziati ora 24 milioni di euro per nuovi cantieri e ricerche nella penisola del Sinis