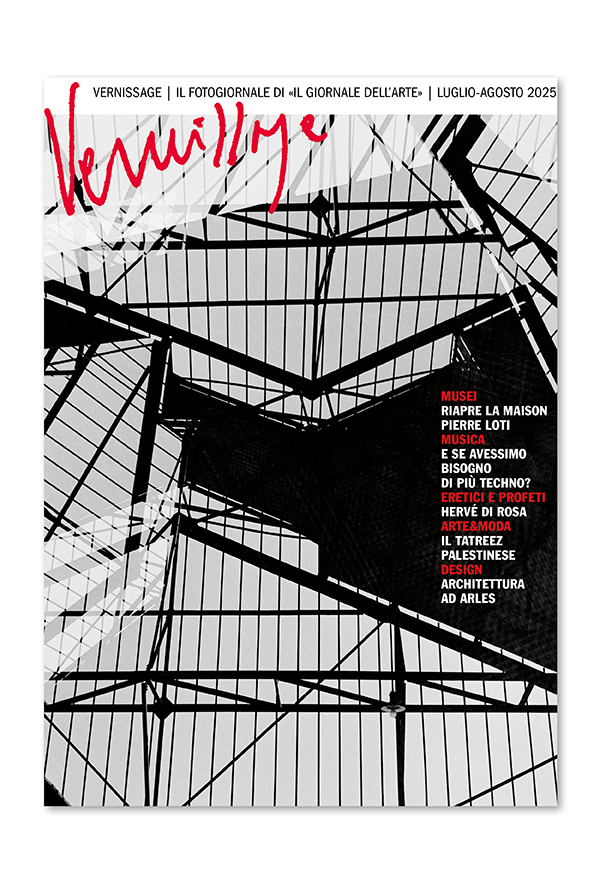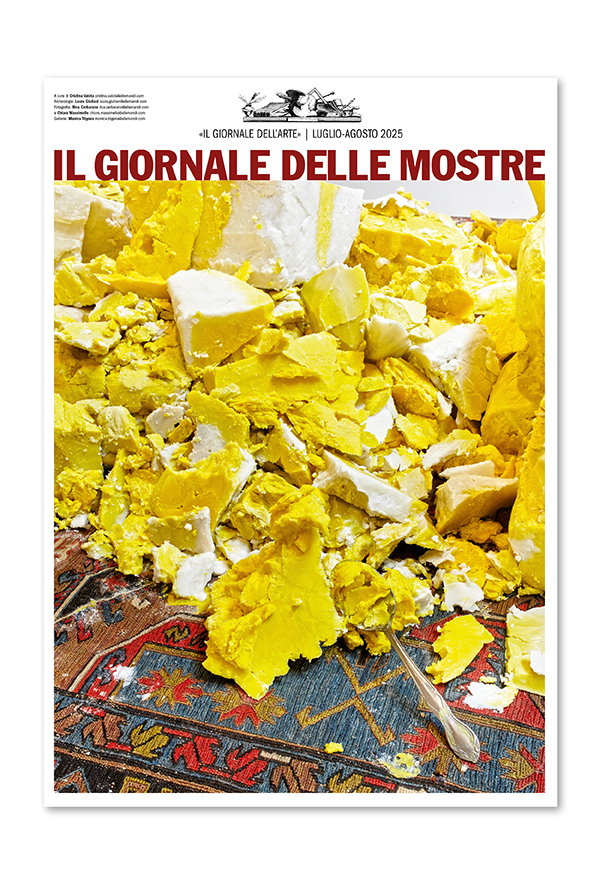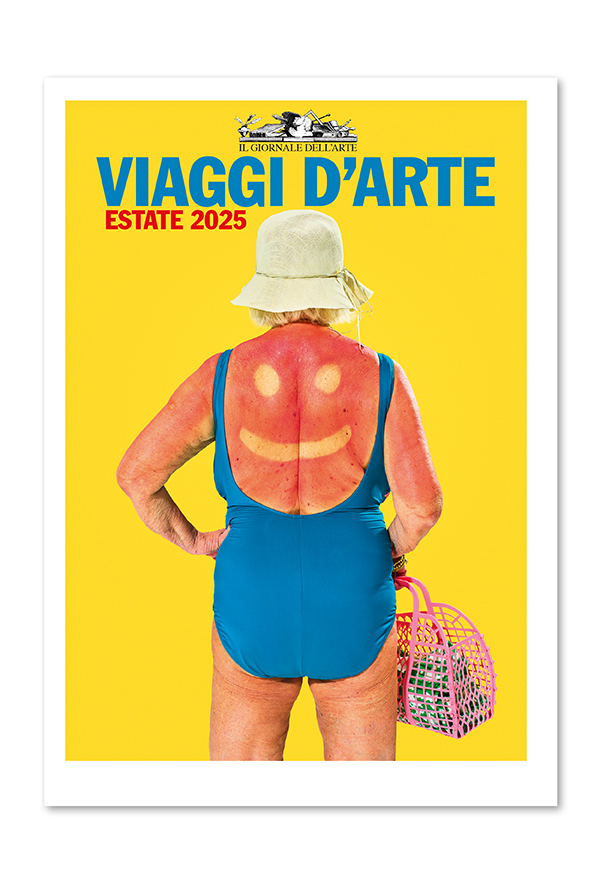Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Rosalba Cignetti
Leggi i suoi articoliMartedì 8 luglio 2025, i visitatori dell’Acropoli di Atene hanno trovato i cancelli chiusi. Dalle 13 alle 17 l’accesso al sito archeologico è stato interdetto per motivi di sicurezza legati all’ondata di calore che ha investito la Grecia con temperature superiori ai 42 °C. La misura, confermata anche per il giorno successivo, è stata annunciata dal Ministero della Cultura nell’ambito di un pacchetto di emergenza che comprendeva il divieto di lavoro all’aperto nelle ore più calde e la chiusura temporanea di altri siti storici, tra cui Messene, Dodona e le rovine di antiche città nella Macedonia centrale (Reuters). «Una decisione necessaria, hanno commentato le autorità, di fronte a un’emergenza sempre meno episodica e sempre più sistemica. I funzionari della Protezione Civile hanno inoltre predisposto squadre per monitorare il rischio incendi in aree vicine ad Atene, mentre si valutano restrizioni ulteriori per i giorni a venire». Non si tratta di un caso isolato, ma di un campanello d’allarme ricorrente. Già nelle scorse estati, l’Acropoli era stata chiusa per più giornate consecutive. Secondo l’UNESCO, circa il 17% dei siti culturali e naturali Patrimonio dell’Umanità sta già facendo i conti con gli effetti del cambiamento climatico. Tra questi, molti sono luoghi esposti a fenomeni estremi sempre più frequenti: innalzamento del livello del mare, incendi, desertificazione, piogge torrenziali e sbalzi termici che danneggiano materiali millenari e compromettono l’integrità strutturale delle rovine e rendono più difficile ogni intervento conservativo. Una buona parte è concentrata nel Mediterraneo, considerato un hotspot climatico, dove il 60% dei siti ha segnalato rischi legati all’innalzamento del livello del mare (whc.unesco.org). In Grecia, l’antico sito di Olympia era stato colpito nel 2007 da un devastante incendio che lambì il museo e l’area archeologica. Da allora, è stato attivato un piano di monitoraggio con squadre permanenti dei vigili del fuoco durante l’estate. Ma l’aumento delle temperature e la maggiore imprevedibilità dei fenomeni meteorologici rendono tutto più fragile. Nell’estate 2025, la chiusura dell’Acropoli è stata accompagnata da un provvedimento straordinario, che ha vietato il lavoro all’aperto tra mezzogiorno e le 17 per operai, corrieri, addetti ai cantieri.
Nel frattempo altri siti nel mondo subiscono le conseguenze, spesso silenziose, del riscaldamento globale. In Perù, le piogge torrenziali legate al fenomeno del Niño stanno minacciando le strutture in adobe di Chan Chan, città precolombiana patrimonio mondiale. In Svezia, il sito mesolitico di Ageröd, perfettamente conservato per millenni nelle torbiere, si sta deteriorando a causa dell’abbassamento delle falde acquifere. In Canada, centinaia di siti costieri delle Prime Nazioni sono esposti all’erosione per via dell’innalzamento del livello del mare, mentre nell’Isola di Pasqua l’erosione delle scogliere mette a rischio i moai, le iconiche statue in pietra basaltica che rischiano di franare in mare. Come riportava il New Yorker già nel 2016, «il patrimonio culturale globale è tra le vittime più tangibili della crisi climatica».

Olimpia, Grecia
Talvolta è successo che la crisi climatica abbia anche contribuito a rivelare ciò che era sepolto da millenni: siccità straordinarie come quelle verificatesi tra Tigri ed Eufrate hanno fatto riemergere interi insediamenti antichi in Iraq (l’antico palazzo di 3.400 anni riemerso in corrispondenza della diga di Mosul) e in Siria (dove sono invece venuti alla luce diversi siti archeologici risalenti fino a 11.000 anni fa). Ma questa esposizione improvvisa e non controllata accelera la decomposizione di materiali organici, poiché spesso non ci sono fondi, né personale, né tempo per intervenire tempestivamente. Di fronte a questo scenario sono intervenute alcune istituzioni. L’Università di Cambridge ha avviato modelli predittivi per valutare l’impatto climatico sui siti marittimi europei (cambridge.org), mentre la Canadian Archaeological Association ha elaborato linee guida per la protezione di siti in aree artiche, zone umide e litorali in erosione (canadianarchaeology.com). Anche in Grecia è stato avviato nel 2024 un programma di mappatura delle vulnerabilità nei siti archeologici principali, con sensori ambientali, piani antincendio e protocolli di chiusura automatica in caso di superamento delle soglie di rischio (intarch.ac.uk).
E lo stesso succede anche nelle altre parti del mondo, un esempio il villaggio di Bahaj, distretto di Deeg (Rajasthan), un sito archeologico scoperto di recente, con reliquie di età paletolitica e dell’età del rame e del ferro, messo a serio rischio a causa delle piogge monsoniche e dell’assenza di adeguate protezioni. Le fosse di scavo, profonde fino a 23 metri e non adeguatamente ricoperte, sono a rischio erosione, tracimazione e danneggiamento irreversibile delle stratigrafie (Times of India).
Senza dimenticare, infine, la vulnerabilità dovuta a eventi geologici come i terremoti. Sempre i Grecia, tra i più recenti, la serie di scosse sismiche con magnitudo di circa 5,3 iniziata il 7 giugno 2025, che ha coinvolto i monasteri del Monte Athos, enclave sacra dell’Ortodossia, provocando danni strutturali a tra cui Xenophontos, Dochiariou e Simonopetra, nel Monastero di Xenophon, per esempio, ha causato crepe nel soffitto a cupola e danni ad affreschi secolari, per le quali le autorità hanno già annunciato interventi di consolidamento e restauro coordinati dal Ministero della Cultura greco (AP News).

Bahaj, distretto di Deeg (Rajasthan)

Monasteri del Monte Athos
Altri articoli dell'autore
È morto oggi nella sua casa di Water Mill, a New York, all’età di 83 anni, il regista teatrale, scenografo, artista visivo e fondatore del Watermill Center
Il CEO di LVMH sostiene l’intesa UE-USA sui dazi. È in gioco non solo il business del lusso, ma anche l’ecosistema creativo e culturale europeo
Messa in vendita a febbraio, fu per cinque anni la dimora e lo studio di Wright, dove la spirale del Guggenheim prese forma tra incontri, disegni e ospiti celebri da Marilyn Monroe al re Faisal II d’Iraq
Dalla gestione di opere e clienti alle vendite online, la fusione tra Artlogic e ArtCloud dà vita a un’unica piattaforma pensata per digitalizzare il lavoro quotidiano di gallerie, artisti e collezionisti