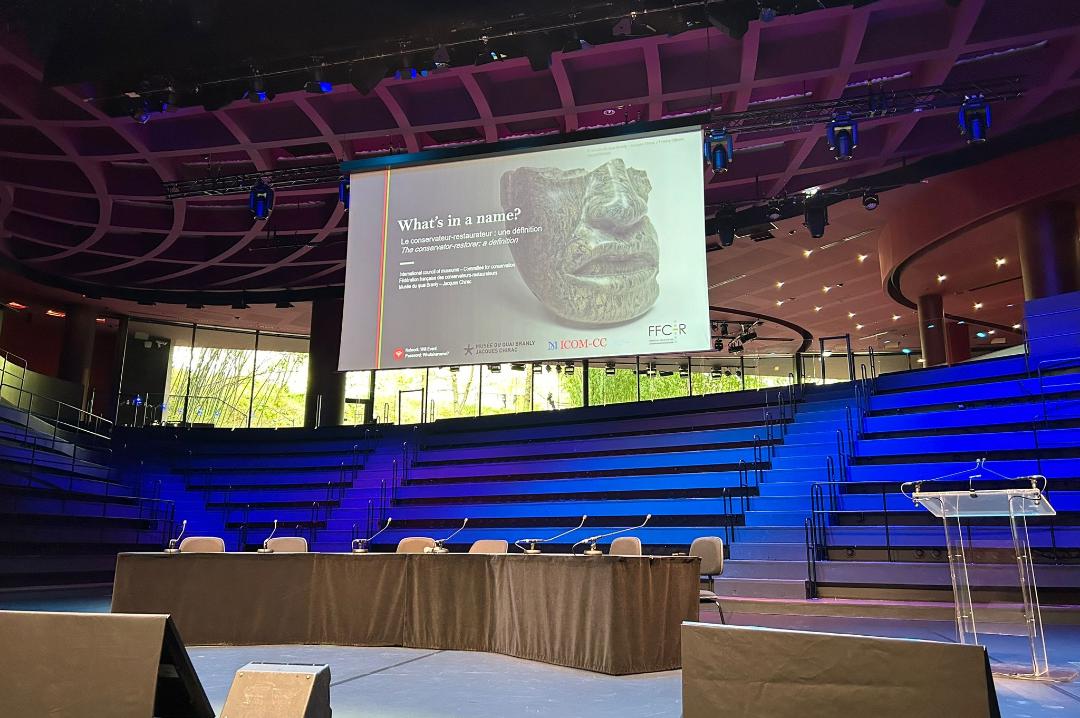Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Simona Sajeva
Leggi i suoi articoliRoma. La notizia è nota ed è stata ripresa sia dai media sia dalle associazioni di rappresentanza della categoria, che hanno immediatamente reagito: il Dpcm del 26 aprile, previa consultazione anche del Mibact, ha stabilito che il 4 maggio i cantieri di restauro non avrebbero potuto riaprire, i cantieri edili sì.
Grazie alle pronte reazioni delle associazioni di categoria (si veda la disamina nella lettera aperta del 29 aprile, che la presidente Silvia Mangionello dell’associazione La Ragione del Restauro ha indirizzato al ministro dello Sviluppo economico), il Governo in data 2 maggio ha precisato che le attività di restauro di opere d’arte (quadri, affreschi, sculture, mosaici, arazzi e beni archeologici) sono riconducibili al restauro di edifici storici e monumentali, dell’industria del legno, di architettura, ingegneria, collaudo e analisi tecniche e altre attività professionali, scientifiche e tecniche nonché alle riparazioni di beni mobili. Quindi non più riconducibili a profili ricreativi o artistici, come in un primo tempo.
Scampato il pericolo, almeno così pare, approfittiamo invece di questa situazione per riflettere sull’effettiva percezione della professione di «restauratore». In tale circostanza l’attività di restauro (ad eccezione di alcuni codici Ateco, una combinazione alfanumerica che identifica un’attività economica da cui la sigla «Ateco», che si prestano a interpretazione) è stata assimilata alle attività creative, artistiche e di intrattenimento, per le quali l’imminente linea di partenza della Fase 2 resta preclusa, risultando quindi disgiunta dal comparto edile.
Questa situazione però non aveva sorpreso più di tanto gli addetti ai lavori che ben sanno che i codici Ateco sono solo la superficie di una situazione ben più profonda. Focalizziamo però l’attenzione sui restauratori che il decreto aveva marginalizzato, ovvero quelli il cui oggetto d’intervento coincide con quello del settore edile: l’edilizia storica. Superfici decorate dell’architettura, pitture murali, stucchi, mosaici e rivestimenti lapidei, per citarne alcuni, sono tutti elementi d’interfaccia dell’edilizia storica.
Giova ricordare che i restauratori sono professionisti oggi obbligatoriamente formati almeno con un corso di studio universitario magistrale di cinque anni, e in precedenza formati da ben più lunghi percorsi di studio e pratica. È già quindi prevista una formazione di base in materia di sicurezza poiché, oltre alla prassi di cantiere, la professione prevede l’uso di attrezzature e sostanze potenzialmente pericolose.
Difatti, i restauratori sono abitualmente formati all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, ora previsti per la protezione da Covid-19. Senza tralasciare il fatto che i restauratori sono l’unica figura a intervenire nell’ambito dell’edilizia storica che è abilitata sia alla progettazione che alla materiale esecuzione dei lavori. Ovvero i restauratori ben formati conoscono in dettaglio i rischi legati alla pratica di cantiere e sono perfettamente in grado di integrare opportuni protocolli, di protezione individuale, distanziamento e smaltimento di residui tossici.
Allora, com’è stato possibile autorizzare un settore e non l’altro? L’origine di questa situazione, oltre che nelle varie classificazioni di categoria d’attività (codici Ateco), va cercata anche nella percezione del restauro come una professione «artistica» e non come una professione tecnico scientifica, quale oggi è. Si tratta di un retaggio ottocentesco, che vede il restauratore come un misto di artista artigiano, sempre da intendersi con accezione romantica, quindi impreparato al recepimento e all’applicazione di precisi protocolli di sicurezza. Inoltre, e torno su un concetto che ritengo centrale, l’oggetto, l’opera, è unico: l’edificio.
Finché si continuerà ad approcciare l’oggetto in maniera compartimentata, quasi bipolare, mettendo da una parte l’architettura e dall’altra le decorazioni, non se ne vedrà l’organicità e la conseguente interdipendenza materiale, quindi gestionale e amministrativa, con il relativo bisogno di intersettorialità e di compresenza. Parlando di organicità, volendo traslare il ragionamento al campo della medicina, è come se il Dpcm avesse detto: ortopedia sì, dermatologia no.
Altri articoli dell'autore
La conferenza internazionale sulla conservazione delle pitture murali «Exciss» si è tenuta a Valencia pochi mesi dopo la tragica alluvione, studiata per capire che cosa si poteva evitare e che cosa si poteva fare di diverso nel gestire l’emergenza
A Lione quasi 2mila partecipanti al 36mo Congresso mondiale del CIHA, la più antica organizzazione internazionale di categoria
Intervista all’avvocato Pietro Celli che ha seguito la procedura presentando il ricorso che ha sbloccato la situazione di stallo, durata otto anni
A Parigi una conferenza sulla professione, codificata nel 1984, ma oggi