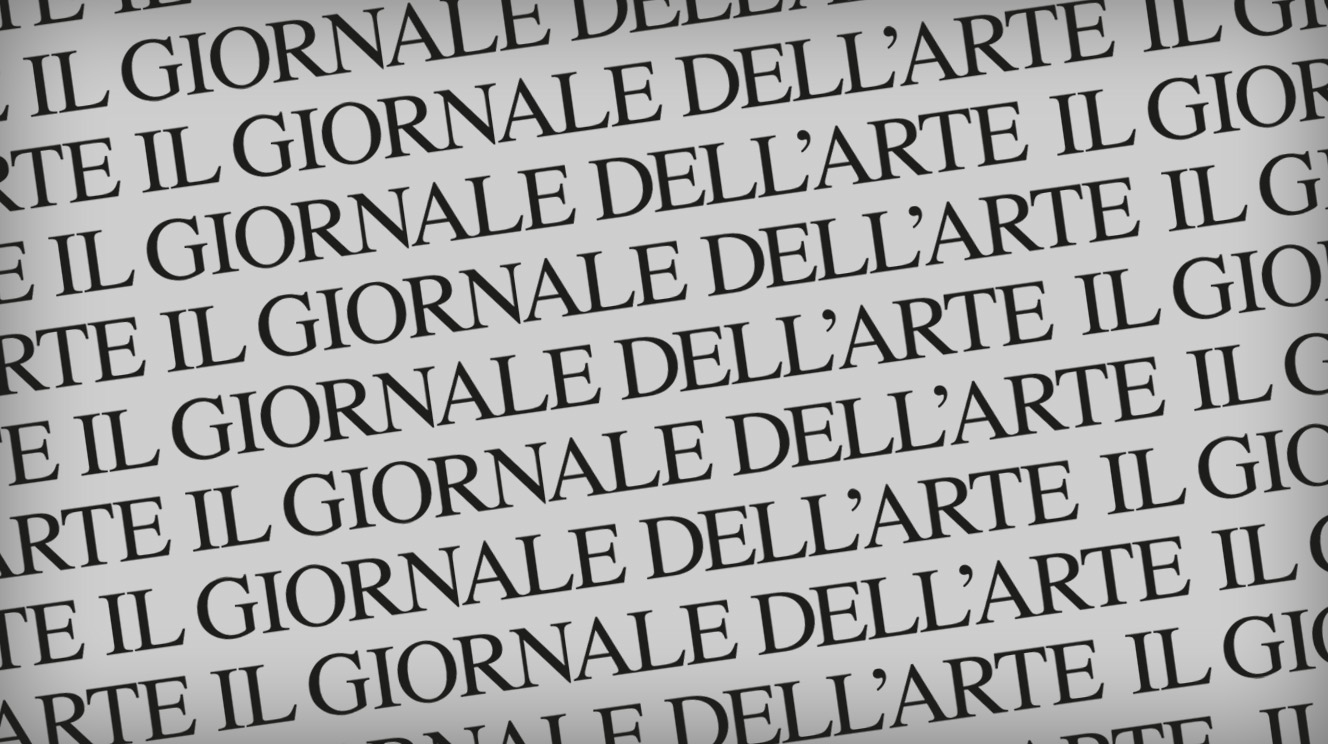Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Redazione GDA
Leggi i suoi articoliQuel che deve interessare di un’opera d’arte è l’essenza formale del messaggio, non il suo contenuto
Si dice che Robert Schumann avesse affermato un giorno: «Quando cesserà, il pubblico, di chiederci cosa abbiamo espresso con le nostre composizioni musicali?». In effetti, partendo dall’affermazione idealistica e neoidealistica che «l’arte è sempre parola» (Roberto Longhi docet), si ricerca un significato logico, verbalmente esprimibile, anche nelle composizioni musicali e nelle immagini, fino ad arrivare al parossismo di interpretare l’incipit della V Sinfonia di Beethoven, detta «Sinfonia del Destino», con un «Sono il destin, lasciami entrar!» (ma con questo siamo al ridicolo). Peraltro, nell’arte concettuale l’artista si propone di esprimere un concetto attraverso un’immagine e in questo caso la ricerca di quel che ha inteso veicolare è certamente legittima se non addirittura obbligatoria.
Partiamo allora da un esempio emblematico appunto di arte concettuale. Nel 1972, alla Biennale di Venezia, Gino De Dominicis espose, in un angolo della sala a lui riservata, un mongoloide in carne e ossa, seduto su una sedia, con la scritta, posta avanti a lui, «Seconda soluzione di immortalità (l’universo è immobile)». Una risata di scherno, proveniente dall’alto e ripetuta da un megafono, completava la performance, certamente suggestiva sotto il profilo visivo.
L’opera, ovviamente, suscitò scandalo: un ufficiale del non più Regio Esercito reagì clamorosamente, vedendo nell’opera una sorta di dileggio per un incapace. La famiglia di questi reagì, sporgendo querela per sottrazione di incapace alla patria potestà (art. 574 c.p.): si sostenne che Gino avesse carpito, assieme a Simone Fortis, che lo aveva aiutato nell’impresa, il consenso dei genitori, affermando che il figlio sarebbe stato ripreso cinematograficamente e non oggetto di pubblica esposizione. Ne nacque un processo avanti al Tribunale di Venezia, nel quale assunsi la difesa dell’artista e che si concluse il 12 aprile 1973, con una sentenza di piena assoluzione. La strategia processuale che adottai era quella della libertà dell’artista, espressione della libertà di manifestazione del pensiero, consacrata nell’art. 21 della Costituzione. Tale libertà presupponeva che il giudice non potesse controllare e quindi sindacare quel che l’artista aveva voluto esprimere in forme poetiche.
In quest’ottica, quel che interessava era l’essenza formale del messaggio, non il suo contenuto, certamente opinabile e comunque sottratto al controllo giurisdizionale. Rammento che mi riferii, nella mia arringa, al memorabile processo per oscenità contro Gustavo Flaubert per il suo capolavoro Madame Bovary, processo che si svolse a Parigi nel 1857 per iniziativa di un procuratore della Repubblica, tale Ernest Pinard, castigatore dei costumi (pochi anni prima, aveva allestito un processo analogo contro Beaudelaire per Les Fleurs du Mal, che si concluse con sette «pièces condamnées»). Come risultò successivamente Pinard era autore anonimo di poesie oscene e la vicenda è singolarmente vicina a un altro castigatore di costumi dei nostri giorni, un magistrato siciliano che incriminava le donne in «hot pant», «con i glutei visibili» e poi venne «colto con le mani nel sacco», per proposte oscene da lui fatte a Cicciolina, incontrata in uno spettacolo televisivo, ove erano entrambi oggetto di intervista. Ma torniamo a Flaubert: egli venne trionfalmente assolto, dopo una splendida arringa pronunziata in sua difesa da Jules Senard, ex ministro dell’Interno, in nome già allora (era l’epoca del Secondo Impero, borghese e clericale) della libertà della creazione artistica.
Neppure chiesi a Gino quale fosse il significato della sua opera: non volevo farmi contaminare da pregiudizi contenutistici. Ma pochi giorni orsono, sulle rive del Lago di Bracciano, il significato dell’opera mi è stato richiesto da un’illustre contemporaneista, Simonetta Lux, che proprio in questi tempi sta indagando, assieme ad Alessandro Zuccari, sul rapporto tra arte e (usiamo questo termine «politically correct») disomogeneità: in altri termini, l’arte dei «diversamente normali». Alla domanda io ho risposto che, a mio avviso, con l’esposizione del mongoloide Gino intendeva esprimere che questi, privo di una consapevolezza razionale della morte, supera ed esorcizza il mostro incombente sulle sorti umane, dal quale non ci si ripara neppure fuggendo nell’Arcadia («Et in Arcadia Ego» è scritto infatti sotto un teschio, simbolo della morte, in due capolavori pittorici del Seicento europeo, rispettivamente di Guercino e di Poussin). Simonetta Lux invece mi propose una lettura più complessa, ispiratagli da un dialogo con un sodale di Gino De Dominicis, che ne aveva parlato con l’autore. Il disabile, il mongoloide, il deforme rappresentano una frattura del creato, una violazione del codice di riproduzione, alla base della sostanziale uniformità di tutti gli umani. È ignoto se la frattura sia voluta dal Creatore o sia un accidente del processo creativo. La risata che risonava, sinistramente, sopra all’ignaro mongoloide esposto alla Biennale, farebbe propendere per la prima ipotesi: chi, se non un Dio, cattivo e maligno, potrebbe prendersi gioco di una propria creatura? Ma resta da spiegare perché l’errore nella creazione possa porre il creato al di fuori della morte.
Lucio Fontana pensò che nulla potesse meglio esprimere l’idea dello spazio cosmico di un buco o una frattura (taglio) inseriti in una superficie campita a un solo colore. Si potrebbe pensare, allora, che l’errore nel processo creativo possa infrangere il tabù della morte. È una possibilità.
Certo è, comunque, che Gino De Dominicis, in tutta la sua esperienza artistica, è stato ossessionato dall’idea dell’immortalità, al punto di immaginare, come scrive Fabio Sargentini (Gino De Dominicis l’Immortale, a cura di Achille Bonito Oliva, Cat. MaXXI, 2010, p. 85) una performance per la propria morte «avvolta nel mistero, tanto da far pensare a una lucida regia, ad un’estrema macabra installazione».
Altri articoli dell'autore
L’Associazione archeologi del Pubblico Impiego (Api-MiBact) ha inviato una nota al Ministero della Cultura e a quello della Funzione Pubblica, nonché ai membri delle Commissioni cultura di Camera e Senato, per esprimere il proprio dissenso per il bando per 75 posti nell’area dell’elevate professionalità (Ep), le cui domande di partecipazione vanno presentate entro il 26 giugno
Il premio Nobel e il direttore del Museo Egizio si sono incontrati per parlare di musei e romanzi: «Sono simili: sono i “luoghi” in cui avviene l’interpretazione del significato della nostra vita, nei quali riflettere su sé stessi»
Anche quest’anno Tag Art Night, la Notte delle Arti Contemporanee, propone un palinsesto di mostre diffuse sul territorio cittadino
Rimodulate le competenze e modificato la struttura organizzativa: dal Segretariato generale al modello dipartimentale