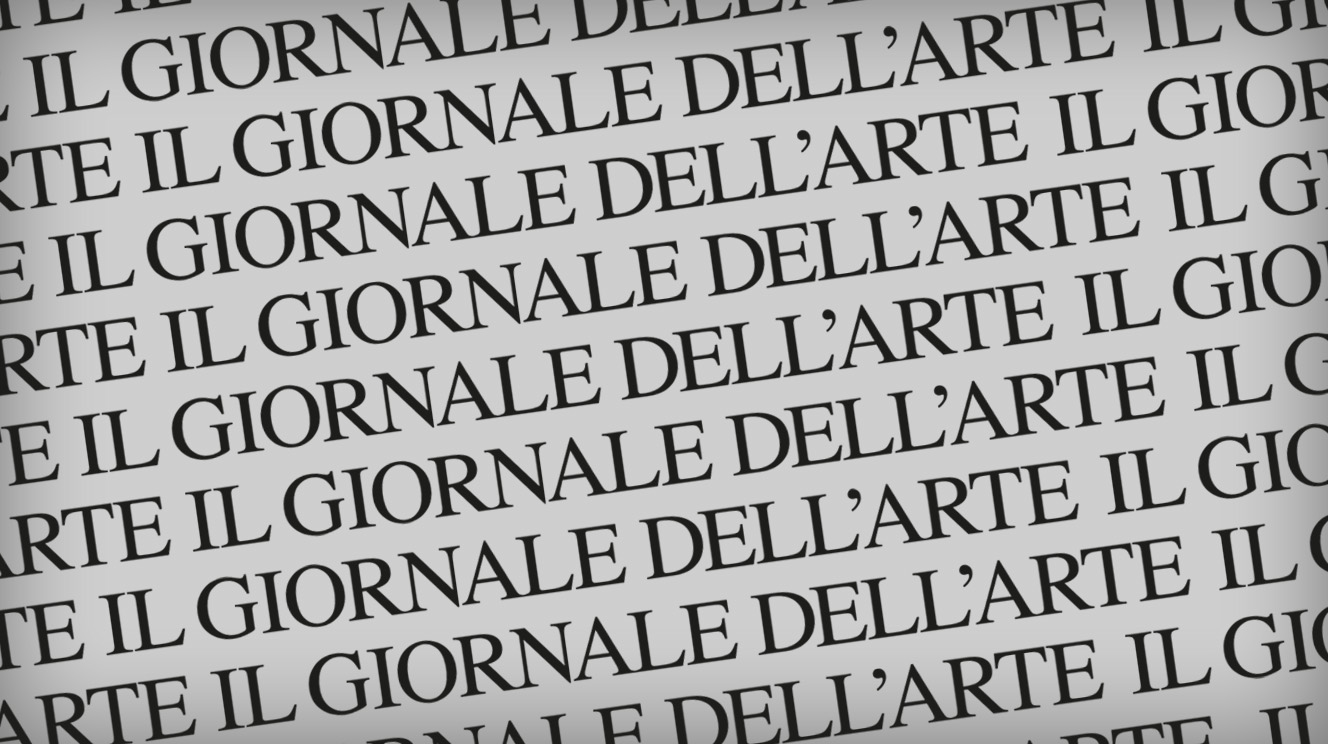Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Redazione GDA
Leggi i suoi articoliCon sempre maggiore frequenza, anche in Italia, i musei e le organizzazioni culturali si interrogano sulla possibilità di misurare e rendere espliciti i benefici di natura culturale, sociale ed economica che a vario titolo possono riverberare sui territori. Si tratta di un’aspirazione lodevole e affascinante e che la crisi ha reso ancora più necessaria e urgente, sia perché sposta l’analisi dall’oggetto in sé ai suoi possibili effetti, sia per le sfide metodologiche che pone.
Il recente dibattito sul ruolo della cultura nel contribuire allo sviluppo sociale ed economico del nostro Paese (anche in termini di apporto intellettuale e visionario nel ripensarne i modelli e i paradigmi), nutrito da amletici quesiti in merito alla possibilità di poterci «mangiare» (con la cultura), sta avendo il merito di richiamare l’attenzione sulla necessità di disporre di dati e di «prove» a sostegno delle molteplici ed eterogenee posizioni. Come diceva Oscar Wilde, le domande non sono mai indiscrete, lo sono talvolta le risposte; nell’ambito dei musei occorre ora uno slancio generoso per vincere reticenze e inerzie tenaci, mettendosi nella condizione di rispondere ad alcune domande di fondo: quali valori sono inscritti in quello che i musei sono e quali valori sono generati da quello che i musei fanno? Come adoperarsi per renderli entrambi espliciti e misurabili?
A livello internazionale, già da alcune decadi ci si sta interrogando sui valori che più pertinentemente possono essere connessi all’idea e al ruolo del museo contemporaneo e si stanno sperimentando metodologie e tecniche per misurarne e valutarne gli impatti. Le risposte, ovviamente, variano a seconda delle politiche e della temperie culturale dominante. Se negli anni ’80 del Novecento l’enfasi era posta principalmente sugli impatti economici (misurati come generazione di ricchezza e di posti di lavoro), e successivamente l’attenzione si è spostata su quelli di natura sociale (si pensi, ad esempio, all’approccio anglosassone del periodo labour di fine anni ’90 in cui la cultura veniva valutata anche per la sua capacità «strumentale» di risolvere problemi di natura sociale), il presente sembra caratterizzato da una tendenza a considerare il valore della cultura come qualcosa di più complesso, olistico e multidimensionale. Interessante, da questo punto di vista, una recente pubblicazione dell’Associazione dei Musei olandesi che sostiene che i musei possono diventare davvero rilevanti per la società (usano il concetto di «social significance») se sono in grado di dispiegare cinque tipologie di valore: il valore della collezione, il valore della connessione, il valore educativo, il valore esperienziale, il valore economico. Appare quindi evidente come da una pluralità di valori derivino diverse possibilità di impatto e ancor più numerose metodologie di indagine e calcolo.
L’impatto economico e il significato sociale
Se si prendono in considerazione gli studi sugli impatti museali, si può distinguere tra impatti economici e impatti socio-culturali. I primi riguardano differenti possibilità di concepire e misurare il valore economico dell’istituzione in relazione alla sua esistenza e al suo uso da parte di diverse categorie di stakeholder. I diversi contributi all’economia di un territorio possono essere espressi in forma di occupazione e forza lavoro, economia addizionale derivante dalla spesa dei visitatori, rafforzamento del brand e della capacità attrattiva dei territori, effetti moltiplicativi sui redditi e sulle vendite, rigenerazione urbana e rivalutazione immobiliare, valore derivante dalla semplice esistenza di un bene culturale.
Il Museum of Fine Arts di Boston (Mfa) ha condotto uno studio per quantificare e dimostrare il ruolo giocato dall’istituzione nell’economia della città e dell’intero Massachussetts prendendo in considerazione i molti flussi monetari che il museo genera quando entra in relazione con i cittadini, il sistema turistico, le aziende private, il settore commerciale e l’ambito educativo. Sono stati stimati, inoltre, gli effetti di lungo termine connessi al miglioramento dell’attrattività urbana e della vitalità culturale e creativa. Lo studio ha quantificato, per il 2011, in 369 milioni di dollari (272 milioni di euro) il contributo all’economia del Massachussetts, in 73 milioni (54 in euro ca) la spesa dei turisti a beneficio della città e in 11 milioni (8 in euro ca) le maggiori tasse locali generate dall’esistenza del museo.
Diverso l’approccio adottato, invece, dai musei della città britannica di Bolton, poco lontana da Manchester, che hanno scelto la tecnica della «Contingent Valuation» per dimostrare il valore del settore museale e bibliotecario nell’economia locale. La ricerca ha coinvolto gli utenti del museo, ma anche i non utenti, per quantificare sia il valore d’uso sia quello legato alla sua esistenza: il presupposto è che le persone possano attribuire un valore (anche economico) a un bene culturale indipendentemente dal fatto che ne beneficino direttamente, ma in relazione alla sua semplice esistenza e alla capacità di generare utilità e significati sociali, identitari e simbolici per altre persone e per le future generazioni. Il valore complessivo è stato stimato in 10,4 milioni di sterline (12,4 milioni di euro ca) di cui 7,4 (8,8 in euro ca) derivanti dal beneficio diretto e circa 3 milioni (3,5 in euro ca) dal valore indiretto indicato dai non utenti. L’aspetto interessante è stato che le fasce sociali meno abbienti sono quelle che hanno attribuito i valori più elevati.
Il benessere collettivo e lo sviluppo personale
Gli impatti sociali e culturali sono generalmente più difficili da definire e da misurare anche perché la loro definizione varia a seconda dei contesti nazionali e dei soggetti che promuovono la valutazione. Da un lato, si osserva la tendenza a restringere il significato di impatto sociale agli effetti che le organizzazioni culturali generano quando si attrezzano per affrontare e risolvere necessità e fabbisogni di natura collettiva e sociale (si pensi, ad esempio, ai temi della rigenerazione sociale, della coesione sociale, della lotta all’esclusione, alla salute e al benessere delle comunità). Dall’altra, tali impatti attengono alla dimensione educativa, allo sviluppo personale, al capitale culturale e creativo delle persone quando entrano in connessione con le molteplici e sfaccettate attività del museo. Citando l’urbanista inglese Charles Landry, potremmo definire gli impatti sociali come «quegli effetti che vanno oltre l’esperienza dell’oggetto o dell’evento in sé, e che determinano un’influenza continuativa in grado di toccare direttamente la vita delle persone». Misurare gli impatti sociali significa comprendere se e come un museo può giocare un ruolo nel processo di trasformazione delle persone e della società.
I Tyne & Wear Archives & Museums di Newcastle upon Tyne (Gb) hanno, ad esempio, studiato il pubblico della mostra «Cinema India: The Art of Bollywood» per valutare gli effetti in termini di miglioramento della vita pubblica e di costruzione di comunità più coese e integrate (con risultati piuttosto incoraggianti), mentre la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo a Torino, nell’ambito del progetto «City Telling», ha analizzato se e come i progetti educativi favoriscono il dialogo interculturale, rafforzano le competenze artistiche e culturali e rispondono alle esigenze di apprendimento e di crescita personale ed espressiva dei partecipanti.
Gli impatti ambientali e gli approcci green
Un’ultima interessante frontiera è quella, infine, degli impatti ambientali e dell’adozione di approcci green alla gestione delle organizzazioni culturali. Temi quali l’analisi dell’impronta di carbonio, le mostre «verdi» e l’adozione di comportamenti volti al risparmio energetico rappresentano un’innovazione sostanziale per un gran numero di musei, anche se sono ancora molto limitate le informazioni e le prassi di valutazione, soprattutto per operazioni complesse come i prestiti delle opere e l’organizzazione delle mostre.
L’Amgueddfa Cymru, il sistema del Museo nazionale del Galles, ha promosso uno studio approfondito volto a misurare l’impatto ambientale connesso ai prestiti museali anche con l’obiettivo di formulare raccomandazioni a uso dei musei che intendono ridurre il loro effetto sul riscaldamento globale. L’impronta di carbonio derivante dai prestiti di opere e dalle mostre per il 2006 è stata pari a 53 tonnellate di biossido di carbonio, il 95% delle quali generate dal trasporto degli oggetti e delle persone.
Si tratta di tematiche e studi la cui importanza sta via via acquisendo sempre maggiore peso nell’ambito della comunità degli operatori museali, tant’è che una trattazione sistematica e approfondita è stata commissionata dal progetto europeo LEM, The Learning Museum. È stata sistematizzata nel volume Measuring Museum Impacts, disponibile sul sito del progetto, all’indirizzo: www.lemproject.eu.
Altri articoli dell'autore
L’Associazione archeologi del Pubblico Impiego (Api-MiBact) ha inviato una nota al Ministero della Cultura e a quello della Funzione Pubblica, nonché ai membri delle Commissioni cultura di Camera e Senato, per esprimere il proprio dissenso per il bando per 75 posti nell’area dell’elevate professionalità (Ep), le cui domande di partecipazione vanno presentate entro il 26 giugno
Il premio Nobel e il direttore del Museo Egizio si sono incontrati per parlare di musei e romanzi: «Sono simili: sono i “luoghi” in cui avviene l’interpretazione del significato della nostra vita, nei quali riflettere su sé stessi»
Anche quest’anno Tag Art Night, la Notte delle Arti Contemporanee, propone un palinsesto di mostre diffuse sul territorio cittadino
Rimodulate le competenze e modificato la struttura organizzativa: dal Segretariato generale al modello dipartimentale