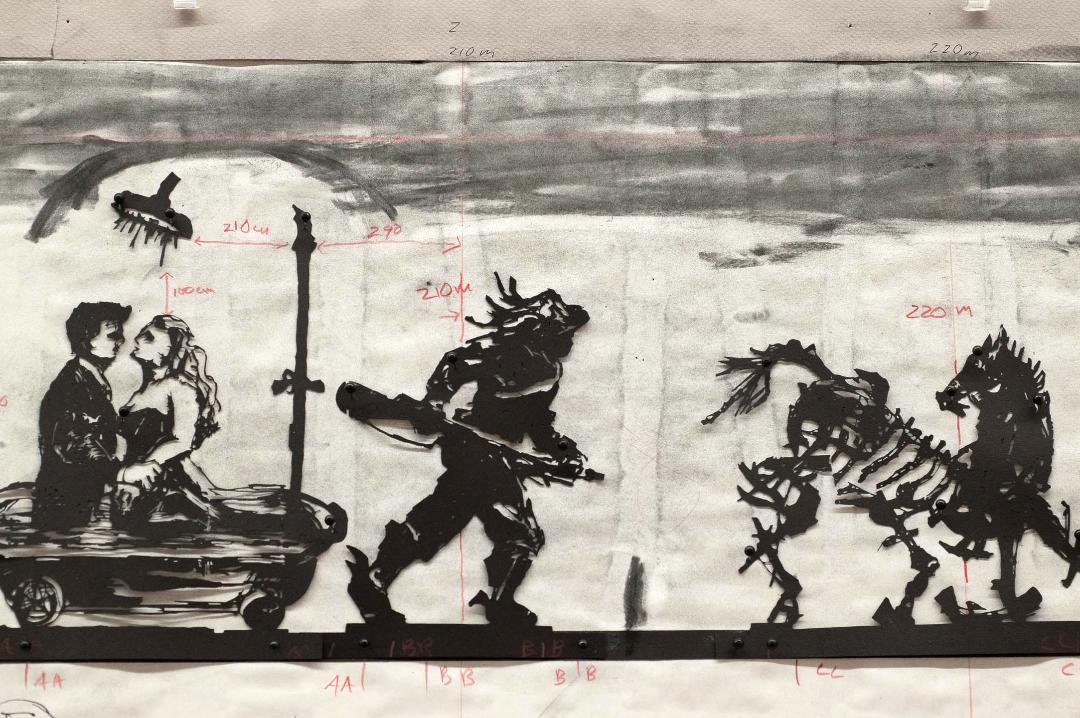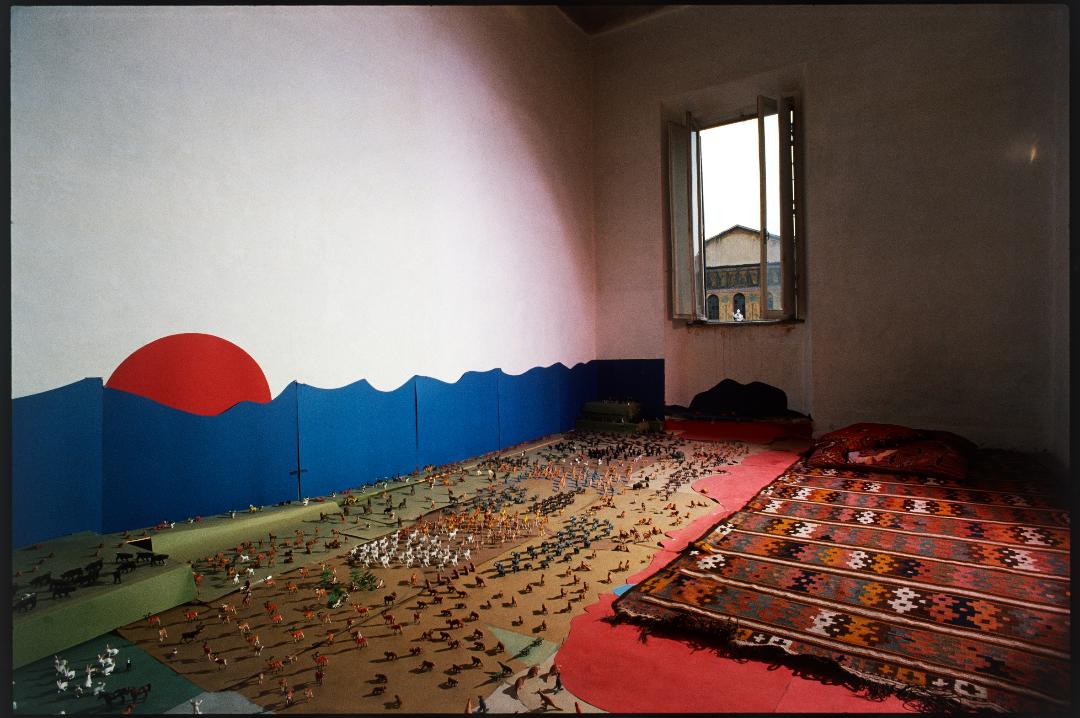Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Francesca Romana Morelli
Leggi i suoi articoliIn pensione anticipata, Alberta Campitelli racconta le sue esperienze professionali in dieci amministrazioni comunali, di diversi colori politici
Dal 1978 alla Soprintendenza capitolina, di ruolo dal 1981, Giovanna Alberta Campitelli, direttore dell’Ufficio Ville Parchi Storici, ha collaborato con dieci sindaci, a cominciare da Giulio Carlo Argan, uomo di sinistra e laico che, con la sua statura d’intellettuale internazionale, dichiarò: «Nel mio pensiero la città è cultura, niente altro che cultura». Parole cha paiono oggi giungere da un’altra epoca.
Dallo scorso 31 marzo la Campitelli è in pensione, volutamente anticipata. Si è occupata di 42 tra ville e giardini storici per oltre 500 ettari di verde, disseminati di 220 edifici e arredi urbani. Nel 2013, per sedici mesi, ha diretto ad interim il Macro nella sua fase più burrascosa, tra l’assessorato insipiente di Flavia Barca e quello burocratico di Giovanna Marinelli (che tolse l’autonomia al museo). Ha ideato e realizzato il restauro dei complessi delle ville Borghese e Torlonia, dove ha creato e diretto cinque spazi museali. Autrice di saggi e libri, tiene docenze, consulenze, partecipa a convegni in Italia e all’estero. Fellow presso il centro di ricerche sui giardini di Dumbarton Oaks, Washington, della Harvard University (2001), è membro dell’Icomos Ifla e del Direttivo di Icom Italia, organi dell’Unesco. Il Ministero della Cultura francese l’ha nominata Chevalier des artes et lettres nel 2013.
La sua esperienza inizia a fianco di Renato Nicolini, assessore alla Cultura nelle giunte Argan e Petroselli.
Negli anni di piombo, Renato Nicolini spezzò il clima di paura trasformando alle radici il modo di vivere la città. Accessibilità, coesione, senso di appartenenza sociale erano i concetti cardine della sua rivoluzione culturale. Da una parte portò la cultura nelle periferie, dall’altra organizzò mostre raffinate in Campidoglio (Kandinskij, i capolavori dell’Ermitage, l’architettura di Schinkel), che collocavano Roma sulla scena internazionale e inventò l’Estate romana. Mi assegnò il quartiere di Cinecittà, che sconfinava nella campagna: censimmo acquedotti romani e tombe antiche, riconnettendo quel territorio al centro storico. Vi si trovava la Fatme, gigante dell’industria romana del tempo e roccaforte della classe operaia: con il consiglio di fabbrica e le scuole del quartiere organizzai dibattiti, conferenze, visite guidate nella Roma barocca e medievale e una mostra su quel territorio, per rendere consapevoli gli abitanti delle loro radici culturali.
All’epoca le ville storiche non interessavano la Soprintendenza. Lei perché fece questa scelta?
In effetti, la giunta Argan espropriò Villa Torlonia e alcune ville minori per accrescere il verde urbano. Nicolini vincolò invece l’archeologia industriale dell’Ostiense, destinata alla distruzione. Affrontando la riqualificazione di questo recente passato, capii come le ville, un insieme di verde e arte, rappresentavano anche loro un patrimonio del quale la città aveva perso la memoria storica. Nel 1984 Nicolini mi convinse a occuparmene.
Nel 1993 viene eletto Francesco Rutelli, che inaugura la stagione dei restauri del patrimonio della città e valorizza l’arte contemporanea. Come collaborò a questo programma?
Rutelli usò il Giubileo e i fondi della Legge Roma Capitale per rivitalizzare, conferire un volto moderno a Roma. Per esempio all’Ostiense trasformò la Centrale Montemartini, sede della prima officina elettrica della città, in un museo di scultura romana. Avviò i cantieri del museo dell’Ara Pacis, dell’Auditorium e altri. Immediatamente affrontammo il recupero di Villa Torlonia con la Casina delle Civette firmata da Fasolo e Cambellotti, che rischiava di scomparire. Fu il primo di una serie di nuovi musei nelle ville e nella città.
Si trattava di musei di nuovo tipo, legati al territorio. Qual era l’idea?
Nel 2001 Rutelli lasciò per il restauro Villa Torlonia un tesoretto di 30 miliardi di vecchie lire, cui Veltroni ne aggiunse altrettanti. Un formidabile lavoro di squadra permise di creare un circuito armonioso: il Museo della Scuola romana e le mostre nel Casino Nobile (che conserva anche le memorie della presenza di Mussolini) e Casino dei Principi per un pubblico colto, la Casina delle Civette, museo delle vetrate di primi Novecento, amato da anziani e bambini, il Teatro con spettacoli preziosi, la biblioteca dell’Accademia delle Scienze, una ludoteca tecnologica, la caffetteria della Limonaia. Non era sufficiente restaurare Villa Torlonia, era importante definire gli usi dei «contenitori» in un percorso integrato e stimolante per i visitatori.
Quanto costano il polo museale di Villa Torlonia, i Musei Bilotti e Canonica a Villa Borghese?
Nessun museo ha sufficienti introiti per «mantenersi» con la bigliettazione, nemmeno il Louvre! È importante l’indotto che un museo crea per la città e il valore sociale della cultura. Con l’assessore Barca ci rendemmo conto che negli 8 piccoli musei della città creati da Veltroni, compreso il Bilotti, si spendevano 50mila euro di personale di biglietteria e se ne ricavavano soltanto 30mila dai biglietti, così suggerii di rendere gratuito l’ingresso, con il beneficio di un ritorno d’immagine per la Soprintendenza. Un rapporto pubblico sul numero dei visitatori dei musei comunali nel 2015 ha dimostrato che le star capitoline dell’Ara Pacis, i Capitolini e il Macro hanno subito un calo notevole, in particolare il Macro ha perso quasi 100mila visitatori. Hanno invece raddoppiato gli otto musei gratuiti, tra cui il Canonica, passato da 12.541 a 24.564 visitatori e il Bilotti da 17.841 a 34.202.
Veltroni aprì alla collaborazione con i privati. Come avvenne la creazione del Museo Bilotti?
Con Veltroni nasce il progetto di Villa Borghese Parco dei Musei (2003) e una campagna d’investimento di 15 milioni di euro per i restauri del verde e degli edifici. Nel 2004 il newyorkese Carlo Bilotti, imprenditore di origini italiane e collezionista, propone a Veltroni di creare un museo con la donazione da parte sua di 23 dipinti di Giorgio de Chirico, Andy Warhol e altri, dal valore di 13 milioni di euro. Individuammo l’antica Aranciera a ridosso del Giardino del Lago, dove progettammo uno spazio espositivo diviso tra la donazione e le mostre di arte contemporanea. Fu inaugurato nel 2006 con dieci pezzi di Damien Hirst, David Salle e Jenny Saville. Mesi dopo purtroppo Bilotti morì improvvisamente, e ulteriori progetti svanirono. L’operazione era però innovativa e suscitò dibattiti sul rapporto pubblico-privato, Veltroni e l’assessore Gianni Borgna dovettero battersi per fare capire che i vantaggi erano per entrambe le parti: il pubblico arricchiva il patrimonio, il privato aveva benefici in detrazioni fiscali e d’immagine.
Oggi questi musei ospitano solo mostre sponsorizzate: che cosa ne pensa?
Non c’è nulla di diabolico o di negativo nel rapporto tra privato e pubblico, quando quest’ultimo è capace di mantenere la governance di un progetto e condurlo bene in porto. A questo proposito, Icom Italia sta stilando un documento sull’etica del rapporto tra pubblico e privato.
Altri articoli dell'autore
Una sessantina di opere di 51 artisti (da Parmigianino a Schiele, da Boetti a Kentridge), entrate nella collezione dell’istituto romano grazie a tre milioni finanziati dallo Stato, sono ora visibili a Palazzo Poli
Un’antologica nel Casino dei Principi a Villa Torlonia e al Mlac di una delle artiste più moderne e complesse del Novecento
L’allestimento da Tornabuoni è una continua scoperta all’interno dell’emisfero artistico e umano dell’artista torinese
Dopo cinque anni il direttore saluta il Macro di Roma con una collettiva di oltre trenta artisti che intende «restituire uno sguardo dinamico al visitatore»