
Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Redazione GDA
Leggi i suoi articoliBologna. La connoisseurship è un tema cruciale per il destino della disciplina storico artistica, intrinseco all’attività di Federico Zeri e all’identità stessa della Fondazione a lui dedicata che da anni promuove attività di formazione specialistica e di alta divulgazione scientifica riunendo storici dell’arte di fama internazionale («La scultura della “maniera moderna” in Emilia e nel Veneto», 2012; «Lo specchio della realtà. I falsi e la storia dell’Arte», 2013; «La scultura gotica in Emilia», 2014).
Nel seminario «Il mestiere del conoscitore. Roberto Longhi», a cura di Anna Maria Ambrosini, Andrea Bacchi, Daniele Benati e Aldo Galli, ospitato dalla fondazione Zeri dal 24 al 26 settembre scorso, la figura di Longhi (1890-1970) ha offerto l’occasione per riflettere sull’importanza e al tempo stesso sui limiti dell’attribuzione, prima fase di un procedimento complesso e articolato che fa della storia dell’arte uno dei sistemi di lettura dei fenomeni storici.
Pubblichiamo qui la relazione tenuta da Massimo Ferretti.
L’immenso lavoro di Longhi «conoscitore» è stato ripercorso in questi due giorni con sondaggi di natura o tematica o regionale o cronologica. Il modo peggiore per darne un bilancio sarebbe quello di mettersi come davanti a un pallottoliere, spostando da una parte le palline (mettiamo azzurre) corrispondenti alle attribuzioni «giuste», dall’altra parte le palline (diciamo rosse) che rappresentano i giudizi ai nostri occhi difettosi. Va da sé che per ogni giudice onesto la fila delle palline azzurre sarebbe molto, molto più lunga dell’altra. Ma come ci ha ricordato anche Francesco Caglioti parlando di scultura (probabilmente è il caso estremo) non è che in Longhi luccichi sempre l’oro. Non si tratta di naturale avanzamento delle conoscenze. Anche per Longhi ci furono zone storiche dove continuarono a pesare i pregiudizi comuni. Nessuno può saltare a piè pari sulla propria ombra storica, anche se è un gigante. E poi, neppure Longhi avrebbe potuto ripercorrere l’intero corso della storia dell’arte con la stessa freschezza innovativa.
Per fortuna il mondo va avanti e resta sempre qualcosa per le generazioni successive: anche per quella oggi ai suoi esordi scientifici, alla quale è rivolto il seminario. Ma non era questo il punto.
Cercando di tirare le somme, è emerso più che a sufficienza come Longhi resti figura centrale di un grandioso processo storiografico, avvenuto attorno alla prima metà del secolo scorso. Centrale, ho detto, perché all’opera non ci fu solo Longhi, che ne resta tuttavia il più tipico e consapevole protagonista, per quantità e qualità di risultati. Mi sto riferendo a quella radicale riorganizzazione del sistema dei valori della nostra storia figurativa che a volte sembra quasi sfuggire o essere data per sottintesa da chi oggi si serve di documenti figurativi in ambienti disciplinari diversi dal nostro (ma anche nel nostro). L’esito ultimo di quella stagione somiglia fino a un certo punto al «canone» degli studiosi di letteratura, perché la nostra mappa è più fitta e complessa. Nei sessanta anni di lavoro fatto da Longhi è saltata un’idea di tradizione artistica a base spiccatamente nazionale e se ne è stabilita un’altra, qua e là ritoccata, ma non sovvertita nei decenni a noi più vicini. Allo specchio della storia figurativa, è riemersa un’Italia policentrica, fatta di regioni e di province, più che di «scuole», ma con centri di raggio europeo (come la Roma caravaggesca). È un sistema ricco e complesso, inserito nel più largo quadro di «congiunture», per usare un termine caro a Longhi, continentali.
E visto che ogni tanto sbuca fuori la voglia di dare a Longhi etichette politiche (il primo a provarci fu Garrison): pre e postbellico, «fascista» e «di sinistra», vorrei esprimere il convincimento che quell’opera di riassetto resta il suo più grande e vero lascito politico. A maggior ragione nel momento in cui il legame fra cultura e cultura figurativa, fra tradizione e vita sociale, fra cose e generazioni, sta saltando, devastato anche dall’interno, da non occulte, né in futuro occultabili, responsabilità politico-amministrative. È l’Italia molteplice ed europea, l’Italia fisica e civile di Longhi che è oggi esposta ai rischi di un disastro irrimediabile.
L’immagine del pallottoliere da cui sono partito stava a indicare, in modo ribaltato, che non possiamo leggere Longhi azzerandone gli svolgimenti nel tempo. Prescindendone, si fraintenderebbero o cancellerebbero aspetti essenziali del Longhi storico dell’arte e «conoscitore». Non è neppure giusto appianare certi cambiamenti di giudizio, certe sue apparenti contraddizioni. Oscillazioni di giudizio a distanza di tempo, come le affermazioni più perentorie, vanno ripensate sempre alla luce della forza d’urto che dovevano avere rispetto a idee allora correnti, banali e disseccate. Chi vuol mettere anche le oscillazioni e le uscite trancianti, non può prescindere dalla storia intellettuale di Longhi e del relativo milieu. Non c’è dubbio, a leggere i suoi saggi rimontati in base all’oggettiva sequenza dei secoli, come nel «meridiano» di Contini (che ha però il merito di esibire la somma di quei sessant’anni di lavoro) si perdono di vista riferimenti sostanziali per una migliore messa a fuoco. Si fa fatica persino a comprendere le tappe dello scrittore.
Era l’immediato presupposto di questo seminario: le attribuzioni non hanno mai per Longhi un semplice fine classificatorio. Sono la leva conoscitiva che coincide quasi sempre con l’operante giudizio di valore, ossia con la restituzione di un tessuto lacerato o semplicemente frainteso. Con un’attribuzione Longhi non intese mai riempire, banalmente, una casella vuota. Non sarà male ricordarlo, oggi che il nostro mestiere sembra a volte restare fra l’estremo di una storia della cultura lontana dai documenti propri e quello di una competenza specifica che si compiace un po’ troppo a riempire caselle attributive nuove, ma sempre più piccole. All’una e all’altra tendenza Longhi si oppose sempre.
Non per questo dobbiamo fare di Longhi un «nostro contemporaneo». Longhi nacque 125 anni fa, è morto da 45 anni, quando la gran parte dei presenti, escludendo parte delle prime file, non era nata. Longhi può riuscire figura viva solo nella misura in cui riusciamo a renderci conto che appartiene a una stagione diversissima dalla nostra. Con tutte le differenze del caso, possiamo immaginare un ritorno a Longhi come ci fu, negli anni della guerra e del dopoguerra, un ritorno a De Sanctis. E come per De Sanctis non ha senso questionare sull’uomo di Guicciardini o sul mondo di Aretino, l’insegnamento di Longhi è in grado di fruttare davvero solo se lo si legge come uomo di una generazione e di una cultura distanti da noi.
Francesco Arcangeli ci ricordava spesso che Longhi aveva quasi la stessa estrazione generazionale di Picasso e di Stravinskij: superuomini. Ebbe un’alta considerazione di sé, nessun dubbio, ma quando aprì spiragli autobiografici, come nel Carlo Braccesco (ne ha parlato Mauro Natale), non lo fece per narcisismo, ma per il bisogno di squadernare il senso pieno della riscoperta, per dare anche lo spaccato «vettoriale» e strumentale della sua ricerca. Non sono spiragli di metodo, in astratto. Dire che Longhi conoscitore va messo in relazione alla sua stessa storia è dunque qualcosa che ci ha mostrato per primo lui stesso.
Una morale che si può trarre dalle lezioni che abbiamo ascoltato è che, riferendoci oggi a Longhi, occorre avere ben presente il quadro concreto delle conoscenze disponibili in quel determinato momento. È l’insegnamento che si ricava dal paratesto illustrativo del libro di esordio di Giovanni Previtali, un suo allievo. Le illustrazioni finali della Fortuna dei Primitivi sono una lezione pratica e visualizzata di metodo storico-artistico: quelle immagini in serie (tipo album di figurine, in parte opportunamente oscurate) sintetizzano che cosa è Giotto e che cosa non è ancora o non è più per un determinato scrittore d’arte. È la mappa a cui dobbiamo riferire i giudizi espressi su un artista in un certo momento. Non possiamo confondere una mappa con l’altra.
Vale anche per Longhi, vale (almeno in parte) per il Giudizio sul Duecento, il caso in assoluto più delicato, generosamente affrontato da Andrea de Marchi. Questa avvertenza, ovvia ma non sempre facile da praticare, in ordine al Giudizio sul Duecento, fu già richiamata anni fa da Gianni Romano, nell’articolo sulla volta del battistero di Parma per il numero di «Paragone» in memoria di Carlo Volpe. Non possiamo raffigurarci la cultura bizantina duramente giudicata da Longhi in base alle nostre letture di Kitzinger, Weitzmann ecc., e avendo a disposizione ben altre campagne fotografiche. A scala diversa, l’avvertenza riguarda altri scritti di Longhi. Ne abbiamo avuto un bell’esempio con il caso dello scambio attributivo fra Annibale Carracci e Fra Semplice da Verona rievocato da Daniele Benati: Fra Semplice non è allora quell’alternativa che è diventata sempre più accessibile per noi (certo, anche a partire dalla correzione attributiva di Benati). Nel momento in cui siamo consapevoli di avere a disposizione materiali e conoscenze che Longhi non aveva, è naturale sentirsi «nani sulle spalle dei giganti», per riprendere l’immagine medievale opportunamente evocata da Alessandro Angelini. Che non significa rassegnarsi a un destino da «nani».
Torniamo così al senso primo dell’attribuzione, riemerso più volte. È stato da tutti ricordato che, in sintesi, è operazione inseparabile dalla idea di serie, che è la regola fondamentale per la conoscenza di ogni prodotto umano. Le cose che realizziamo riflettono un sapere, dunque si somigliano, si legano l’una con l’altra in serie. L’attribuzione non è divinazione, non scende dal cielo. Consiste nel collocare un anello nella catena appropriata o nello spostarlo ad un’altra, dove entra a perfezione, o quanto meno nel modo in quel momento più probabile. In realtà, è un po’ troppo semplice raccontarla così, appunto perché il tipo di attribuzione praticata da Longhi non servì mai a riempire caselle vuote, ma fu sempre operazione funzionale a una profonda verifica e spesso a ricombinare diversamente le stesse serie stilistiche. Non si trattava semplicemente di «pubblicare» l’inedito. C’è una pagina di «Paragone» che piacerebbe veder ricordata più spesso: è quella dove Longhi spiega quale scopo abbia la rubrica «Antologia di opere». Non suona diversamente il termine «apice». Più che la ricognizione degli artisti nella complessità del loro catalogo, gli interessava individuare «quel» particolare momento, la risposta qualitativamente rivelatrice che un artista aveva dato alla particolare congiuntura storico-artistica. Le attribuzioni servono allora a Longhi per distruggere e ricostruire un diverso sistema di valori e conoscenze.
Non va dimenticato che Longhi non era nato attributore: lo diventò. Cristina Terzaghi ha avuto modo di ricordare l’articolo su Caravaggio uscito su «L’Arte» nel 1912, ufficializzato come l’esordio disciplinare negli Scritti giovanili. Dove quelle due attribuzioni vengono però «censurate» nell’apparato illustrativo (non si potevano ripubblicare, nel 1961, con il nome di Caravaggio, neanche fra parentesi quadra, dei dipinti dove Longhi riconoscerà in seguito lo Spadarino). Non a causa di quell’incidente che si è detto: non nacque attributore. Lo sappiamo invece da quel documento straordinario che fu reso noto da Giacomo Agosti; straordinario anche per l’antipatia che provoca immediatamente Longhi. Non ha ancora compiuto 22 anni, si è laureato da meno di un anno, quando scrive a Berenson per dire, in sostanza, che nel mondo della critica d’arte non ci sono che loro due (sì, c’era stato Vasari…); e poi si mette a spiegare che cosa non funziona in Croce e lascia trasparire quanto meno lo convince negli scritti del suo destinatario. Al quale propone, alla fine, di farsi traduttore dei suoi quattro saggi, già allora famosi, sui pittori italiani del Rinascimento, riunendoli in un libro solo. Ora, in quella lettera del 4 settembre 1912 Longhi esordisce dicendo: «Sono un giovine studioso d’arte e di estetica [si faccia caso alla gemmazione] che spera di non doversi fermare all’inevitabile periodo di tirocinio come conoscitore che ora sto compiendo [aveva vinto un posto alla Scuola di specializzazione di Adolfo Venturi, a Roma] considerando il tirocinio conoscitivo al critico d’arte come la chimica della tecnica al pittore». Se Longhi fosse davvero stato quello che aspirava a diventare allora, di certo non ci saremmo incontrati qui, ieri e oggi. La sua storia ebbe altro corso: Longhi si convertì in conoscitore, appunto, ma senza iato dal critico, nell’immediato, e dallo storico. Difatti, un paio di anni quella lettera, quasi con la coda fra le gambe, scrive a Berenson per spiegare perché l’opera di traduzione non è andata avanti come promesso. Spiega che quel lavoro (dunque tutto il quadro di intenti che lo aveva motivato) sta ritardando perché, nel frattempo, «il corso delle mie idee sull’arte figurativa si è fatto così rapido e anche così tumultuoso che io vidi la necessità di attendere». Non sta dimettendo i panni del superuomo, sta cominciando a capire che il suo approccio alla storia dell’arte non può essere quello dell’estetica. Da quel momento comincia a diventare conoscitore, anche se il vero decollo avviene qualche anno dopo, girando per l’Europa. Tant’è che mentre in un primo tempo aveva proposto a Berenson di tradurre i soli saggi, omettendo gli elenchi delle opere, quando subito dopo riscopre i pittori caravaggeschi, Longhi chiude tali scritti con liste delle opere.
Resterà, questo delle liste, come un punto di distinzione fra Longhi e Berenson, il cui lungo contrasto non va ridotto a pure faccende personali. I toni, fra l’ironico e il beffardo, con cui Longhi accenna quasi sempre agli «Indici» berensoniani meritano una spiegazione un po’ più alta. Nella forma degli elenchi di opere si riflette un’idea di attribuzione che non combacia: disporre le opere in ordine topografico, con una sigla utile a richiamare lo stato di conservazione, la presenza di aiuti, la collocazione liminare nella carriera del pittore, funzionava bene per il pragmatico Berenson. Lascia invece dubbioso il più giovane idealista italiano, che parla di elenchi ferroviari, che li considera di limitata natura strumentale, distante dal reale paesaggio della storia dell’arte.
È ormai convenuto che il punto di svolta, per Longhi, fu segnato dai grandi viaggi nel 1920-22. Assieme alla sterminata perlustrazione di opere d’arte, Longhi ne compie una non meno capillare nel campo della letteratura artistica. Non si tratta (almeno per certi versi) della riscoperta delle fonti sei e settecentesche, complementare a quella dei dipinti di quei secoli. Anzi, il termine «fonti» è quello che meglio risponde ai propositi di Longhi, cresciuto in ambiente antipositivista. Di certo, fu un eccezionale divoratore della letteratura artistica fra Vasari e Lanzi. Il suo primissimo scritto, comparso su «La Voce» mentre compiva ventun’anni, è una recensione alle prime uscite di una serie di estratti vasariani, dove infilza ironicamente tutti i «venturini» e «supinini» d’Italia (fu una fortuna che non lo firmasse: avrà pensato l’anno dopo, trovandosi davanti ad Adolfo Venturi per il colloquio di accesso alla Scuola di Roma). Longhi si rivolge fin dal primo momento alla letteratura artistica, anche con il proposito, credo, di acquisire la strumentazione linguistica con gli consenta di riferirsi meglio alle opere. Longhi attinge alla letteratura artistica come per acquisire il vocabolario storico del critico-conoscitore. Per quanto la distinzione possa riuscire banale, il suo problema non è la struttura della pagina (alcuni suoi saggi avranno poi anche una dimensione narrativa): l’urgenza prima è quella della lingua. Non a caso la più efficace introduzione al primo Longhi, soprattutto, l’ha scritta uno storico della lingua, Pier Vincenzo Mengaldo. Come non è casuale che il giudizio più aspro su Longhi, quello di un Fortini indegno della sua passione intellettuale, consista nel proiettargli addosso l’ombra corruttrice di D’Annunzio. Ma lo si potrà rovesciare in un altro senso, quell’accostamento: se D’Annunzio fu il più formidabile divoratore di vocabolari, moderni e classici, Longhi non fu un consumatore meno accanito del vocabolario italiano (Antonio Boschetto mi raccontò di avergli dovuto ricomprare un nuovo «Zingarelli»: le pagine di quello vecchio erano tutte sbrindellate).
Ho inteso rammentare che Longhi fu neoidealista di formazione, convertito all’empiria a forza di guardare dipinti, praticando nello stesso tempo i testi della letteratura artistica. Ma è proprio quello che fa di Longhi una figura diversa dal puro empirico; e non per questo si potrà mai dire positivista. Non ci stiamo allontanando troppo: Longhi può ancora insegnarci che fra i rischi del positivismo e quelli dell’idealismo è meglio correre i secondi. Il trapasso a un atteggiamento più fatturale, partendo da una forma criticamente conseguente di idealismo (e viceversa) è cosa nota ai filosofi. Per Longhi non si risolse in astrazione di metodo. Muovendosi sempre in mezzo ai dipinti, nel corso del terzo decennio, maturò una poetica critica di rinnovato senso naturalistico (quella che gli consentì di approdare ai Precedenti caravaggeschi e gli precluderà di andare a fondo sulle ragioni espressive dei bizantini).
[Non c’è ora spazio per trascrivere la pagina di Francesco Arcangeli che è stata letta a questo punto: sta nel fascicolo di «Paragone» uscito immediatamente dopo la scomparsa di Longhi; e si può ridurre a queste poche parole]: «accanto alla sua facoltà intuitiva così stimolante a intendere la qualità, non la quantità delle cose, in Longhi fu altrettanto desta la capacità illuministico-positiva del riconoscere la situazione delle opere entro un contesto umano che non si può tuttora non chiamare "storico"». Viene così spiegato, con il prevalere delle ragioni qualitative, quel rapporto fra storiografia, critica e inferenze attributive che è stato il tema al centro di questo seminario.
Mi sembra però abbastanza curioso che nell’ormai più che rigogliosa letteratura su Longhi il tema dell’attribuzione non emerga in modo particolare, almeno nei titoli. Anche la commemorazione di Arcangeli non mi pare uno dei testi più citati. Sì, è stata utilizzata molto bene da Bruno Toscano; ed è ovviamente ricordata nell’articolo di un allievo, Alessandro Conti, dedicato a Roberto Longhi e l’attribuzione, sugli «Annali» della Normale nel 1980. Alla fine, però, preme poco il taglio specifico o meno, perché il tema dell’attribuzione s’intreccia con l’intera opera di Longhi (un po’ come quello della scrittura). L’impressione che conservo di quell’articolo è che Alessandro guardasse soprattutto al Longhi degli anni di «Paragone», al Longhi di Una cornice per Bonifacio Bembo o di Qualità e Industria in Taddeo Gaddi.
Anche partendo dal tema dell’attribuzione emergono le diverse stagioni di Longhi. Non cercherò di mostrarlo ora. Ricordo solo che nel 1925 Longhi parlava ormai della «razza, di certo abominanda, ma praticamente giovevolissima, dei conoscitori». E polo per servirmi di una delle fotocopie portate dietro in vista di questo discorso, leggo queste righe scritte quando le Precisioni su alcuni dipinti della Galleria Borghese vennero riunite in volume, chiuso facendo questo bilancio: «Fosse pure che gran parte delle nostre ricerche non avesse servito altro che a dare agli anziani l’appiglio per esprimere opinioni più perfette e da gran tempo tenute in serbo! Ci restringeremo allora alle soddisfazioni residue di aver inflitto agli ardentissimi calciatori di attribuzioni che sparano senza ordine, e alla Luna, qualche solennissimo ‘calcio di rigore’; al pubblico più scettico qualche palla in faccia; e, quel che più ci premeva, ai neofiti desiderosi alcuni spunti per una metodica riformata». Non va più in là, quanto a pura metodica. Il fatto è che la riflessione sull’attribuzione, al modo di Berenson o di Pope-Hennessy e altri conoscitori, non interessava a Longhi. Interessa invece che il discorso sull’attribuzione s’identifichi con una diversa configurazione storica; che sia un cuneo in grado di smuovere in profondità quanto appare ben assestato (la «palla in faccia» ai filistei). Di qui nascono anche mutazioni di giudizio stupefacenti, se viste esclusivamente sull’asse Longhi (chi liquida in modo terribile un artista di statura europea, con il famoso «Buonanotte Fattori», anni prima aveva promesso un libro su Nino Costa e due sui paesisti piemontesi, a partire da Fontanesi; o aveva poi fatto una rivista assieme a Emilio Cecchi, che parlava di Macchiaioli: cose incomprensibili, se non si tiene conto di quanto nel frattempo era cambiato in campo collezionistico o se non si considera che c’era da fare i conti con Ojetti).
Questo accenno ai giudizi più spiazzanti ci consente di tornare indirettamente al senso che per Longhi ha l’attribuzione, che spesso finisce per riguardare due artisti: quello a cui si toglie un’opera e quello a cui si dà. Nei giudizi di Longhi si trova sempre il modo di ribassare da una parte e d’innalzare da un’altra; d’intervenire sempre nel vivo dei convincimenti e delle attese di chi legge; di modificare anche provocatoriamente, per necessità, i valori assestati. Il modello è quello che corrisponde alla nascita della figura del critico nella Francia dell’Ottocento, all’ombra della funzionale polarità Ingres-Delacroix. E modello «salonnier» si fonde con quello di Riegl: è il miracolo che rivela Longhi. Ma la combinazione binaria rimarrà costante in Longhi e può spiegare perfino certe sue preclusioni filologiche come quella di non (voler) riconoscere la presenza di Avanzi accanto ad Altichiero.
Non possiamo leggere per estrapolazione i giudizi di Longhi: le sue rassegne critiche sono un antidoto alla deformante compressione delle odierne, sempre più estese «schede» di catalogo. È una considerazione che per forza di cose dovrà restare abborracciata, come un po’ tutto questo discorso. Occorreva almeno un accenno, perché ancora oggi, a quasi mezzo secolo dalla scomparsa, vediamo sculacciare Longhi perché non apprezzò a dovere Tintoretto o perché nulla intese di Canova (e se avesse capito Canova, non avrebbe potuto intendere tante altre cose). Dobbiamo insomma leggere sempre Longhi, anche il Longhi attributore, nella sua complessità diacronica, non per pagine separate. Il quadro complessivo uscito in queste due giornate ci ha restituito «tutto» Longhi: un Longhi con le figure, per così dire, visto che è stato da più parti evocato, prendendone a volte le distanze, il Longhi «senza figure» di Contini. Anch’io confesso di non avere mai avuto un grande trasporto per quella raccolta e di averla davvero apprezzata solo al tempo del servizio militare, quando entrava in una tasca della tuta mimetica. Sarà anche perché ho sempre avuto in sospetto chi dà l’impressione d’interessarsi alla storia dell’arte quasi soltanto perché ha letto Longhi. Se continuiamo a leggere Longhi, è perché ci occupiamo ancora di storia dell’arte.
Articoli correlati:
Longhi, l'attributore principe
Il mestiere del conoscitore: tre giornate per Roberto Longhi alla Fondazione Zeri
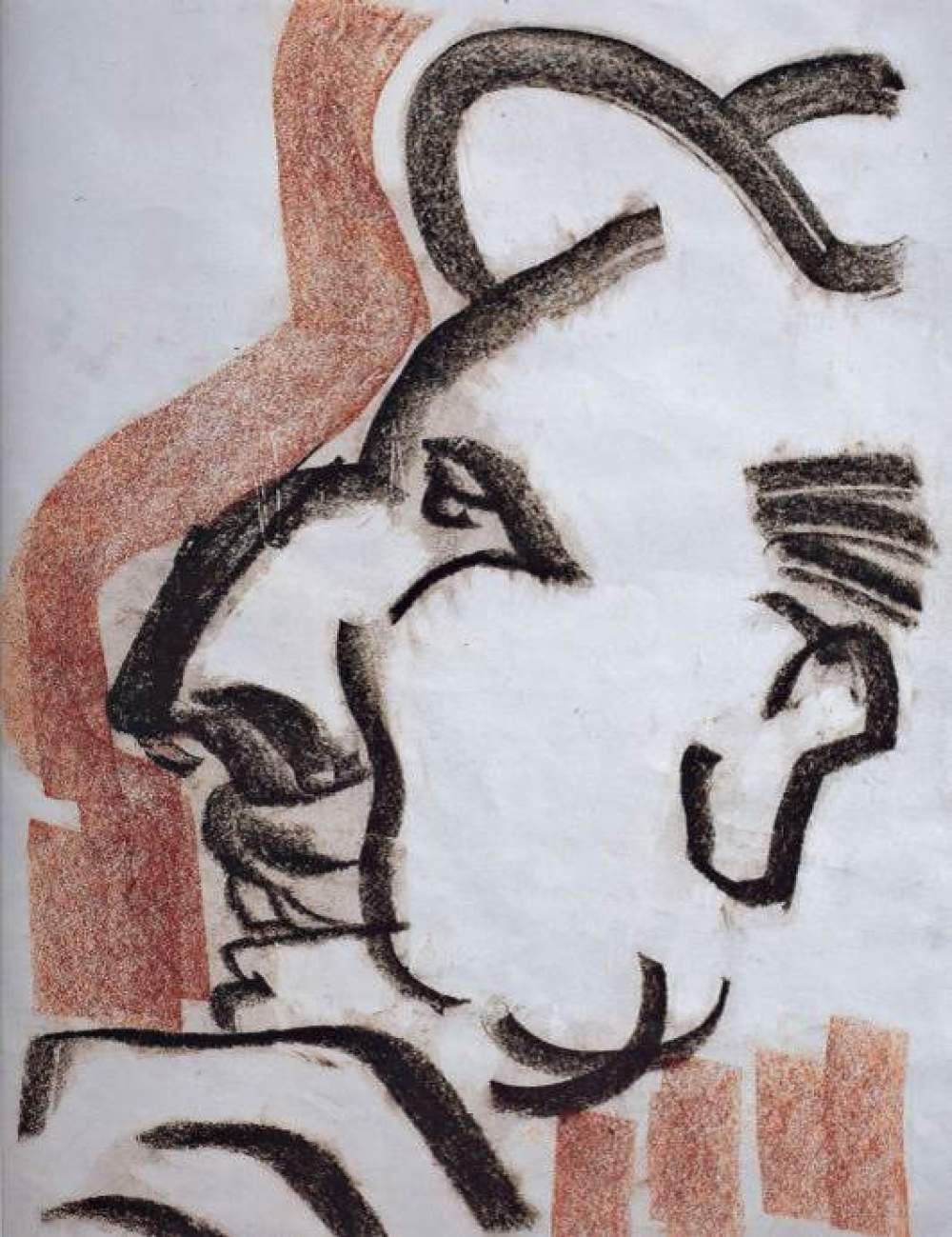
Roberto Longhi ritratto da Pasolini
Altri articoli dell'autore
L’Associazione archeologi del Pubblico Impiego (Api-MiBact) ha inviato una nota al Ministero della Cultura e a quello della Funzione Pubblica, nonché ai membri delle Commissioni cultura di Camera e Senato, per esprimere il proprio dissenso per il bando per 75 posti nell’area dell’elevate professionalità (Ep), le cui domande di partecipazione vanno presentate entro il 26 giugno
Il premio Nobel e il direttore del Museo Egizio si sono incontrati per parlare di musei e romanzi: «Sono simili: sono i “luoghi” in cui avviene l’interpretazione del significato della nostra vita, nei quali riflettere su sé stessi»
Anche quest’anno Tag Art Night, la Notte delle Arti Contemporanee, propone un palinsesto di mostre diffuse sul territorio cittadino
Rimodulate le competenze e modificato la struttura organizzativa: dal Segretariato generale al modello dipartimentale



















