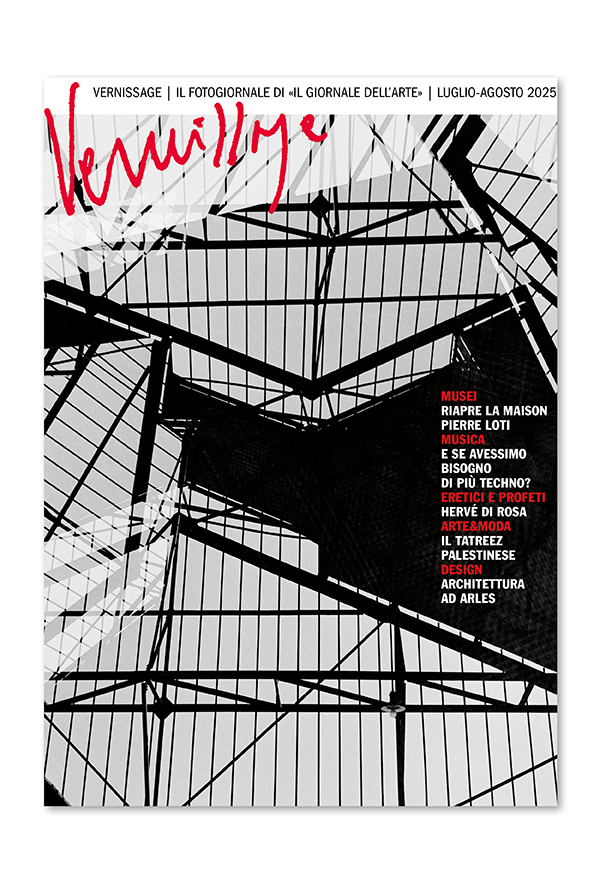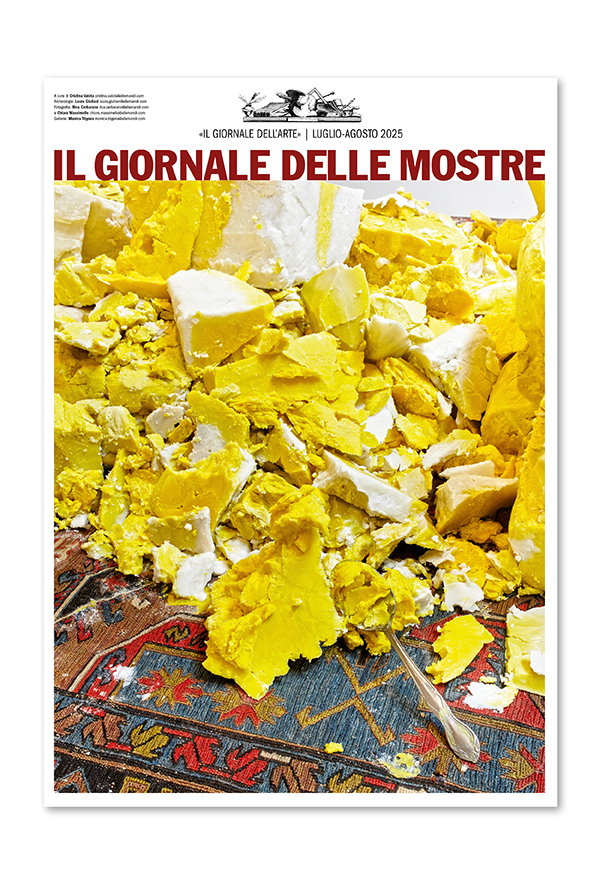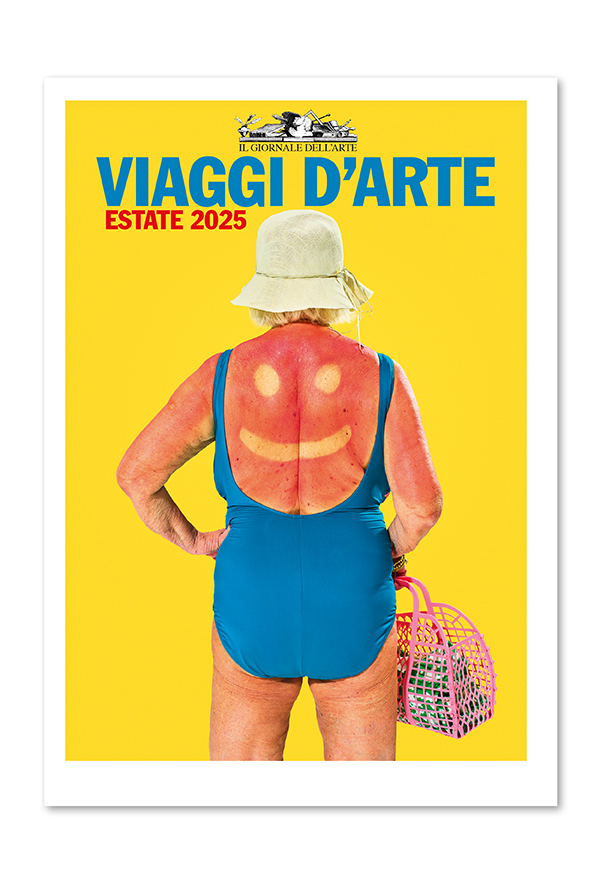Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Simone Facchinetti
Leggi i suoi articoliAndrea Cipriani è un restauratore molto stimato nell’ambiente del mercato dell’arte. Lo è in virtù di riconosciute competenze e capacità. È una posizione conquistata sul campo, frutto di un’esperienza difficilmente ripetibile, per numero, tipologia e importanza delle opere che gli sono passate tra le mani. Frequentando quel mondo ha imparato a essere molto riservato. Non rivela i nomi dei clienti neppure sotto tortura e non mostra a nessuno i quadri che ha in corso di lavorazione. In tanti anni che lo frequento penso di aver visto sì e no una manciata di opere, chiamato direttamente dai proprietari; di altre centinaia e centinaia ho visto solo i retri. Non so bene come faccia a giostrarsi tra innumerevoli cornici, tele e telai. Me lo sono sempre immaginato come un abile giocoliere che fa roteare in aria i suoi birilli senza mai perderli di vista.
Chi opera nel mondo del restauro ama indossare il camice bianco dei medici ospedalieri, come gli anatomopatologi che dissezionano i cadaveri in cerca delle ragioni del loro decesso. Cipriani porta sempre abiti borghesi e non cova nessuna forma di necrofilia. Al contrario, si innamora e danza coi quadri, nel senso che riesce a stabilire con essi un profondo dialogo. Esalta le loro tracce vitali, quelle che riescono a dirci, imperscrutabilmente, ancora qualcosa. Crea un legame sentimentale coi dipinti, nutre delle preferenze, si comporta come un latin lover. In queste vesti di deus ex machina determina le regole del gioco, non prima di aver investigato a fondo la materia, ispezionato ogni suo aspetto costitutivo, indagato le tipologie di degrado. La premessa è sempre un approccio rigorosamente scientifico al restauro, poi però scatta qualcosa.
Mi sono sempre chiesto cosa renda i suoi risultati unanimemente apprezzati e penso che non dipenda da un unico ingrediente, contribuiscono vari fattori. Il primo è il contesto. Non è un mistero che Cipriani operi per alcuni mercanti d’arte attivi sullo scenario internazionale. Questo significa che le opere che gli arrivano sono state attentamente selezionate. Con quali criteri? Il primo in assoluto ha a che fare con il gusto del nostro tempo. Anche se può sembrare ovvio conviene sottolineare che le opere sono state scelte per le loro potenzialità di suscitare l’interesse dei collezionisti contemporanei. Se fossimo all’interno della programmazione di un teatro sarebbe come stabilire a tavolino il cartellone di una stagione lirica. Poi arriva il direttore d’orchestra, Cipriani appunto, che si assume la responsabilità di dirigere l’orchestra, interpretando lo spartito, fino a mandare in estasi il pubblico. Tutti sappiamo che i loggionisti sono i più esigenti, perché hanno sviluppato un rapporto simbiotico, spesso patologico, con l’opera d’arte: ecco i grandi mercanti sono equiparabili ai più intransigenti loggionisti. Per questo motivo Cipriani si trova spesso in una posizione non facile.
La musica di Mozart è fatta di note, così come la pittura di Botticelli di colori. Più di una volta mi è capitato di sentirgli dire «che problema c’è, in fondo è solo un buco!». Cipriani ha la capacità di sottrarre all’opera d’arte la sua aurea e di considerarla semplicemente per quello che è: un supporto, una preparazione, dei pigmenti miscelati con l’olio e stesi su una superficie. Questo sguardo freddo, duro, marxista, cela in realtà una volontà di dominio. Mentre Marx si rotola nella tomba, Cipriani afferma il suo ego nel controllo della materia. Dove sta il segreto? In una visione. Cipriani si prefigura come verrà il quadro e poi inizia a danzare. Bisogna conoscere esattamente tutti i passi, le mosse, perfino il casquè, eseguendoli senza sbavature. Guai se il partner ti cade dalle braccia!
Nel restauro ci sono dei limiti che non si possono superare. Il primo concerne la pulitura. È un tipo di intervento irreversibile, perciò, deve essere condotto con estrema cautela. Cipriani è un maestro in questo ambito. Un altro aspetto che cura in modo maniacale riguarda il miglioramento della superficie e tutto ciò che ha a che fare con i supporti: buchi, stuccature, imitazione di superficie ecc. Infine arriva il ritocco. Ma il ritocco di cosa? Qui va detto che Cipriani non ama i fondi oro mentre si esprime al massimo sui dipinti di età barocca: quindi non superfici specchianti ma sfrangiate, non sagome perfette ma deformi, non colori campiti ma sciabolati.
Un giorno, molto tempo fa, gli ho sentito fare un discorso che mi sono appuntato perché, lì per lì, mi suonava curioso: «So riconoscere diverse tipologie di ritocchi, intuisco se risalgono alla mano di uomini oppure no. Alcune donne stanno un passetto indietro». L’apparente riverbero politically incorrect della battuta va aggiustato alla luce del contesto in cui è stata fatta e tenendo presente il gusto per il paradosso del suo artefice. Non avrebbe senso soffermarsi su questa facezia se non fosse che cela un nucleo di verità. Cipriani si innamora dei quadri che restaura e li vuole possedere. Il corteggiamento può durare molto tempo. Li spia, li accarezza, li massaggia. Compie un rituale amoroso complesso che possiamo solo provare a immaginare, perché avviene in un contesto privato. A un certo punto però il risultato arriva sotto gli occhi di tutti e scatta l’applauso.
Nell’ultimo anno ha iniziato a fare la spola con Madrid. È stato chiamato da Colnaghi, Benappi e Lullo a restaurare l’«Ecce Homo» di Caravaggio», l’opera saltata fuori qualche anno fa in un’asta madrilena, dove era stato erroneamente schedata come «scuola di Ribera». Il dipinto ha destato un enorme interesse, non solo nel ristretto ambito degli addetti ai lavori. La storia è finita su tutti i principali quotidiani del mondo, da «El País» al «New York Times», da «Le Monde» al «Corriere della Sera». E come poteva essere diversamente? Parlandone ha esordito così: «All’inizio ero preoccupato perché non ero preoccupato! Alla fin fine si trattava solo di un supporto preparato, dipinto a olio, protetto con una vernice e ritoccato più volte nel corso del tempo».
Quindi un oggetto qualsiasi?
Certo che no, però neanche un totem. Sono state fatte diverse indagini sul dipinto. Contemporaneamente ho raccolto tutto il materiale bibliografico disponibile sulla tecnica pittorica di Caravaggio. Poi ho iniziato un pellegrinaggio per andare a rivedere le sue opere. Un giorno ero davanti alla «Salomè con la testa del Battista» del Palacio Real a Madrid. Dietro di me c’era un gruppo di persone intensamente concentrate, quasi in venerazione di fronte all’opera. Io non me ne ero accorto, perché ero assorto nell’osservazione della superficie. Per capirla meglio, sfruttando una luce radente che arrivava dall’alto, mi sono abbassato a terra. Quando mi sono voltato ho visto che le persone alle mie spalle si erano inginocchiate, imitandomi. Si era creata una situazione surreale.
Che cosa ha scoperto grazie alle indagini?
Alcuni segni si vedevano già a occhio nudo, tuttavia è emerso un reticolo di incisioni dirette, in corrispondenza delle teste e delle mani piuttosto interessanti poiché si tratta di un aspetto tecnico molto peculiare in Caravaggio che non partiva da un disegno preparatorio ma incideva con uno strumento appuntito direttamente sulla preparazione della tela.
Immagino che l’operazione più delicata sia stata la pulitura?
Immagini bene. Prima di sfiorarlo con un dito abbiamo studiato attentamente il quadro e steso un’articolata proposta di intervento che è stata approvata dalle autorità spagnole, preposte a sovrintendere un bene considerato di interesse nazionale. Le medesime hanno seguito da vicino tutte le fasi salienti del restauro. Ma torniamo alla pulitura: ha rivelato l’esistenza di quattro precedenti restauri, distinguibili in base ai diversi materiali utilizzati. Una spia particolarmente loquace è lo stucco e ne abbiamo trovati di quattro tipologie che risalgono a epoche diverse. Il più antico sembrerebbe del XVIII secolo. Le puliture antiche si erano concentrate solo su alcune porzioni del dipinto. In genere le zone più in luce, come la figura di Cristo. Procedendo per gradi con la pulitura sono riaffiorate dal buio intere zone che prima risultavano mute. In particolare la figura del giovane sgherro che sta alle spalle di Cristo. Lentamente è emerso dal fondo con un nuovo soffio vitale.
So che parli coi quadri, cosa vi siete detti?
Non scherzare, nessuno parla coi quadri. Se intendi dire che i restauratori hanno il privilegio di stabilire un contatto prolungato e intimo con le opere d’arte, allora ti confesso che per me è stato emozionante lavorare sull’«Ecce Homo». Tutte quelle ore passate in silenzio a osservarlo e a studiarlo, già mi mancano.
Quale tipo di intervento pittorico avete adottato?
Oggigiorno c’è un ritorno al passato, per fortuna. Sono sempre stato diffidente nei confronti della selezione cromatica. Il ritocco mimetico non dà mano libera al restauratore che, ovviamente, deve operare entro i confini delle lacune. Nel nostro caso è stato documentato tutto con una campagna fotografica capillare, quasi minuto per minuto. Perciò gli studiosi potranno farsi un’idea precisa di come fosse prima dell’intervento pittorico. Al contempo tutti gli altri potranno godersi l’opera senza essere vessati dai protagonismi delle teorie del restauro.
Questa conversazione è andata in scena in vari tempi e in varie stagioni, quasi sempre con un bicchiere di vernaccia in mano. A un certo punto si interrompeva bruscamente. Cipriani correva via. Andava di corsa nel suo studio in via Santo Spirito e continuava a danzare.
da Il mercato dell’arte. Le regole del gioco, di Simone Facchinetti, Allemandi 2023
Leggi anche:
Al Prado il Caravaggio messo all’asta per 1.500 euro
Il nostro Caravaggio: mio, suo e di Pulini
CARAVAGGIOMANIA | Le indagini diagnostiche
CARAVAGGIOMANIA | Chissà perché piace tanto
CARAVAGGIOMANIA | Controstoria
Ecco come gestiremo il Caravaggio
CARAVAGGIOMANIA | Il Caravaggio di tutti
Più Caravaggio di così si muore
Altri articoli dell'autore
La vista lunga del tiratore scelto • Intanto possiamo osservare che il genere gode di buona salute, anche solo passando in rassegna il materiale che le case d’aste sono riuscite a racimolare
La vista lunga del tiratore scelto • Il quadro recentemente acquistato dalla National Gallery di Londra è misterioso perché da quando si conosce nessuno è mai riuscito a individuare il nome del suo vero autore
La vista lunga del tiratore scelto • Come scriveva il collezionista Guido Rossi in un editoriale su «Il Giornale dell’Arte» nel 1983 «nessun bene acquistato a un certo prezzo sul mercato, può essere venduto a un prezzo sicuro»
La vista lunga del tiratore scelto • La merce parla, basta saperla leggere, e ciò che ha affollato la fiera di Maastricht era piuttosto loquace. Ciò che più strideva, invece, erano gli allestimenti