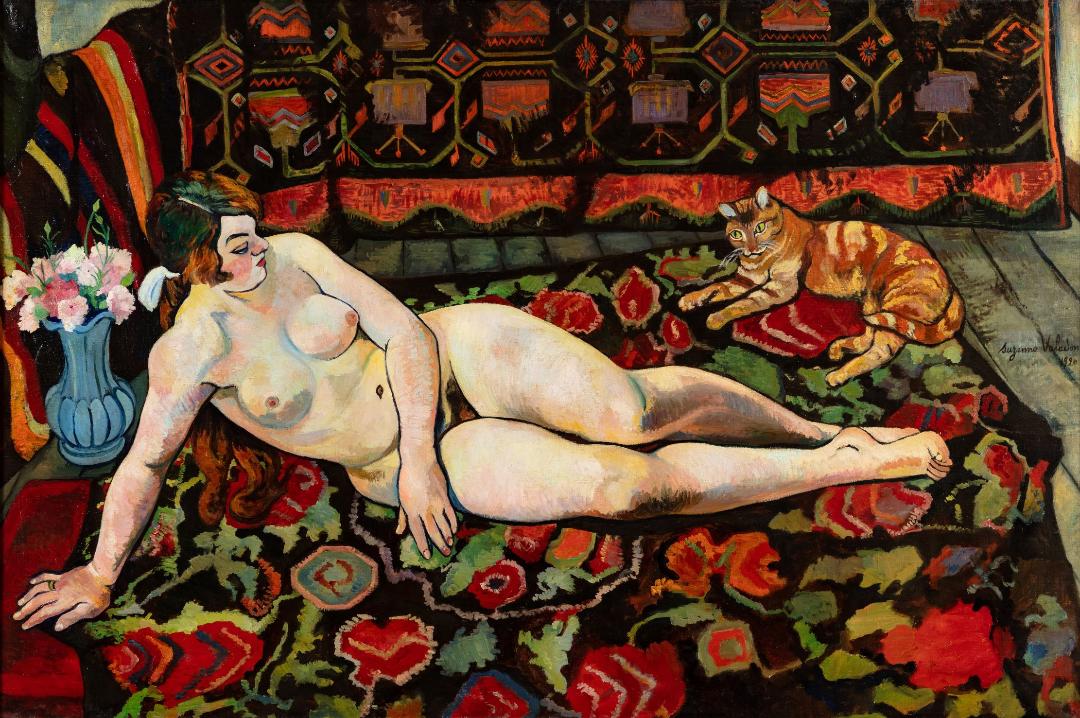Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Luca Zuccala
Leggi i suoi articoliIlaria Bernardi (Pescia, Pt, 1985) ha iniziato il suo percorso curatoriale al Castello di Rivoli sotto la direzione di Carolyn Christov-Bakargiev. Ha poi scelto la libera professione, curando mostre presso istituzioni in Italia e all’estero (tra cui Gnamc, MaXXI e Palazzo delle Esposizioni a Roma; Triennale a Milano; Onu a Ginevra; Parlamento Europeo a Bruxelles...) e collaborando con enti (come l’Associazione Genesi) e fondamentali figure come Germano Celant. Da sempre si è concentrata sull’arte italiana dal dopoguerra ad oggi, promuovendola soprattutto internazionalmente e analizzandola con un approccio storico scientifico.
Partiamo dalla strettissima attualità, la mostra sull’Arte Povera che sta aprendo a Varsavia.
La mostra è dedicata al rapporto tra l’Arte Povera e il Teatro povero del regista polacco Jerzy Grotowski ed è organizzata dagli Istituti Italiani di Cultura di Varsavia e Cracovia. Si aprirà il 9 ottobre all’Istituto Italiano di Cultura di Varsavia per poi spostarsi all’Istituto Grotowski a Cracovia, includendo una giornata commemorativa dei 26 anni dalla scomparsa del regista, il 14 gennaio. Si baserà sui concetti di corpo, azione e replicabilità, fondamentali nel teatro di Grotowski e altrettanto presenti nelle ricerche dell’Arte Povera. Includerà pertanto video e fotografie in cui gli artisti stessi compiono azioni davanti alla cinepresa o davanti al pubblico, unite a un nucleo di multipli in cui il corpo dell’artista è elemento principale di un’immagine «replicabile» come le pièce teatrali. La mostra è il terzo «atto» di un ciclo di esposizioni dedicato all’Arte Povera che ho curato per il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale (Maeci): la prima, tenuta nel 2023 al Wits Art Museum di Johannesburg, ha approfondito lo sviluppo del movimento, dalla sua definizione da parte di Celant (1967) alla sua presunta fine, dichiarata dallo stesso Celant nel 1971; la seconda si è invece tenuta nel 2024 al Museo Nazionale di Bucarest e si è focalizzata sulla sua promozione internazionale attraverso la gallerista Ileana Sonnabend. Queste tre mostre corrispondono alle prime esposizioni dedicate all’Arte Povera nei rispettivi Paesi ospitanti, e quella in Sudafrica anche alla prima nell’intero continente africano.
Appare allora imprescindibile una riflessione sul ruolo della diplomazia culturale, specialmente per l’Italia.
Dal 2018 ho avuto la fortuna di curare diverse mostre in collaborazione con il Maeci, volte alla promozione dell’arte italiana all’estero, soprattutto, in importanti musei e spazi espositivi locali. Per l’Italia, la cultura è un elemento essenziale della sua identità nel mondo e rappresenta un patrimonio materiale e immateriale cui attingere per affrontare le sfide della contemporaneità. La promozione culturale occupa pertanto un ruolo fondamentale nella politica estera del nostro Paese e costituisce uno dei principali strumenti di proiezione esterna. Per me è da sempre fondamentale cooperare per la promozione dell’arte italiana all’estero attraverso canali istituzionali capaci di garantire massima risonanza e massima professionalità.
Si esaltano così due elementi cardine della sua figura: il ruolo della curatrice e quello dell’«ambasciatrice».
Per quanto mi riguarda i due ruoli sono inscindibili: prendersi cura del lavoro di un artista, o dell’arte italiana in generale, significa necessariamente pensare anche alla sua promozione, facendo ponte tra l’Italia e l’estero. Curare mostre significa certamente raggiungere traguardi importanti nel proprio percorso di curatore ma, a mio avviso, senza un obiettivo meno personalistico e di più ampio respiro, il curare rischia di diventare qualcosa di fine a sé stesso e, perciò, non troppo utile all’arte. Mettersi invece a servizio dell’arte del proprio Paese, per cooperare alla sua promozione internazionale, conferisce al mestiere di curatore un senso e una responsabilità ben più alti.
Perché fin dall’inizio ha voluto specializzarsi nell’arte italiana dagli anni ’60 ai giorni nostri?
Innanzitutto perché ritengo essenziale conoscere la cultura dove si è nati per poi confrontarsi con il mondo. Inoltre, ho sempre temuto l’esterofilia che percepivo in alcuni contesti: ricordo che, dopo aver curato le mie prime mostre, più persone del settore mi suggerirono di cercare lavoro stabile in uno spazio espositivo all’estero, sia perché l’offerta lavorativa era più ampia, sia per avere un più immediato riconoscimento in Italia e, dunque, una facilità nel trovare un posto di prestigio nel nostro Paese al rientro. Non nego una certa veridicità in queste affermazioni, ma questa «esterofilia pianificata» mi sembrava paradossalmente molto provinciale: ero certa che una possibilità di lavoro ci fosse anche in Italia e anche occupandosi di arte italiana. Anziché trasferirmi stabilmente all’estero, ho quindi preferito seguire il modello di alcuni curatori italiani della fine degli anni ’60/inizio ’70 che, da curatori «indipendenti», viaggiavano nel modo, promuovendo l’arte italiana e facendola dialogare con quella estera.

Ilaria Bernardi con il presidente della Repubblica Sergio Matterella alla mostra «Ileana Sonnabend & Arte Povera» al Museo Nazionale di Bucarest, 2024
Nel suo percorso traspare un altro dei suoi principi: mettersi al servizio delle istituzioni.
Finora ho sempre preferito essere curatrice freelance per avere la libertà di proporre progetti da me ideati e svilupparli relazionandomi con team sempre differenti, ampliando di conseguenza le mie «vedute». Al contempo, tuttavia, fin dall’inizio ho cercato di assumere un approccio molto istituzionale, lavorando quasi esclusivamente con musei e fondazioni, oltre al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Non credo sia però sufficiente lavorare con le istituzioni per avere un approccio istituzionale. È necessario imparare le «regole» del lavoro in un’istituzione, sia pratiche, sia manageriali, sia finanziarie sia di «public relation», studiandone i meccanismi e facendoli propri, pur mantenendo la libera professione. Per farlo, ho voluto volontariamente cimentarmi in ogni mansione intrinseca al museo: non solo quella prettamente curatoriale/concettuale, ma anche quelle di manager, registrar, archivista, fundraising, ufficio stampa, in quanto ritengo che non si possa dirigere un team per realizzare una mostra senza prima essere stati al loro posto e aver compreso le regole del loro specifico lavoro. Per mia natura, sono lontana dall’essere un «curatore personaggio», così come dal vedere gli enti per cui lavoro come un trampolino di lancio per qualcos’altro: la mia attitudine è sempre stata quella di mettermi a servizio dell’istituzione committente della mostra, ogni volta come se ci lavorassi da sempre e dovessi lavorarci per sempre. Solo così posso svolgere davvero un buon servizio cha va oltre il mio percorso individuale e diventa qualcosa di allargato, di pubblico e collettivo. Il modello di riferimento per questo tipo di approccio è senz’altro (almeno per me) Ida Gianelli che, nei suoi 18 anni di direzione del Castello di Rivoli, si è messa a completo servizio del museo, evitando personalismi e autocelebrazioni, per lavorare con estremo rigore a costruire un valido team e una eccellente programmazione espositiva, educativa ed editoriale, rendendolo un polo imprescindibile per l’arte contemporanea. Ovviamente, l’ideale sarebbe unire l’approccio istituzionale a quello di «curatore eroe» sviluppato da Harald Szeemann e poi, in modo diverso, da Germano Celant, creando «mostre manifesto» capaci di incidere nel dibattito artistico e sociale, stando in prima linea nella costruzione di senso dell’arte contemporanea. Tuttavia, dobbiamo anche essere realistici: di Szeemann e di Celant non ne nascono molti. A mio avviso è pertanto preferibile l’obiettivo di lavorare con estremo rigore, professionalità, analiticità, rispetto per l’arte, per gli artisti e per le istituzioni committenti, organizzando mostre di qualità capaci di soddisfare sia chi le fa sia chi le fruisce.
Parallelamente alla curatela, si è occupata di archivi e pubblicazioni derivate dai suoi studi d’archivio. Che cosa le ha lasciato e insegnato lavorare con gli archivi?
Prima di intraprendere la mia attività curatoriale, ho dato molta valenza alla formazione accademica (conseguendo un Dottorato di ricerca e l’Abilitazione scientifica nazionale in Storia dell’arte) per avere uno specifico metodo storicistico e perché senza conoscere il passato non si può comprendere il presente. È dalla ricerca accademia che ho capito l’importanza degli archivi e del metodo di ricerca che passa attraverso l’archivio: è un’educazione all’ordine, alla pazienza, alla fiducia, al ragionamento. Da qui i miei primi lavori per archivi di artisti e collezionisti privati, nonché l’insegnamento, dal 2018, ad AitArt-Associazione Archivi d’Artista Italiani e l’insegnamento in «Archivi d’artista» dal 2022 alla Iulm di Milano. Anche dopo aver intrapreso l’attività curatoriale, l’archivio è rimasto il mio punto di riferimento, condividendo l’insegnamento celantiano di «critica acritica», basata su fatti e documenti, dunque necessariamente sull’archivio. L’archivio degli artisti è per me fondamentale nella costruzione non solo delle mostre ma, anche, delle pubblicazioni che infatti imposto per lo più come monografie piuttosto che come cataloghi; questo sia che si tratti di artisti ormai storicizzati sia che si tratti di artisti giovani. Ritengo infatti che il genere bibliografico della monografia dal taglio retrospettivo, effettivamente svincolata oppure, comunque, svincolabile da una mostra, non debba essere riservata solo alla consacrazione di artisti ormai storicizzati, ma sia uno strumento utile per affermare e supportare il lavoro dei più giovani artisti nell’ambito del sistema dell’arte internazionale. Credo inoltre che il principale obiettivo del curatore sia storicizzare il presente, attraverso ricerche d’archivio, una contestualizzazione storico artistica, la costruzione di una cronologia dell’attività dell’artista, uno studio delle fonti, allo scopo di fornire una prima analisi scientificamente approfondita sull’opera dell’artista, da cui possono nascere pubblicazioni e mostre di ben più ampio respiro.
Se dovesse citare quattro tra le sue pubblicazioni che più rispecchiano questo metodo?
Giulio Paolini. Opere su carta (Prinp Editore, 2017) frutto di molti anni di studio nell’archivio dell’artista al fine di catalogare e interpretare per la prima volta la sua (allora mai studiata) produzione di disegni e collage su carta. La Tartaruga. Storia di una galleria (postmedia books, 2018) in cui ho ricostruito per la prima volta l’intera attività espositiva della galleria fondamentale negli anni Sessanta per lo sviluppo della cosiddetta Scuola di Piazza del Popolo, con artisti come Mario Schifano, Franco Angeli, Pino Piscali, Jannis Kounellis… La monografia Marinella Senatore (Silvana Editoriale, 2022), in cui, in circa 370 pagine, attraverso una cronologia dettaglia, ho ricostruito i suoi primi vent’anni di attività. Il volume appena uscito su Louise Nevelson (Silvana Editoriale, 2025) che, a parte l’appendice sulla mostra che ho curato a Palazzo Fava a Bologna, include un ampio testo cronologico corredato da fotografie di archivio sulla vita personale e professionale dell’artista.

Ilaria Bernardi con Enzo Cucchi durante l’allestimento della sua mostra personale alla Fondazione Malvina Menegaz, Castelbasso-Teramo
Attualmente, dal 2020, si occupa dell’attività espositiva dell’Associazione Genesi: come ha impostato questo percorso?
L’Associazione Genesi, nata nel 2020 per volontà di Letizia Moratti, che la presiede, è impegnata nella difesa dei diritti umani attraverso l’arte contemporanea, con l’obiettivo di contribuire alla creazione di una cittadinanza più responsabile e socialmente attiva. Per farlo, ha dato avvio alla Collezione Genesi, selezionando opere d’arte di artisti di tutto il mondo e di diverse generazioni, che riflettono sulle urgenti, complesse e spesso drammatiche questioni culturali, ambientali, sociali e politiche coeve. Una volta fondata l’Associazione e dato avvio alla Collezione, Letizia Moratti desiderava far conoscere Associazione e Collezione. Da qui nasce il mio coinvolgimento, con la richiesta di ideare una prima proposta espositiva. Mi è stato subito chiaro che per delineare un progetto davvero educativo, la sola mostra delle opere della Collezione in un’unica sede non sarebbe stata sufficiente. Per essere davvero inclusivo, il progetto avrebbe dovuto optare per un’itineranza prima in Italia e, in seguito, anche all’estero, così da includere più comunità possibili e così da andare metaforicamente incontro ai visitatori e non viceversa. Inoltre, avrebbe dovuto concepire un vero e proprio programma educativo, di pari importanza rispetto alla mostra, teso a fornire strumenti di conoscenza interdisciplinare in merito ai diritti umani al fine di coinvolgere il più ampio pubblico possibile. Per farlo sarebbero stati utili partner istituzionali a cui affidare specifici programmi educativi: Università Cattolica del Sacro Cuore, Fai Ponte tra Culture, Fondazione Gariwo, Robert F. Kennedy Human Rights-Italia. Così facendo, nei suoi primi anni di attività, l’Associazione Genesi non ha proposto solo una mostra, ma si è piuttosto presentata come un museo itinerante che si sposta in Italia e all’estero con la propria Collezione e con le proprie attività educative.
Nel 2025 c’è stata una svolta nell’attività dell’Associazione: in che cosa consiste?
Dopo i primi tre anni di attività, certi che l’Associazione fosse ormai conosciuta sul territorio, abbiamo potuto fare il passo al quale fin dall’inizio miravo: dal 2025 l’Associazione ha iniziato a svolgere tutte le funzioni tradizionalmente attribuite a un museo d’arte contemporanea, ma associandole a un format itinerante utile a renderla il primo e unico museo d’arte contemporanea itinerante italiano. Accanto a una mostra all’anno dedicata alla propria Collezione che, come in ogni museo costituisce il «percorso permanente» da rileggere di volta in volta attraverso uno specifico percorso espositivo, dal 2025 l’Associazione ha dato avvio a una serie di mostre dedicate a grandi artisti ormai storicizzati, non ancora presenti nella propria Collezione, la cui vita o il cui lavoro può essere interpretato, ex-post, come anticipatore di tematiche sociali oggi divenute urgenti. Di questa programmazione fanno parte le mostre sulla protofemminista Louise Nevelson (Kiev, 1899-New York, 1988) e su Fabio Mauri (Roma, 1926-2009), su tema dell’oppressione, rispettivamente a Bologna, a Palazzo Fava, dal 30 maggio al 20 luglio 2025, e a Milano, in Triennale, dal 3 dicembre 2025 al 15 febbraio 2026. Queste mostre sono accompagnate da una nuova collana editoriale dell’Associazione, costituita da libri monografici sugli artisti della mostra. Inoltre, l’Associazione, già dal 2024, ha avviato la commissione di opere a giovani artisti italiani da esporre in mostre personali prodotte dall’Associazione in collaborazione con altri enti (la prima è stata quella di Binta Diaw alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo) al fine di supporto della giovane arte italiana connessa a tematiche sociali.
Per concludere, a quale mostra curata finora è più legata?
È naturale che l’ultima mostra sia sempre percepita come la più importante perché la più recente. Tuttavia, rimango profondamente legata alla mia prima mostra all’estero, «Young Italians», co-organizzata da Magazzino Italian Art e dall’IIC New York perché incarna perfettamente lo sguardo bifronte che mi connota; da un lato rivolto al passato e dall’altro al presente. Young Italians, infatti, ha reso omaggio all’omonima mostra tenutasi nel 1968 all’Institute of Contemporary Art di Boston e al Jewish Museum di New York, dedicata alla giovane arte italiana di allora, attraverso una sorta di seconda edizione, presentando 12 giovani artisti italiani di oggi per indagare i possibili fil rouge della ricerca artistica del nostro Paese, nonché i suoi legami (per analogia o differenza) con quella del passato.

Ilaria Bernardi con Michelangelo Pistoletto a Citadellarte, Biella 2024
Altri articoli dell'autore
«Sono aumentati i visitatori, i finanziamenti privati, gli incassi, le donazioni. Il patrimonio è cresciuto e la sede si sta modernizzando. Anche nell’Ala Cosenza progettata da Mario Botta», spiega la direttrice
Sul numero di gennaio, il 468, il direttore Luca Zuccala tira le somme dei primi 10 numeri del nuovo corso
L’autorevole classifica del 2025 di «ArtReview»: dall’emergere degli Stati del Golfo alle voci della Global Majority, dalle grandi reti agli artisti tuttofare, il ritratto di un sistema in trasformazione
La capitale francese ospita la tradizionale asta di arte moderna e contemporanea di Sotheby's con quasi 200 lotti selezionati e una narrazione curatoriale che conferma la nuova strategia della sede di Parigi