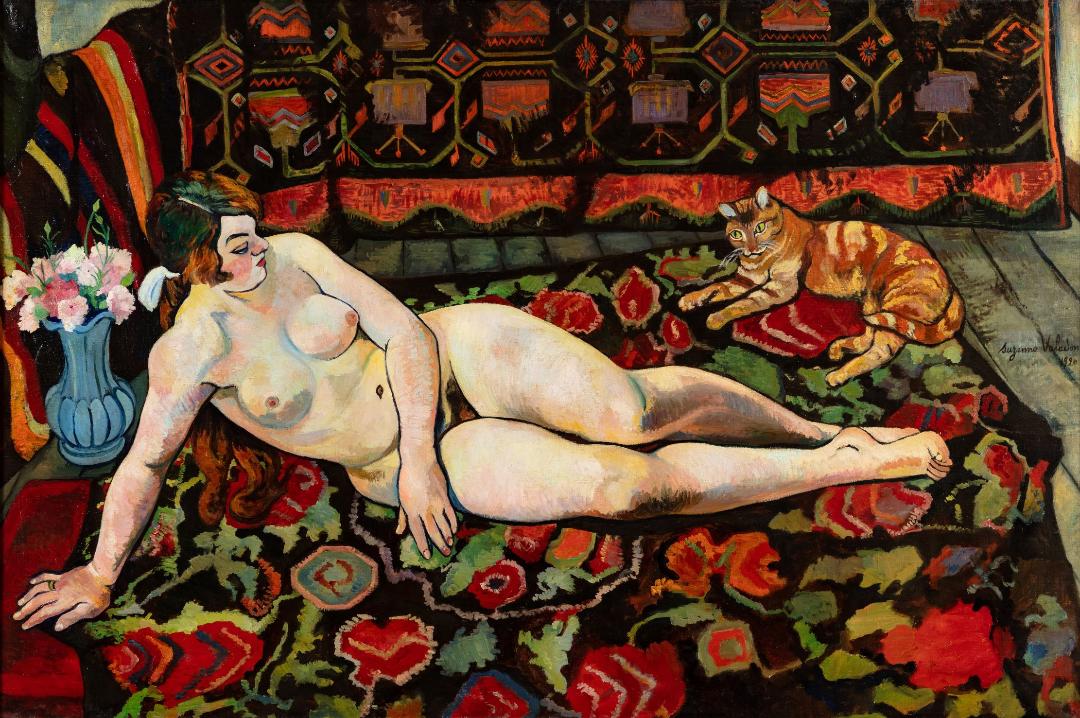Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Luca Zuccala
Leggi i suoi articoliParigi, Rue Bonaparte, giovedì 16 ottobre 2025. Tre coordinate che fanno un indizio, di più: un'inaugurazione. Cosa succede oggi a due passi da Saint-Germain-des-Prés?
Inauguro Galerie Bonaparte, la mia galleria dedicata al design italiano. È un progetto che porto dentro da molti anni, nato dal desiderio di raccontare il design come linguaggio culturale, come racconto di vita e di identità. Quando mi sono trasferita a Parigi due anni fa ho sentito che era il momento e il luogo giusto, qui c’è una sensibilità profonda per il design e un collezionismo attento, curioso, innamorato del Made in Italy. Ho scelto ottobre perché Parigi, in questo periodo, diventa un crocevia internazionale straordinario grazie ad Art Basel Paris e Design Miami: la città si anima di incontri e passioni condivise tra arte, design e collezionismo. Aprire in quei giorni significa inserirsi in questo flusso vitale, nel cuore di una comunità globale che guarda al design come forma d’arte e di cultura.
Il tutto nel quartiere più bello di Parigi…
Saint-Germain-des-Prés è un quartiere che ha respirato letteratura, filosofia e arte. Ogni strada custodisce una storia, ogni caffè un frammento di pensiero. Mi piace la sua eleganza un po’ discreta, quella bellezza che non ha bisogno di imporsi ma semplicemente esiste.
Come nasce e vuole «semplicemente esistere» Galerie Bonaparte?
Galerie Bonaparte nasce per rappresentare il design italiano del XX secolo, un patrimonio che considero culturale prima ancora che estetico. Sarà la sola galleria a Parigi interamente dedicata al Made in Italy, con l’intento di restituirgli la complessità e la profondità che merita. Il mio obiettivo è mostrare come il design italiano sia nato dall’architettura, da quella capacità tutta italiana di pensare la forma come misura dell’uomo, equilibrio tra funzione e armonia. In fondo, credo che il design italiano non sia solo una scuola di forme, ma una scuola di cultura e di vita: un modo di pensare la bellezza come parte dell’esistenza quotidiana. La mia missione è rappresentare questo patrimonio come un bene culturale vivente, farlo conoscere, comprendere e amare nella sua complessità.
Un atto che «non ha bisogno di imporsi».
Oggi, più che mai, credo che il design debba essere un atto culturale e poetico, non solo estetico e Parigi è il palcoscenico perfetto per raccontarlo.
Quale sarà la prima «messa in scena»?
La galleria inaugura con la mostra “Casa Italia 1930–1960”, curata da me e da Justine Despretz, un percorso che racconta le origini e l’evoluzione del design italiano in un periodo cruciale: dagli anni tra le due guerre fino al boom economico. È un omaggio a quel momento in cui l’Italia, rinata dalle macerie, diventa un laboratorio d’idee e di forme. Attraverso le opere di Gio Ponti, Osvaldo Borsani, Max Ingrand, Paolo Buffa e Paolo De Poli, la mostra esplora la nascita della cosiddetta “casa italiana”: un luogo dove arte, architettura e design si fondono, trasformando la quotidianità in una dimensione estetica e culturale. Non è una semplice esposizione di oggetti, ma un racconto della forma come espressione di un’identità nazionale. Con “Casa Italia” ho voluto dichiarare la visione della galleria: il design come lusso culturale, come eredità viva capace di unire funzione, bellezza e memoria.

Virginia Valsecchi e Casa Italia © Gregory Copitet
A proposito di «eredità viva» c’è una figura -artista, designer, gallerista, curatore- che ha sedimentato in te una luce in questi anni?
I designer che amo sono molti, e ognuno rappresenta una sfumatura diversa della straordinaria versatilità italiana del Novecento. A Parigi, ho sempre ammirato Patrick Seguin e Yves Gastou, per la loro capacità di costruire narrazioni forti intorno al design e di dare alle opere un contesto culturale, non solo commerciale. A proposito di design italiano quando Yves Gastou, aprì la sua galleria negli anni 80 a Rue Bonaparte, inaugurò con una mostra dedicata a Ettore Sottsass fu Jack Lang in persona ad approvare la facciata ideata da Sottsass, in terrazzo bianco e nero dopo settimane di discussioni con le autorità. Un episodio che racconta bene quanto il design italiano sapesse già allora scuotere i confini tra arte, architettura e libertà creativa.
Confini spuri, mondi osmotici. C’è una dimensione, o più semplicemente un progetto, che vorresti rievocare in galleria?
Mi affascina molto la narrazione femminile e nel design, e sono molte le donne che ammiro. In Italia nel 2020 ho prodotto il podcast “Il Design è Donna” per raccontare come la creatività femminile abbia contribuito a ridisegnare il nostro modo di vivere e abitare e le difficoltà che queste donne hanno dovuto affrontare per affermarsi in un mestiere considerato "roba da uomini". E poi non escludo di portare in galleria la dimensione cinematografica…
Cinema e design: galassie che si conciliano in Rue Bonaparte…
Cinema e design sono due mondi intimamente connessi, dato che entrambi costruiscono spazi di racconto. La scenografia è una forma di design narrativo, penso a Mon Oncle di Jacques Tati o a 2001: Odissea nello spazio di Kubrick, dove l’architettura diventa protagonista. Quando progetto una mostra, immagino ambienti come piccole messe in scena, spazi intimi che ricordano un set cinematografico ogni oggetto ha una voce e ha un motivo di racconto, come una battuta in una scena di un film, non è lì a caso. In fondo, allestire una mostra è un po’ come dirigere un film.
Se idealmente potessi far allestire lo spazio da un designer (scomparso) su chi ricadrebbe la scelta?
Sceglierei Ignazio Gardella. Mi affascina il suo equilibrio tra rigore e sensibilità: pensava ogni dettaglio in relazione allo spazio, con una grazia discreta che trasformava la funzionalità in bellezza. Il suo progetto per Azucena di cui è cofondatore con Luigi Caccia Dominioni è un esempio perfetto di come artigianato, architettura e design possano fondersi in un linguaggio unico e senza tempo
Carpiato temporale: nel futuro potresti trattare anche il design contemporaneo?
Sì, è una possibilità che lascio aperta, ma sempre in continuità con la sua radice storica. Mi interessa mostrare come la cultura del progetto italiano continui ancora oggi a evolversi, mantenendo quella capacità di trasformare la materia in emozione, la funzione in poesia.
Concludendo, a bruciapelo. Quale pezzo di design non può mancare in casa Valsecchi?
Tra tutti i pezzi, la Superleggera di Gio Ponti rimane per me un simbolo insuperabile: la perfezione dell’equilibrio tra leggerezza e solidità, tra invenzione tecnica e poesia quotidiana. Ogni volta che la guardo penso che in quella sedia Ponti abbia condensato tutta l’anima del design italiano: la capacità di rendere straordinario l’ordinario, con una leggerezza che è insieme intellettuale e umana.
Museo-rifugio?
Sarà scontato, ma rimane il Louvre. Ho la fortuna di abitare vicino e cerco di andarci ogni venerdì pomeriggio, anche solo per un’ora. Scelgo una sala diversa ogni volta… spesso quelle più silenziose e meno affollate e mi godo, a volte in solitudine, capolavori incredibili. È un piccolo lusso settimanale.
Opera d’arte da cui tornare?
Domanda difficile, perché cambio spesso. Spazio dall’antico al contemporaneo. In questo periodo è Turner che mi ossessiona per il suo modo di lavorare la luce e i paesaggi.

Casa Italia a Galerie Bonaparte © Gregory Copitet
Altri articoli dell'autore
«Sono aumentati i visitatori, i finanziamenti privati, gli incassi, le donazioni. Il patrimonio è cresciuto e la sede si sta modernizzando. Anche nell’Ala Cosenza progettata da Mario Botta», spiega la direttrice
Sul numero di gennaio, il 468, il direttore Luca Zuccala tira le somme dei primi 10 numeri del nuovo corso
L’autorevole classifica del 2025 di «ArtReview»: dall’emergere degli Stati del Golfo alle voci della Global Majority, dalle grandi reti agli artisti tuttofare, il ritratto di un sistema in trasformazione
La capitale francese ospita la tradizionale asta di arte moderna e contemporanea di Sotheby's con quasi 200 lotti selezionati e una narrazione curatoriale che conferma la nuova strategia della sede di Parigi