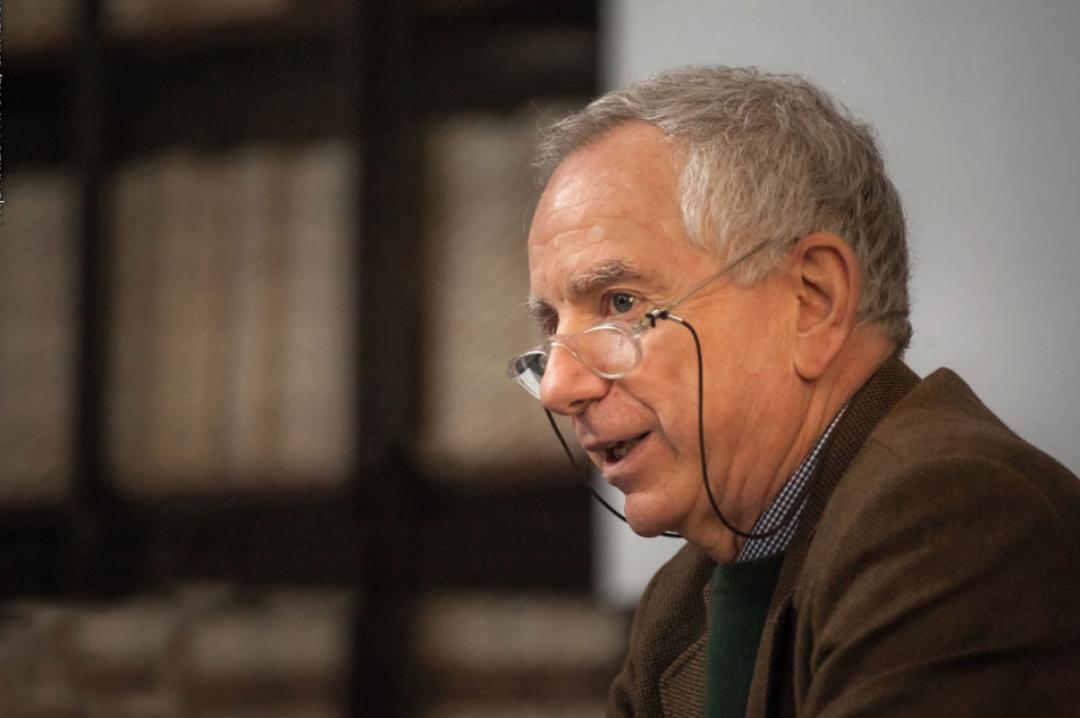Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Da quando è stata inventata, poco meno di due secoli fa, la fotografia ci ha accompagnati passo passo nella vita quotidiana come nei momenti più importanti della vita collettiva. Miliardi di foto sono state scattate da allora, e il loro numero è diventato incalcolabile con l’avvento dei telefoni cellulari. La foto postata sui social, a volte in maniera addirittura compulsiva, ha spazzato via le antiche cartoline. Ma la fotografia è da tempo anche una raffinata forma d’arte, che ha conquistato ampie fette di mercato, tanto che l’opera fotografica, intesa come «opera dell’ingegno», è protetta dalla legge per 70 anni dalla morte dell’autore, come un quadro, una poesia, uno spartito musicale.
Con l’invenzione della stampa nel Quattrocento si è resa possibile non solo la divulgazione di testi letterari, ma anche la rapida diffusione di qualsiasi informazione scritta (avvisi, bandi...), che si è andata affiancando nei secoli alla voluminosa produzione di «scartoffie» manoscritte (uso questo termine colloquiale con tutto l’affetto che meritano i documenti storici di qualsiasi natura), che poi sono state amorosamente raccolte nei nostri archivi pubblici e privati e nelle biblioteche. Testi senza apparenti qualità letterarie, ma specchio fedele delle vite nostre e di chi ci ha preceduto. Da 200 anni, con quelle «scartoffie» hanno cominciato a coabitare centinaia, poi migliaia e ora ormai milioni di fotografie scattate nelle più diverse occasioni a memoria di un evento, privatissimo o pubblico: per il piacere o la necessità di fermare su carta l’immagine di qualcosa che era accaduto e che non si voleva lasciar cadere nell’oblio.
Da molti anni il Ministero della Cultura spende molto denaro pubblico, tempo e intelligenza per digitalizzare questo patrimonio capillare, che documenta la nostra vita di individui e di componenti di una Nazione: milioni (dicevamo) di scatti, che possono avere un valore storico per la nostra identità sociale e culturale, ma anche per le più diverse pratiche amministrative.
La Legge sul diritto d’autore le chiama «fotografie semplici», facendo espresso riferimento alle «immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico» e prive del carattere creativo che connota invece le «opere fotografiche» (art. 87). Le fotografie semplici godono perciò di una tutela ridotta rispetto a queste ultime, al punto che la legge ne permette la libera circolazione dopo vent’anni dallo scatto. Quand’ecco che (se ne è parlato davvero troppo poco in queste settimane) un emendamento votato nello scorso ottobre dal Senato al disegno di legge n. 2655 «Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese» (in discussione da oggi alla Camera, Ndr) ha portato da 20 a 70 anni la libera utilizzazione di queste immagini «semplici», più che triplicando la durata di protezione di cui godevano sinora. Insomma, nel silenzio generale, si sta decidendo che qualsiasi foto scattata d’ora in poi, magari anche per errore con la fotocamera del cellulare, non potrà essere divulgata liberamente se non a partire dal 2095.
La cosa non è passata inosservata al nostro Ministero della Cultura, che per bocca di uno dei suoi sottosegretari ha commentato favorevolmente il fatto che il settore della fotografia, essendo in continua evoluzione, «meriti che le norme che lo regolamentano vengano aggiornate, laddove necessario». Davvero una strana forma di endorsement, che evita di dire perché questo passo così avventato fosse «necessario» e in quale direzione debba semmai andare questo aggiornamento. Visto che la legge del 1941 tutela già il diritto di sfruttamento economico per le «opere fotografiche» fino a settant’anni anni dalla morte dell’autore, di quale necessità si parla se le immagini oggetto del nuovo provvedimento non hanno per definizione valore creativo, ma rappresentano documenti, questo sì, talora preziosi per la storia dell’Italia e dei suoi cittadini?
Varie associazioni di categoria e singoli studiosi, in particolare storici dell’età contemporanea, hanno già espresso in forma sobria e chiara la loro sorpresa e quindi la ferma richiesta di tornare indietro, anche per evitare che futuri e benemeriti progetti di digitalizzazione (che renderanno conoscibili le fotografie che saranno prodotte dal momento dell’entrata in vigore della legge) debbano essere bloccati per oltre mezzo secolo rispetto alla durata di protezione attuale a causa degli ovvi oneri finanziari e amministrativi imposti dalla nuova norma. Tanto peggio se ci dovesse essere un’interpretazione della norma in senso retroattivo. Certo, come è noto, le norme non possono avere effetti retroattivi: se l’emendamento venisse approvato, non dovremmo aspettarci effetti sulle fotografie scattate oltre 20 anni fa. Ma cosa può accadere alle fotografie semplici scattate in questi ultimi 20 anni? La loro tutela potrebbe estendersi fino a 70 anni dalla data dello scatto? Se così fosse il danno risulterebbe certo essere ancor maggiore.
Inutile dire che, oltre che per gli istituti del MiC coinvolti dal provvedimento, le conseguenze della norma, così come attualmente modificata, sarebbero deleterie per le case editrici, le imprese culturali e creative di ogni tipo, i singoli studiosi e cittadini, gli innumerevoli blog che arricchiscono il mondo della comunicazione sociale. Tutti, in breve, troverebbero sbarrata o fortemente impedita la possibilità di raccontare e illustrare il presente, gli anni che stiamo vivendo. È l’attualità stessa delle nostre vite passate e presenti che rischia di essere cacciata in un cono d’ombra. Non solo quella dei grandi eventi, ma quella delle vite quotidiane, che sono lo specchio stesso di noi italiani.
Detto questo, va da sé che uno scatto fotografico, anche quando non voglia avere il carattere di una fotografia d’arte, può essere il prodotto, più o meno riuscito, di più o meno solide competenze tecniche e professionali, giustamente tutelato per vent’anni. E che in questo caso il lavoro dei fotografi va riconosciuto e valorizzato forse più di quanto oggi non accada sul mercato del lavoro nei confronti della loro committenza. Ma lo strumento individuato con questo emendamento «chirurgico» produce, tirando le somme, ben più danni che non benefici. Da un lato è comprensibile che si chieda di andare oltre una distinzione, sempre opinabile, tra fotografie «semplici» e fotografie «opere dell’ingegno» a difesa del lavoro del fotografo da possibili usi speculativi. Dall’altro si fa osservare che per fotografie di carattere documentario prive di palese espressività creativa vent'anni è comunque un lasso di tempo assai ampio che permette un’adeguata protezione e remunerazione.
Credo che, da entrambi i punti di vista, ci possa essere convergenza di interessi nel richiedere una riflessione più profonda circa la regolamentazione dell’uso libero di materiali protetti da diritti d'autore, fondamentale nelle società della comunicazione globale, dalla più semplice delle immagini a quelle assunte nell’empireo dell’opera d’arte. Oggi purtroppo la liceità degli usi è affidata al giudizio della Magistratura, con tutti i limiti che questo può portare con sé in termini di incertezze sul valore documentario, creativo, estetico dell’opera il cui uso è sottoposto a contenzioso. Insomma, modificando con un minimo tratto di penna da «20» a «70», una sola parola della legge sul diritto d’autore, si spazza via il virtuoso bilanciamento sin qui esistente fra la tutela dell’interesse economico individuale e quella dell’interesse pubblico, che mira innanzitutto alla diffusione dell’informazione e del sapere, e che si basa quindi anche sulla libera circolazione delle fotografie di valore documentario.
La mia impressione è che siamo caduti in un grande equivoco, pensando di valorizzare il lavoro dei fotografi professionisti a danno del resto della popolazione e in primis di quel meraviglioso patrimonio fotografico, prodotto collettivo di un’intera Nazione, che conserviamo con cura e attenzione mettendolo (altrimenti a che cosa servirebbe?) alla libera disposizione di tutti vent’anni dopo la sua produzione. Questo equivoco non nasce ora, ma sta nelle stesse definizioni di «opera d’arte», «opera dell’ingegno», «opera creativa», «opera con valore documentario», che abitualmente usiamo e che faticano a trovare puntuale riscontro nelle disposizioni di legge. Basti pensare che l’artisticità di una fotografia è valutazione mutevole nel tempo in relazione con la dimensione culturale e la sensibilità estetica di chi ne dovrebbe godere, anche se una perdurante concezione idealistica dell’opera d’arte tende a caricarla di un valore assoluto.
In campo culturale per «opera dell’ingegno» intendiamo (come sancito dalla Corte di Cassazione) quei prodotti che hanno carattere creativo, nel senso che esprimono una compiuta originalità, e insieme innovativo. È evidente che tali qualità possono ritrovarsi anche in opere fotografiche prodotte a solo fine documentario, eppure capaci di proporre una novità sul piano della informazione e di manifestare una originalità nel contenuto e nella forma espressiva, perché comunque prodotte da una scelta consapevole. Senza cadere nella retorica della creatività, paradossalmente ogni scatto fotografico può rientrare in queste caratteristiche; la sua eventuale artisticità non sarà comunque un valore in sé ma un valore percepito, e in quanto tale mutevole.
In conclusione, se il fotografo (così come il grafico o un qualunque altro operatore creativo) ha il diritto di essere remunerato per il lavoro che svolge, fondamentale soprattutto oggi per l'importanza delle immagini nella comunicazione globale, e ha il diritto di essere messo nelle condizioni di esercitare al meglio la propria professione, occorre tenere conto anche del fatto che a ogni estensione di un regime di monopolio corrisponde sempre una contrazione del pubblico dominio con effetti che si ripercuotono sulla circolazione delle informazioni e sulla loro disponibilità sociale (tanto più se digitale). Ne deriva una forte limitazione dell'accesso alla cultura, e quindi anche dell'attività di digitalizzazione nella quale sono impegnati molti istituti coordinati dal Ministero della Cultura. L'equilibrio, insomma, è molto delicato. Con tutto il rispetto per la libera attività legislativa del Parlamento, il Ministro della Cultura ha comunque il diritto/dovere di far valere, a sua volta, gli interessi generali di cui il suo Dicastero è portatore, auspicando che questo emendamento venga soppresso quando il disegno di legge sarà all’attenzione della Camera dei Deputati. Sono già numerose le associazioni culturali e professionali che l’hanno richiesto, ma saremmo certamente molti di più a rendere grazie al ministro Giuli se vorrà intervenire perché questo accada.
Altri articoli dell'autore
A partire cronologicamente dalle citazioni di un fascinoso antiquario cinquecentesco, lo studioso e divulgatore Andrea Augenti ripercorre le vite di alcuni dei maestri del passato di questa disciplina
L’ultimo libro di Giuliano De Felice per Laterza secondo Daniele Manacorda opera una «“scelta di campo” rischiosa»
L’archeologo Daniele Manacorda traccia una road map per il neonominato al dicastero del Collegio Romano
Il vero problema sembra essere la nuova (vecchia) organizzazione per Dipartimenti, già varata ai tempi del ministro Buttiglione e presto abbandonata non per motivi politici, ma perché ritenuta non adeguata a un Dicastero come quello della Cultura, capillarmente distribuito sul territorio