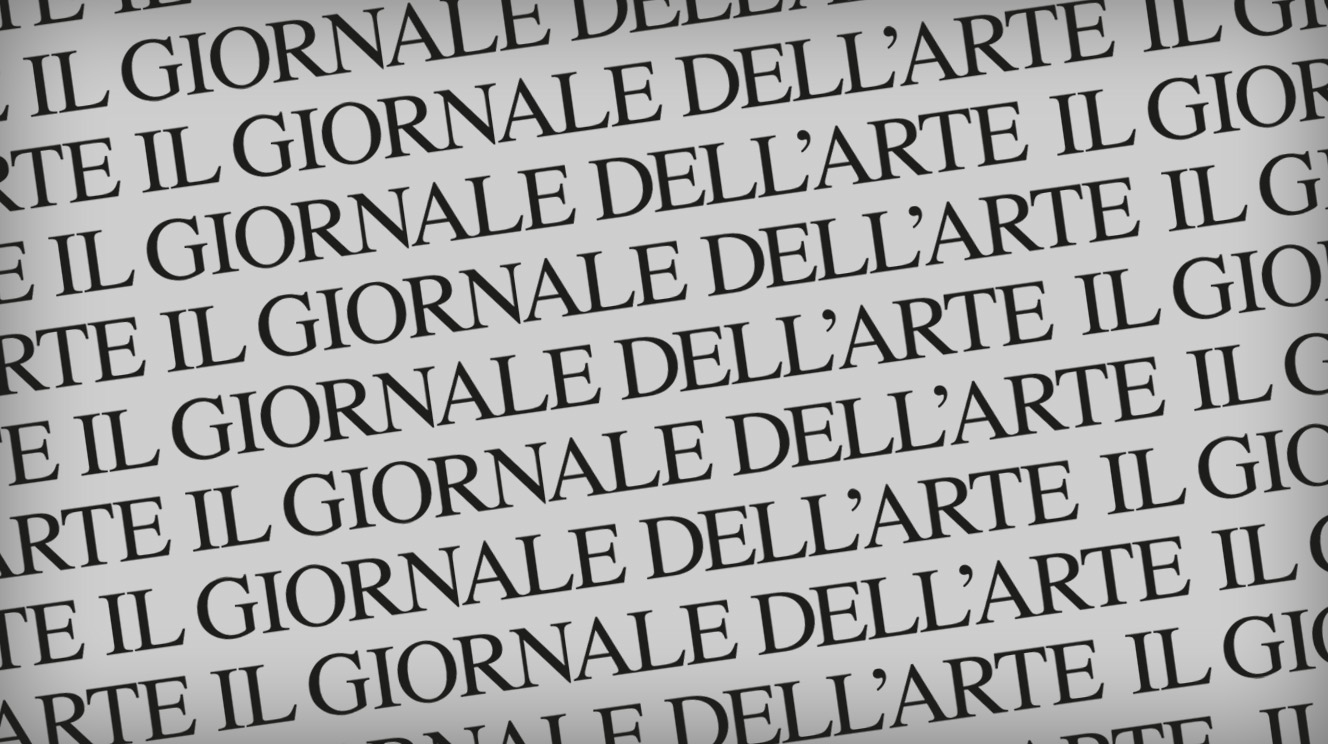Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Redazione GDA
Leggi i suoi articoliLa tutela dell’arte è considerata principio fondamentale della nostra Costituzione e addirittura valore primario e supremo dell’ordinamento, da «non poter essere sovvertito o modificato nel suo contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale od altre leggi costituzionali». Anche a livello europeo viene proclamata diritto fondamentale e inserita nell’art. 13 della Carta dei diritti Ue. Questo perché l’arte è forse lo strumento più forte dato alle minoranze per esprimere il dissenso, a prescindere (da qui la sua eccezionalità) dalla forma di Governo esistente: essa è e sarà sempre una porta verso il pluralismo.
A patto che sia arte, ovvero, a patto che sia libera. «L’arte e la scienza sono la libertà stessa nella sua forma più alta, dire che arte e scienza sono libere è come dire che la libertà è libera»: questo il pensiero del Costituente che non a caso le riserva una tutela specifica e più intensa rispetto alle altre manifestazioni di pensiero dell’art. 21, elevando l’art. 33 a «materia cosiddetta privilegiata», non soggetta al limite del buon costume: l’arte può essere e «usare dell’osceno»; prova ne è l’art. 529 del Codice Penale.
Già nel lontano ’48 quindi, forse a sua stessa insaputa, il nostro Costituente è stato ancora una volta così lungimirante nel rivolgere particolare attenzione al fenomeno artistico da indovinare che proprio oggi quello dell’arte sarebbe stato uno dei mercati che muove più denaro a livello globale, in cui si parla di un fatturato di Christie’s e Sotheby’s pari a 13 miliardi di dollari nel 2014 (cfr. n. 350, feb. ’15, p. 46), in piena crisi economica (!), rispetto ai 5,9 del 2005.
Come spiegare allora la carenza normativa in materia riscontrabile nell’ordinamento italiano?
Se a livello teorico-ontologico potrebbe sembrare facile tratteggiare una linea di confine tra libertà artistica e libera manifestazione del pensiero, nella realtà dei fatti non vi è legislazione né casistica giurisprudenziale in grado di fornire dati costanti (e sufficienti) a tutelare l’attività artistica, in fieri o già conclusa; sicché l’artista si trova costantemente nell’aleatoria, quanto tragica, alternativa di realizzare un’opera d’arte o, con la medesima condotta, commettere un fatto di reato.
Per quanto poi riguarda il momento successivo a tale attività di creazione e produzione artistica, nel silenzio del legislatore è la prassi a dettare le regole del gioco identificando nel certificato d’autentica il vero garante della sicurezza della circolazione delle opere d’arte, nel mercato europeo e internazionale. Ma il valore di quest’affermazione può essere compreso solo se letta contestualemente alla constatazione che a oggi in Italia
– non esistono norme che stabiliscano quali requisiti formali debba avere un’autentica d’opera d’arte (nonostante il richiamo dell’art. 64 Codice dei Beni culturali);
– chi la possa rilasciare e che peso attribuire al suo giudizio;
– non c’è alcun albo professionale di periti esperti d’arte né ente chiamato a controllare la loro preparazione;
– non vi sono criteri economici di riferimento per stabilire il costo di un’expertise;
– sono pressoché inesistenti le norme sulle Fondazioni o Archivi di artisti, ossia gli enti spesso preposti al rilascio delle autentiche (gestiti dagli eredi degli artisti che sono portatori anche di interessi economici sulle opere come il cosiddetto diritto di seguito), che si attribuiscono un carattere di «ufficialità». In realtà la legge sul diritto d’autore non attribuisce loro alcun diritto in via esclusiva sulla facoltà di autentica; tanto più che in un giudizio sulla falsità o meno di un’opera, la testimonianza dell’autore stesso sul riconoscimento della paternità dell’opera non ha più peso di quella di qualsiasi altro testimone (ex art. 9 Legge 1062/1971).
Viceversa si rileva un accurato intervento dello Stato nella disciplina di quei beni privati che egli stesso reputi di «interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante» o «eccezionale» (art. 10/3 Codice dei Beni culturali), che legittima fortissime interferenze e limitazioni al godimento della proprietà privata.
Al legislatore allora domandiamo: è possibile realmente parlare di sicurezza nel mercato dell’arte? Senza criteri da rispettare nella redazione di un certificato di autentica e considerato l’enorme impatto economico determinato dalle autentiche nel mercato dell’arte, come può infatti essere garantita la tutela delle opere d’arte e di chi opera nell’arte? L’affidabilità del documento e della persona/ente che lo emetta? Con quali criteri lo Stato riesce a decidere quando un’opera d’arte risulti talmente importante da divenire un «bene culturale» (ex art. 12 Codice dei Beni culturali), se non dispone degli strumenti per decidere, a monte, quando un’opera sia arte e per determinare quale sia il suo valore effettivo (in base a un giudizio di certezza o quantomeno di probabilità)?
L’arte ha bisogno che venga costruita una tutela giuridica attorno ad essa, capace di disciplinare sia il momento, per così dire, iniziale dell’espressione artistica, cioè quel «facere» creativo che sfocia in un bene (materiale o immateriale), divenendo opera d’arte; sia il momento successivo alla produzione, strettamente legato all’aspetto economico, che attiene invece alla sua tracciabilità, prova e commercio.
Diversamente, a fronte dei dati sopra richiamati e della rilevanza attuale del fenomeno artistico, la libertà proclamata all’art. 33 della Costituzione e 13 della Carta dei diritti Ue, se rimane sprovvista di una sua regolamentazione attuativa non può che diventare, inesorabilmente, sinonimo di anarchia e motivare un fondato scetticismo per l’assenza di un suo nesso causale con gli investimenti esponenziali che riscontriamo nel mercato dell’arte negli ultimi anni.
Altri articoli dell'autore
L’Associazione archeologi del Pubblico Impiego (Api-MiBact) ha inviato una nota al Ministero della Cultura e a quello della Funzione Pubblica, nonché ai membri delle Commissioni cultura di Camera e Senato, per esprimere il proprio dissenso per il bando per 75 posti nell’area dell’elevate professionalità (Ep), le cui domande di partecipazione vanno presentate entro il 26 giugno
Il premio Nobel e il direttore del Museo Egizio si sono incontrati per parlare di musei e romanzi: «Sono simili: sono i “luoghi” in cui avviene l’interpretazione del significato della nostra vita, nei quali riflettere su sé stessi»
Anche quest’anno Tag Art Night, la Notte delle Arti Contemporanee, propone un palinsesto di mostre diffuse sul territorio cittadino
Rimodulate le competenze e modificato la struttura organizzativa: dal Segretariato generale al modello dipartimentale