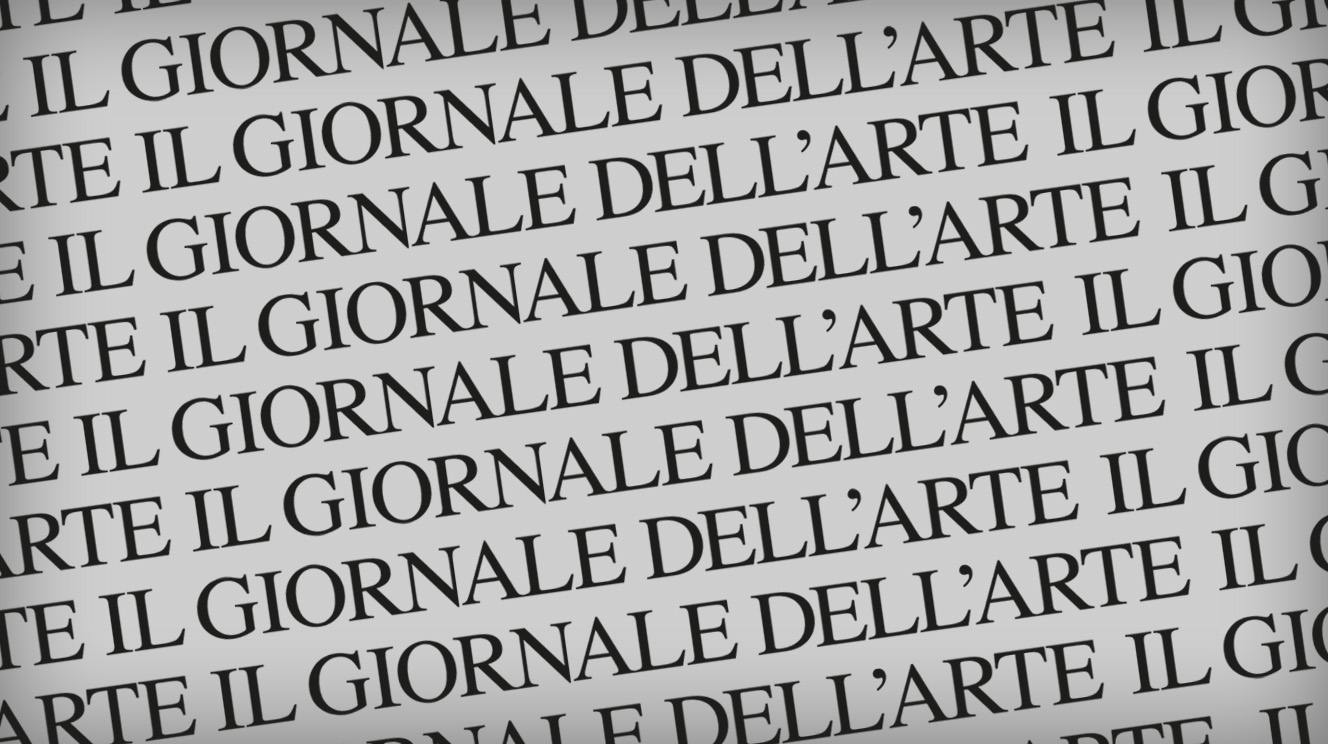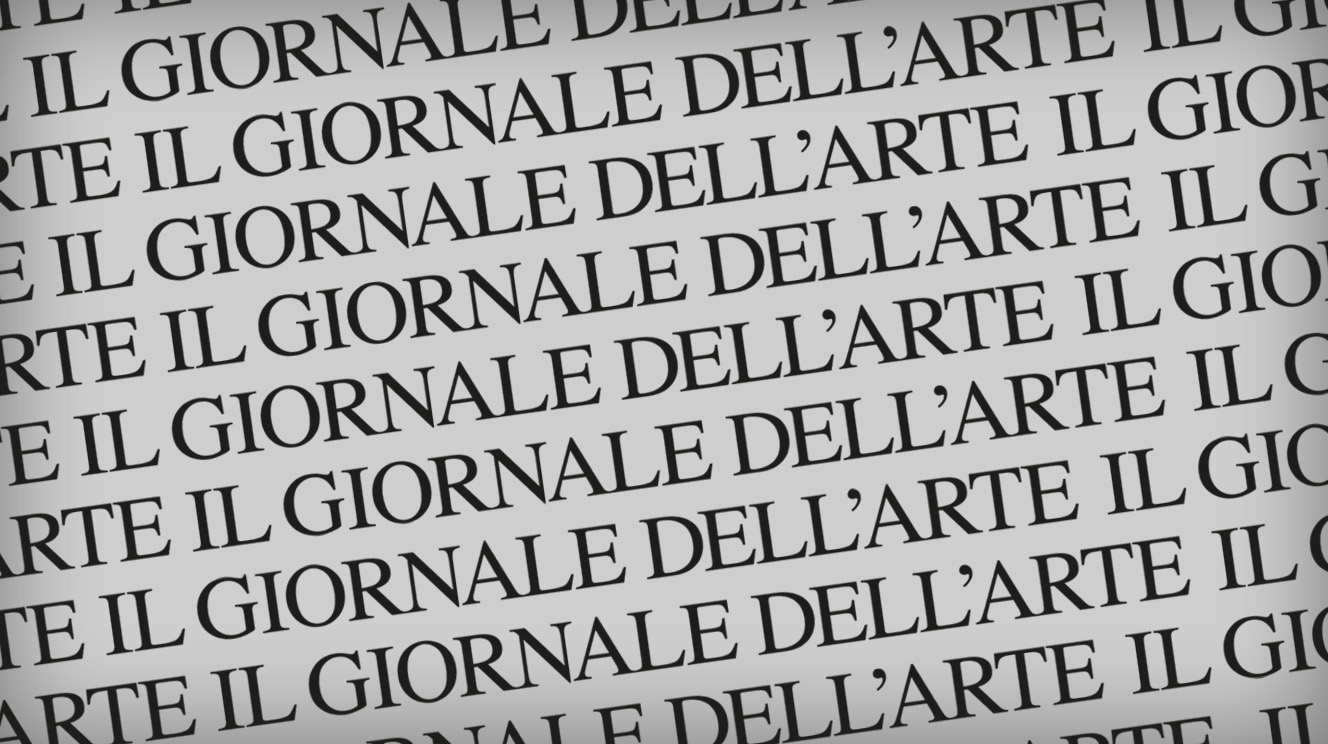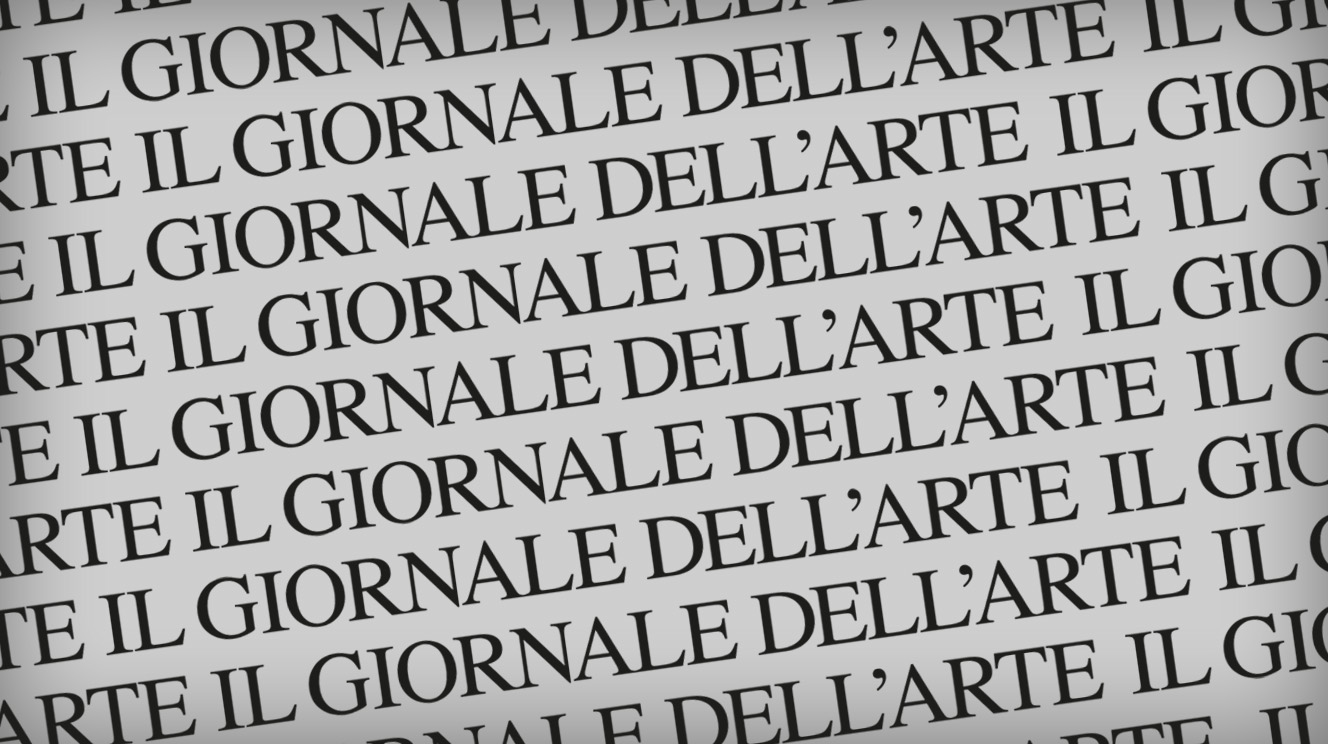Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Susanna Paparatti
Leggi i suoi articoliRoma. Sono stati necessari tre anni di lavoro per organizzare la mostra «Matisse. Arabesque», aperta dal 4 marzo al 21 giugno alle Scuderie del Quirinale, che sottolinea da un lato il fascino che l’Oriente, conosciuto dal pittore francese (1869-1954) durante numerosi viaggi, ebbe nel suo lavoro, dall’altro la rivoluzione che egli operò sulla superficie e lo spazio, quasi fosse scenografo delle sue stesse raffigurazioni, composte con meticolosa cura fra le pareti dello studio. «Di Matisse mi ha sempre colpito la bidimensionalità degli spazi sulla tela, spiega Ester Coen, curatrice della mostra, affiancata dal comitato scientifico composto da John Elderfield, Remi Labrusse e Olivier Berggruen. Quando le Avanguardie lavorano alle destrutturazioni e alle deformazioni, lui è interessato agli arabeschi, ai tessuti, ai modelli di arte barbarica». Ed è proprio per illustrare al meglio il rapporto fra l’artista e queste fascinose contaminazioni, che renderanno gli ambienti rappresentati squarci verso culture lontane tradotte e divenute proprie, che la rassegna va oltre la semplice esposizione di tele e disegni. Divise sul filo di un percorso tematico più che cronologico, le dieci sale riuniscono oltre cento opere (compresi alcuni inediti come la celebre «Zohra sulla terrazza», 1912, dal Museo Puskin di Mosca) che giungono dai principali musei internazionali quali il Philadelphia Museum of Art, la National Gallery of Art di Washington, l’Ermitage di San Pietroburgo, il MoMA di New York, il Centre Pompidou di Parigi, la Tate di Londra, la Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli di Torino, e da alcune collezioni private.
Particolare attenzione però va data agli oltre cento oggetti e complementi che, racchiusi in apposite vetrine collocate a fianco di dipinti e disegni, sottopongono all’attenzione elementi cari a Matisse, facilmente rintracciabili nelle sue ambientazioni: non perché siano appartenuti al maestro bensì per assonanza di stili e provenienze. L’artista infatti è assetato e curioso collezionista di oggetti e tessuti d’ogni parte del mondo e li usa nell’atelier ricreando ambientazioni nomadi. Un non semplice censimento stilato dalla curatrice ha portato alle Scuderie del Quirinale oggetti anch’essi provenienti da musei internazionali, dal Metropolitan di New York al Victoria & Albert di Londra: «C’è solo una rafia Kuba con disegno geometrico realmente appartenuta a Matisse, prosegue Ester Coen, ma numerosi altri oggetti sono stati accuratamente selezionati al Museo Nazionale Preistorico Etnografico Luigi Pigorini e a quello di Arte Orientale di Roma, al Mao di Torino, a Ca’ Pesaro di Venezia, al Museo Nazionale del Bargello e al Mic di Faenza». Pur con prestiti arrivati parzialmente dalle medesime istituzioni questa mostra offre una chiave di lettura diversa dalla rassegna «Matisse, la figura. La forza della linea, l’emozione del colore», ospitata lo scorso anno al Palazzo dei Diamanti di Ferrara (cfr. n. 339, feb. ’14, p. 30). Alle Scuderie del Quirinale infatti la figura femminile, pur indiscussa musa del maestro francese, è attrice delle ricostruzioni sceniche orientali che preludono a successivi dipinti e disegni. I veri protagonisti della mostra capitolina sono i colori, i costumi di scena realizzati collaborando con i Balletti Russi di Diaghilev e la gioia di vivere che accompagnerà Matisse nell’arco di tutta la vita, in una sorta di musicalità formale e cromatica che supererà linee e forme. Eppure gli arabeschi non sovrasteranno mai le opere perché, come egli spiegherà, «fanno parte della mia orchestrazione del quadro».
Articoli correlati:
Ninfe, bagnanti e odalische