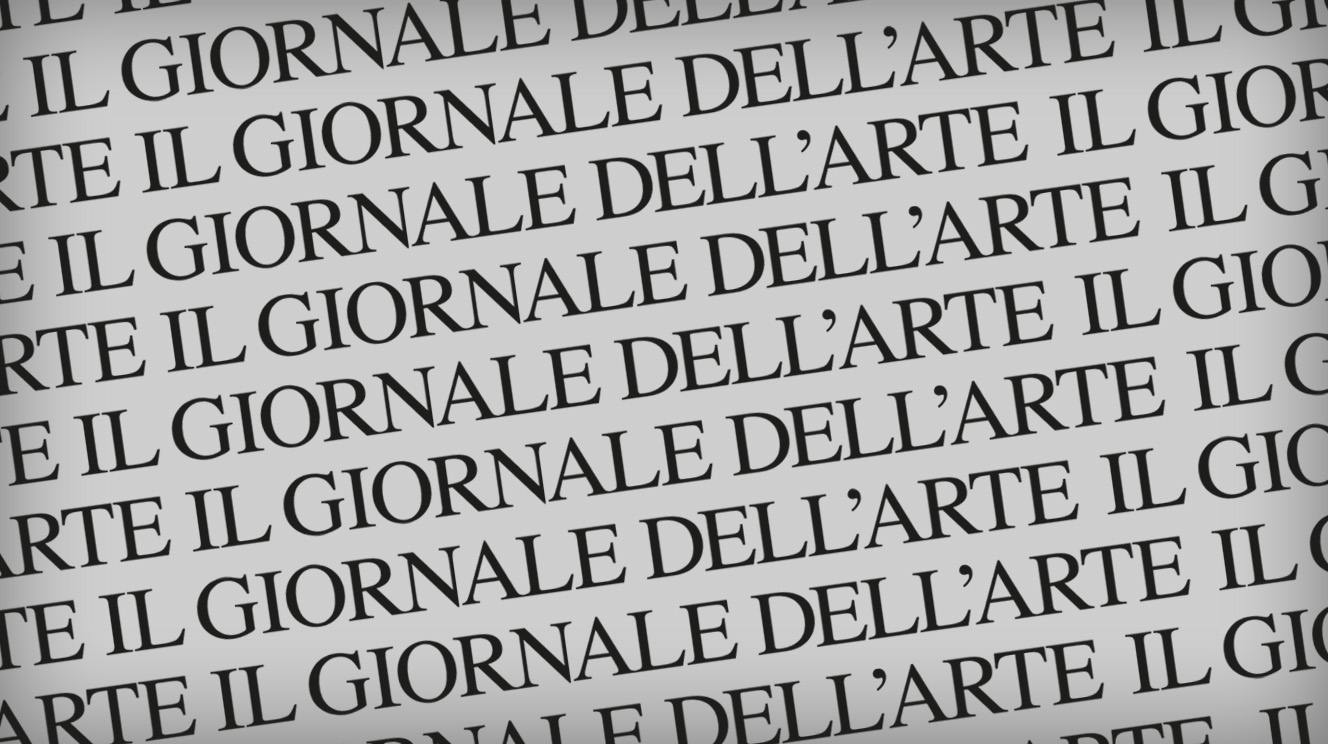Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Redazione GDA
Leggi i suoi articoliEsaurita la distribuzione tra soci, clienti, amici degli sponsor maggiori dell’iniziativa editoriale, e concluso il ciclo delle conferenze presso il Museo Civico di Vicenza che l’hanno assecondata, l’attesa monografia su Bartolomeo Montagna finalmente appare sugli scaffali delle librerie. Il monumentale volume risulta articolato in una Premessa nella quale Maria Elisa Avagnina traccia il profilo della fortuna storiografica e critica del pittore, alla cui vicenda artistica Mauro Lucco dedica il capitolo portante del volume, che si completa con un’appendice di Documenti curata da Manuela Barausse e col Catalogo delle opere (suddiviso tra le certe, le perdute, le spunte) steso in gran parte sempre da Lucco, con qualche scheda concessa al fedele leporello Giovanni Carlo Federico Villa, e cui fan seguito la Bibliografia e gli Indici. Orbene, spiace di dover dichiarare subito che l’esito, a dispetto della imponente e quasi ingombrante sontuosità della sua veste grafica, delude ogni fiduciosa aspettativa, come (risparmiandoci la sin troppo facile evocazione, nel soprannome del pittore, della metafora del topolino e la montagna) cercheremo di provar brevemente, indugiando sugli aspetti preponderanti e, per dir così, connotanti del capitolo monografico di Lucco, la cui principale preoccupazione sembra esser quella di far a pezzi, con un livore malamente alleggerito talora da frizzi di non nobile lega, tassello per tassello, la costruzione della personalità di Bartolomeo che chi qui scrive aveva proposto più di cinquant’anni fa con un libro il quale, insieme a qualche ulteriore suo contributo a latere, aveva costituito sino ad oggi un punto inalienabile di riferimento, né i chiari di luna accesi da Lucco sembrano metterlo del tutto in ombra.
A lui, dunque, che, per darmi il colpo di grazia, esalta le qualità superiori della precedente (1909) monografia montagnesca falsificando, con una citazione parziale, il mio giudizio sul suo autore Tancredi Borenius (p. 25, n. 15), mi guarderò bene dall’elargire giustificazioni e piagnistei e dal recitare la geremiade (che pur include un’ovvietà) onde la realtà delle conoscenze da cui potevamo muovere alcune decine di anni fa non era quella su cui possiam contare oggi: e mi contenterò qui di constatare che, ciò nonostante, dei centotré autografi montagneschi ammessi dal Nostro, ottantacinque eran già stati riconosciuti or è mezzo secolo fa dal sottoscritto, che ne inanellava un’altra dozzina nel corso degli anni immediatamente successivi, e provvedeva a stendere pure un catalogo dei disegni (ventisei numeri), assente nella monografia del Lucco che si limita a citarne qualcuno all’interno del repertorio delle schede, e rinunzia a ragionare la dialettica di pittura e grafica in Montagna (così come si guarda bene dal tentare una restituzione concreta della bottega di Bartolomeo e il suo funzionamento anche per coglierne la gestione tutt’altro che insignificante al di là della morte del Maestro, del figlio Benedetto).
In realtà, se ai traguardi attinti in quella lontana congiuntura riconosco un limite grave, questo non risiede nelle bagatelle di connoisseurship filatelica con cui ama trastullarsi il mio contestatore pescando, a copertura, una citazione decontestualizzata (p. 32, n. 39) di Lucien Lefebvre, di cui dovrebbe studiare davvero la lezione per un’«altra storia», capace di «scoprire correlazioni» e di «stringere accordi e scambi tra discipline vicine tra loro». Mancava alla costruzione di quella mia vecchia proposta monografica, così come a lui continuano a mancare ancor oggi, la consapevolezza dei contesti e la convinzione, che Lefebvre aveva raccolto da Marc Bloch, che la storia è anzitutto, «scienza sociale». È vano, allora, tentar di spiegare l’approdo e l’affermazione dell’oriundo bresciano Bartolomeo Cincani tra i Berici e il sistema di rapporti che stabilirà con Venezia, Padova, Verona, Bassano, se non si tiene conto del legame allacciato tra gli esponenti della sua famiglia, e da lui stesso poi, con i rappresentanti dei casati più prestigiosi dell’aristocrazia vicentina, al tempo stesso protagonisti di una civile conversazione umanistica di raggio vasto, in un momento storico che veniva mettendo a frutto le condizioni privilegiate della dedizione della città a Venezia (1406) la quale ad essa riconosceva le sue «antiche prerogative, immunità, esenzioni, concessioni, consuetudini, leggi, statuti e giurisdizioni».
Ora, se ciò sanzionava un rapporto di fedeltà e obbedienza alla Dominante da parte di una primogenita «Vicenza beata», «perfeta, discreta e richa», «civitas», quasi sorta di città-stato che poteva, senza obiezioni, autodefinirsi «respublica», elaborando, con la leggenda delle apparizioni della Vergine a Monte Berico (1426-’28-’34), un suo mito di superiore rifondazione che la poneva sotto la protezione della Madre di Dio, neppur poteva prescindere da una sfida che a Venezia opponesse una supremazia culturale visibile e tangibile nella pulcritudine della sua immagine urbana. All’indomani della pace di Lodi (1454), che poneva fine, tra l’altro, alla politica, minacciosa per i suoi umoreschi voltafaccia, di Gian Galeazzo Visconti, con la mediazione di Lorenzo Giustiniani, primo patriarca di Venezia, il cantiere che ne avrebbe messo in opera il programma, poteva venir inaugurato, e lo accenderanno, proprio al virar della metà del secolo, la prodigiosa voltatura, da parte di un genio innominato, del palazzo della Ragione e il rinnovamento della Cattedrale. E quanto ne scaturirà è cosa quale «mai fo vista innanzi», «fra le belle bella/e infra le ricche ricca», «tempii, palazzi, piazze, case e torre», «novella Terra Santa»: è il gentiluomo di Fano Giambattista Dragonzino a ricordarlo «nel 1525 di ottobre» dipanando il rosario delle ottave che ci consegnano un poemetto tutto dedicato a esaltare la «nobilità di Vicenza» come si presentava all’indomani della chiusura del cantiere che l’ambizioso programma aveva impalcato, e della morte di un suo protagonista, Bartolomeo Montagna. E quale fosse stato l’afflusso di maestranze specializzate nell’universo dell’edilizia e delle arti figurative, lo documentano le indagini archivistiche di Zorzi, di Mantese, più recentemente, di Zaupa, ignorate quasi tutte da Lucco, malgrado abbiano prodotto una valanga di documenti che ancora attendono, pertanto, di essere compiutamente ordinati in rapporto alla concreta produzione di opere, le quali, a eccezione di quelle riconducibili ai pochi soliti noti, attendono un’esaustiva classificazione e schedatura. Farò qui i nomi di Angelo di Giovanni da Verona (particolarmente maltrattato dal Nostro), di Tomaso e di Bernardino da Lugano, di Pietro Lombardo, di Pierantonio degli Abati, di Lorenzo da Bologna, tutti, o dimenticati o appena sfiorati da Lucco, vuol solo rilevare come Vicenza diventi un incrocio di esperienze, non solo della Padova rinnovata dai toscani, e da Mantegna, ma veneziane, lombarde, emiliane, centroitaliane: un laboratorio di linguaggi, laddove, nell’ambito della produzione pittorica, anche alla luce di quel che accadeva nella Venezia contemporanea, splenderà l’astro di un genio di anagrafica origine lombarda, Bartolomeo Montagna appunto.
E resta punto fermo che, nell’addobbo delle chiese, sovrattutto degli ordini riformati (con san Bartolomeo che assume la rilevanza di un Pantheon durante gli ultimi tre decenni del Quattrocento), la collaborazione dell’atelier di Tommaso da Lugano e di Maestro Bernardino con l’officina pittorica di quel Maestro, le cui dimensioni e frequentazioni restan tuttora da definire, in vista di apparati decorativi che andranno a estendersi agli impianti trionfali dei portali delle residenze gentilizie rinnovate, impalca gli umori di Classicismo romantico di cui la nobiltà cittadina vien nutrendosi, e coniuga con le aspirazioni a una religiosità severa, e purificata dalla consapevolezza o dalla partecipazione a un autentico slancio riformistico. E predispone, così, le condizioni storiche in cui si genererà un secondo Rinascimento, impersonato da Palladio. Ovviamente, tutto ciò allo sguardo di Lucco resta invisibile, e insignificanti gli passan sotto il naso le figure eminenti consegnate dall’eccellente regesto della Barausse (oltre che di letterati, poeti, scienziati, e di artisti che non sian pittori) di committenti che magari s’applicavano anche a quelle stesse humanitates ed è stupefacente che nulla gli dicano le figure per non dir d’altre, di un Giambattista Gualdo, che sarà vicino al Montagna nel momento in cui il pittore si congedava da questo mondo, ma lo aveva voluto a decorare il suo palazzo di Pusterla, che pochi anni dopo sarà teatro di una mirabolante invenzione di Bartolomeo Ammannati, e di Gaspare Trissino, cliente del Giambellino ma puranche suo committente, e padre di Giangiorgio, inventore di quel Palladio che si gioverà di Benedetto e della sua bottega montagnesca per l’allestimento trionfale del cardinal Ridolfi nel 1543 a Vicenza: la città ancor si illudeva di poter ospitare il Concilio ecumenico che, invece, sarà inaugurato a Trento.
Bartolomeo Cincani detto Montagna. Dipinti, di Mauro Lucco e Maria Elisa Avagnina, Manuela Barausse, Giovanni C.F. Villa, 472 pp., 400 ill., ZeL edizioni, Treviso 2014, € 65,00
Altri articoli dell'autore
L’Associazione archeologi del Pubblico Impiego (Api-MiBact) ha inviato una nota al Ministero della Cultura e a quello della Funzione Pubblica, nonché ai membri delle Commissioni cultura di Camera e Senato, per esprimere il proprio dissenso per il bando per 75 posti nell’area dell’elevate professionalità (Ep), le cui domande di partecipazione vanno presentate entro il 26 giugno
Il premio Nobel e il direttore del Museo Egizio si sono incontrati per parlare di musei e romanzi: «Sono simili: sono i “luoghi” in cui avviene l’interpretazione del significato della nostra vita, nei quali riflettere su sé stessi»
Anche quest’anno Tag Art Night, la Notte delle Arti Contemporanee, propone un palinsesto di mostre diffuse sul territorio cittadino
Rimodulate le competenze e modificato la struttura organizzativa: dal Segretariato generale al modello dipartimentale