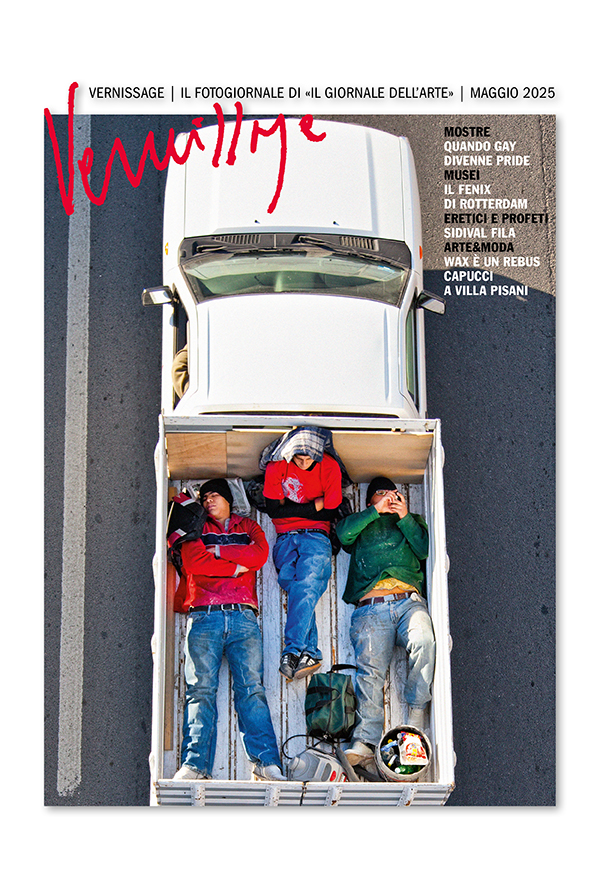Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Matteo Bergamini
Leggi i suoi articoliMentre al Mah (Musée d’Art et d’Histoire) si inaugura la quinta carte blanche, stavolta affidata all’artista Carol Bove (1971), al Cac (Centre d’Art Contemporain) diretto da Andrea Bellini, si appresta alla chiusura la prima personale in Europa dell’artista brasiliano Antonio Obá (1983). E se da un lato siamo trascinati in una atmosfera rarefatta e concettuale, una vera e propria investigazione dello status del museo, dell’opera d’arte e dei relativi codici, dall’altro c’è la visceralità di una pittura che scava nella biografia di un Paese, universalizzandola attraverso immagini di potentissima poesia.
Carol Bove e Antonio Obá, gli antipodi: nata a Ginevra, Bove è cresciuta a Berkeley, California, e vive a New York (dove ha studiato alla Ny University); da Ceilândia, città-satellite di Brasília, arriva invece Obá, che nel Distrito Federal continua a vivere e lavorare. Eppure queste due mostre distanti anni luce, «La Genevoise» di Bove (fino al 22 giugno) e «Rituals of care» di Obá (fino al 16 febbraio), riescono a comunicare tra loro attraverso il potere immaginifico di una produzione che esula dalla semplice messa in scena di «opere», scavando invece profondamente nella storia della cultura, utilizzando linguaggi diametralmente distanti che, potremmo azzardare, si incontrano sul sottile piano del sincretismo, l’unione di qualità e caratteristiche disgiunte per creare una nuova possibilità di esistenza.
Carol Bove offre un percorso visionario rispetto al corpo del museo, unendo ermeticamente bianco e nero; tra le sale del Mah, l’artista crea una interzona dove l’idea illuministica di «esposizione» si mescola al concetto di «percezione» relativo ad alcuni selezionatissimi oggetti, che Bove ha identificato in base alla loro identità «tattile»: vasellame, coltelli, punte di lance preistoriche, ma anche panche e monete, ricreate in scala 1:1 attraverso la stampa 3D, costringendoci a ripensare alla vita dell’artefatto in una sua decontestualizzazione alla potenza e, contemporaneamente, più vicino alla conoscenza umana per il suo essere «toccabile».
La storia dei corpi, degli oggetti e delle azioni di Antonio Obá, è invece un terreno per sua natura appartenente al sincretismo religioso, vivo di esperienza e di memoria, di quell’eredità rimasta dall’antica diaspora africana forzata verso il Brasile in epoca schiavista, che si ripercuote ancora oggi in un Paese che vive navigando in due direzioni opposte, quella di una profonda modernità e globalizzazione, e quella di una ancestralità impossibile da cancellare e, fortunatamente, profondamente condivisa.
Ecco che, a ben guardare, le vicende del raccogliere e catalogare l’arte, il poter afferrare un resto di vita passata, corroborare il fantasma del tempo per intendere il presente, si situa parallelo ai rituali di matrice africana che permeano la cultura brasiliana nella continua risignificazione di oggetti, simboli, animali: quel che accade dentro le mura di un museo, in fin dei conti, è la medesima magia che appartiene ai terreiros, entrambi i luoghi «portali» per conoscere l’ingombrante e sacra eredità del mondo.
Così, mentre «La Genevoise» è una esposizione immateriale, dove è dato immenso spazio al vuoto e alle ombre, come rimarca il direttore del Mah, Marc-Olivier Walher, «Rituals of care» invade di colore, e le ombre della storia restano incollate ai corpi ritratti da Obá, nei dettagli del fumo di sigarette o negli occhi degli «Incantati» che sbucano tra le fronde degli alberi, in scene che tutto hanno a che fare con l’universo rituale, con la luce e la bellezza di scene al limite del surreale.
In fondo, che cosa è la «realtà»? E come si potrebbe definire un museo se non un insieme di linguaggi evanescenti, come rimarca Bove? Gli oggetti/non oggetti neri dell’artista svizzera-statunitense, facsimili defunzionalizzati tanto quanto gli intoccabili originali, sono incidenti semiotici che mantengono una identità fantasmatica, dove la durezza del display industriale (una guida metallica nera che si sussegue in ogni sala e a sua volta è base per le repliche o semplice «inciampo») e le pedane bianche lasciate alternativamente piene e vuote, disegnano uno spazio eccentrico e duale, di riflessione assoluta rispetto alle possibilità del «vedere», all’idea di «conoscenza».
E poi c’è la questione del non-finito che Bove rimarca come una possibilità di perpetrare il tempo dell’opera: mentre un quadro «concluso» resta immobile e, chissà, muore, la vita dell’incompiuto continua in potenza, proprio come questo allestimento al limite dell’onirico mantiene aperti i cammini della percezione. E «abrir caminhos», in Brasile, è una condizione del destino: significa creare le possibilità affinché qualcosa accada o permettere che un desiderio, un obiettivo, venga raggiunto, superando le difficoltà: Obá e Bove, dai rispettivi orizzonti, permettono una eccentrica entrata in altre prospettive della visione, fisica e mentale.

Una veduta della mostra di Carol Bove, «La Genevoise», 2025. © Musée d’Art et d’Histoire de Genève, foto: S. Altenburger