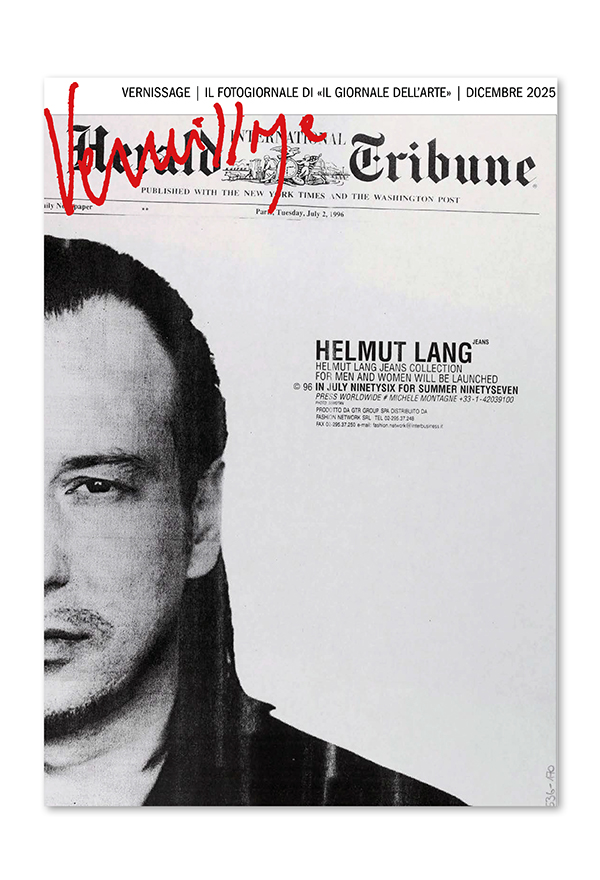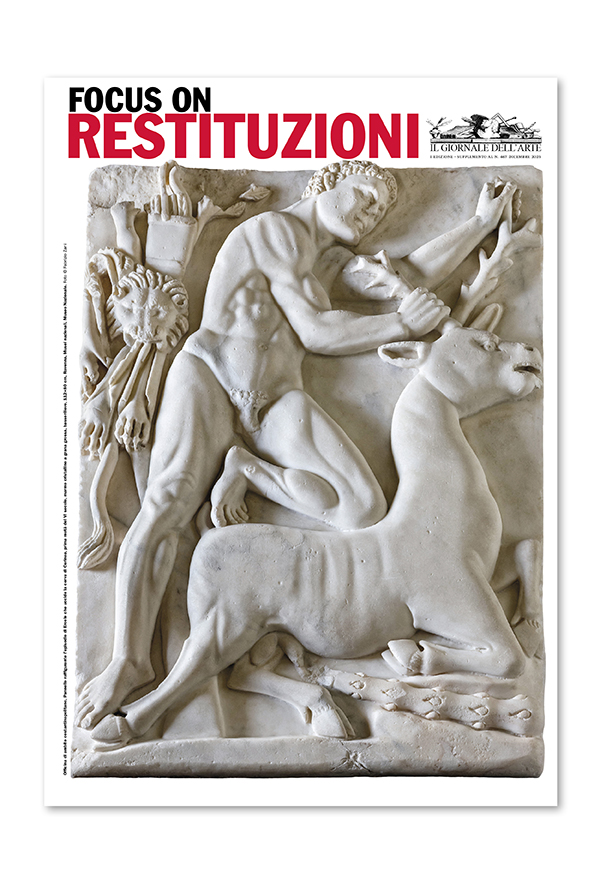Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Stefano Causa e Arabella Cifani
Leggi i suoi articoliSe guardando un film vi vengono le vertigini. E magari non si è neanche bevuto troppo a Natale
In questi giorni di Natale riguardatelo. Uno dei film più perfetti mai girati, magari vi appassionerà così tanto che vi farà evitare di tornare a piluccare a tavola il panettone avanzato o di assortirvi in conversazioni insopportabili con parenti che vorreste mandare al diavolo.
La donna che siede pensosa davanti a un ritratto femminile nel museo di San Francisco (il Legion of Honor) costituisce certamente una delle scene più intriganti della storia del cinema. La giovane, che sembra uscita da un quadro di Hopper ma che denota nel portamento e nello stile la sua appartenenza all’upper class americana, veste un impeccabile tailleur grigio, con scarpe nere dal tacco molto alto. I suoi capelli biondi sono acconciati in un «French twist» che in realtà è una vera e propria scultura astratta con quel nodo che si modella come se Brancusi lo avesse scolpito su idea di Man Ray e che comunque, a guardarlo, fa venire le vertigini.
E il film è infatti «Vertigo», del 1958, uno dei capolavori di Alfred Hitchcock (in italiano fu banalmente tradotto con «La donna che visse due volte»). Hitchcock trasse la trama da un romanzo francese del 1954 D’entre les morts di Pierre Boileau e Thomas Narcejac, ma poi fece a modo suo, e della storia originale mantenne solo l’ossatura.
La contemplazione assorta da parte di Madeleine (la protagonista) di un quadro (improbabile sul piano stilistico, piuttosto maldipinto, forse l’unico difetto di questo film straordinario) che fu inventato apposta per il film e che raffigura il ritratto di Carlotta Valdes si carica di valenze molto profonde legate a temi di morte e di dolore. Carlotta impazzita si uccise a soli 26 anni e Madeleine s’identifica in essa e sembra intenzionata a seguirla nel suo destino. In realtà sta fingendo per trascinare nel suo inganno il povero Scottie, il protagonista maschile e il vortice degli inganni e delle menzogne dà il capogiro.
Quando questi si avvicina alla donna, senza farsi vedere, e la contempla mentre lei guarda il ritratto (che le somiglia moltissimo) si verifica un gioco incrociato di sguardi e di riferimenti: noi guardiamo loro, lui guarda la donna, la donna guarda il quadro. Il mazzo di fiori che Madeleine appoggia su una panca è uguale a quello del ritratto e anche la collana, che avrà un ruolo fatale alla fine del film, è la stessa. Del museo di San Francisco, Hitchcock coglie l’algida raffinatezza di una costruzione e di una sistemazione delle collezioni che era nel 1958 relativamente moderna (il museo fu aperto nel 1924).
Chi ha visitato questi musei americani nati a partire dagli anni Venti del Novecento sulla base di donazioni di miliardari che avevano fatto fortuna commerciando le cose più strane, ne conosce l’atmosfera che punta a ricostruire parti di Europa negli Stati Uniti e a esportare nelle nuove terre americane le raffinatezze del vecchio continente (almeno questa era l’idea). Nel caso di San Francisco addirittura gli architetti s’ispirarono a una costruzione parigina del XVIII secolo (il Palais de la Légion d’Honneur), ed erano quindi parecchio in ritardo culturale.
«Vertigo» è forse il film più ricco di riferimenti artistici e culturali di Hitchcock, che di arte se ne intendeva davvero. L’ambientazione a San Francisco è inusuale e i punti di vista sulla città sono quelli del suo passato coloniale, della California spagnola delle fondazioni francescane (la scena della morte di Madeleine/Judy è ambientata nella Missione settecentesca di San Juan Bautista). Il Golden Gate Bridge che appare in molte inquadrature è invece una visione onirica che pare uscita da una stampa di Hokusai o Hiroshige, mentre la scricchiolante casa dove avrebbe vissuto Carlotta Valdes con la sua architettura vittoriana genera inquietudine ed evoca le case maledette di Edgar Allan Poe.
Hitchcock supera sé stesso anche nella scena in cui il protagonista insegue la misteriosa donna che gli ha preso il cuore in un antico cimitero californiano. Il suo avvicinarsi alla tomba della sfortunata Carlotta Valdes, figura chiave (di invenzione) del film vissuta nella San Francisco del primo Ottocento, fa pensare all’«Ingresso al cimitero» di Caspar David Friedrich o a certe visioni funerarie di Böcklin, la tensione della scena si scarica poi nella vertigine della fossa.
La storia, è noto, è quella di un inganno mortale che porterà la protagonista che si divide fra l’essere la sfrontata Judy e la misteriosa e algida Madeleine a una fine tragica.
Tappezzerie opulente che sembrano uscite da quadri di Matisse fanno da sfondo alla bellezza perturbante e bianca di Kim Novak; spirali da vertigine sbucano in molte scene come un Leitmotiv, fino a quella della pazzia di Scottie che diventa un’animazione degna delle avanguardie tedesche («An Optical Poem» di Oskar Fischinger, del 1938, per esempio), mentre l’uso stesso del colore come fatto emotivo (a tratti tutto diventa verde, o blu, rosso o nero) fa pensare alla poesia di Arthur Rimbaud che definisce le lettere dell’alfabeto come colori: «A nera, E bianca, I rossa, U verde, O blu», con un processo di associazione libera delle paure, delle ansie, dello struggimento amoroso che attraversa anche il regista e che ci appare perfettamente comprensibile. I personaggi, entrambi disturbati mentalmente, ruotano dunque vorticosamente nelle loro spirali, tra la vita e la morte, conoscendosi, riconoscendosi, per ritrovarsi e infine perdersi.
[Arabella Cifani]
Se godi guardando un film vuol dire che sei sulla cattiva strada. Soprattutto se guardi un film di mare a Natale
Insieme ai film natalizi, alle interviste agli anziani soli e agli sbarchi a Lampedusa, ogni tanto ripassa in tv lo «Squalo» di Steven Spielberg inarrivabile prototipo di mille pescecani che, a suo tempo, infestarono le sale cinematografiche risparmiando, pare, oceani e mari nostri. Di solito l’esemplare numero uno (quello del 1975) titolo originale, per sineddoche: «Mascelle» («Jaws»), riemerge sulle reti commerciali affinché, chi non lo abbia già visto almeno cinquanta volte, lo rincontri crivellato da spot che compaiono nei momenti topici dentro un film scandito, però, solo da momenti topici (è la pubblicità che uccide lo squalo non la bombola ingoiata). E di nuovo ci si convince di due cose: del genio di Spielberg, all’epoca neanche trentenne e della nostra incoercibile, infrangibile stupidità.
Quando l’animale cominciò a mangiare cristiani, al centro esatto degli anni Settanta, incastonato tra la «Rabbia giovane» di Terence Malick (1973) e «Taxi Driver» di Martin Scorsese (1976), tornammo con la sensazione di aver incocciato in un gran film di serie B, un apice di seconda lista (in prima c’erano quelli dove la noia fosse garanzia di rigore). Negli anni della cultura come cilicio, l’intrattenimento era guardato con sospetto. Si poteva fucilare qualcuno per meno. E del resto, a scanso di equivoci, così fu venduto il film che, sulle locandine, veniva definito: «il film più terrificante». Come a dire: se non ingabbi lo squalo, puoi classificare e insterilire dentro un genere almeno il film. Che, naturalmente, è tutto tranne che un horror.
Ma erano gli anni in cui se andavi al cinema era solo d’essai (Bergman e Woody Allen i parametri sempiterni). Sempre col dito alzato molti, anche dei meno sprovveduti, tacciavano di fascismo Mogol e Battisti, lasciando fuori dalle storie della musica moderna Morricone o Trovajoli (oppure condannavano come kitsch il romanzo di Tomasi di Lampedusa, uno degli ultimi ben scritti del nostro Novecento). L’imperativo era educare ed educarsi. Se godevi vuol dire che stavi sulla cattiva strada. Sperimentale e popolare in ogni inquadratura, il buon Hitchcock aveva insegnato ai registi e niente ai critici. Ovviamente lo squalo morse tutti: il pubblico e i critici stessi (gli stessi che mai avrebbero confessato di canticchiare Il mio canto libero di Battisti).
E intanto, mentre non avremmo più superato la paura di fare il bagno al largo (alto mare rimase metafora di situazione provvisoriamente irrisolvibile), lui saliva a galla come il film cruciale di fine secolo. Con Spielberg l’arte americana con caratteri propri (il jazz e, appunto, il cinema) portò sulle spalle, pressoché da sola, l’onere di ricucire i rapporti con il pubblico che ancora non si chiamava generalista; quel contratto tra artista e chi paga che era stato stracciato con la crisi dei linguaggi figurativi tradizionali. Spielberg si è andato a riprendere gli spettatori ad uno ad uno.
Lo squalo è una macchina perfetta dove vengono ripresi e ripotenziati tutti i cliché della cultura occidentale antica e moderna. La natura matrigna, gli eroismi e le pavidità, la massa contro l’estro del singolo, il guscio della famiglia e la comunità, i fantasmi del Vietnam, l’avidità e il senso della morte. Corale nella prima, paurosamente asciutto nella seconda, la struttura è di un western anomalo. Nel primo tempo chi guarda è calato dentro situazioni tipiche ma non tipizzate, banali ma non banalizzate. Nessuno prima (se non il Norman Rockwell delle copertine del «Saturday Evening Post», stabili nell’agenda culturale e sentimentale di Spielberg) era riuscito a raccontare l’America con eguale naturalezza scansando come scorciatoie accomodanti ogni virtuosismo di stile. Sono, le sue, stanze di vita quotidiana come, un secolo prima, erano state quelle dei capitoli di avviamento di Anna Karenina di Tolstoj.
Quando il film entra nella fase seconda, introdotta dalla scena delle nature morte delle dentature esposte come trofei nel museo personale di Quint, la barca che si allontana inquadrata dalle mascelle dello squalo è un omaggio al finale di «Sentieri Selvaggi» con John Wayne che si allontana nel vano della porta. Per chi la sappia cogliere la strizzatina d’occhio vale come una citazione di classe. Il massimo della spettacolarità confezionato nel massimo dell’audacia formale. Quella cornice dentata apre il finale del film, ultimo saggio di epica moderna.
Le scene di massa della porzione iniziale (il lato A del vinile) si contraggono nel gioco a tre del rovescio del disco (squalo escluso, il capo della polizia Brody, il cacciatore Quint e il biologo Hooper); un teatrino che va in scena su pochi metri di barca vieppiù scassata dove tutto è misurato: gesti, sguardi e silenzi interrotti solo dalla musica onomatopeica di John Williams tutte le volte che si avvicini la bestia. A tre quarti del film compare una cadenza che, come nei concerti settecenteschi per piano e orchestra, è a discrezione di esecutore e attore (il racconto del sommergibile «Indianapolis» che porta la bomba, uno dei punti alti del cinema americano tutto, è sostanzialmente improvvisato). Infine, come da contratto, Spielberg ricrea l’Achab di Moby Dick nella figura di Quint (è lui e non lo squalo il vero protagonista del film). All’epoca qualcuno disse: da noi Luchino Visconti fa la gara con la pittura, arreda, fa il sarto di lusso, l’Orazio Gentileschi della macchina da presa. Spielberg, finalmente, no.
Ma non è vero. Si tratta di capire con che museo si confrontassero l’uno e l’altro. Da storico d’arte, Visconti attraversa il nostro Ottocento, lo stupido secolo italiano secondo Roberto Longhi. Nell’anno di morte di Pasolini, Spielberg si confronta con i maestri della Pop. Lo squalo è un’icona come Elvis o Marilyn Monroe. Tutto il film trabocca di dettagli pop: dalla locandina (negativa rovesciata dell’olio abbronzante «Coppertone») a finire con la targa divelta che, ubriaco, il biologo Matt Hooper estrae dallo stomaco dello squalo. Ma Spielberg scansa l’ironia seriale di Peter Phillips o Joanna Ballantyne. Lungo la chiostra mascellare di un grande squalo bianco si celebra l’epicedio di «American Graffiti» e di «Happy Days». Il pollice di Fonzie salterebbe al primo morso.
Qui tutto è ferocemente scabro, privo di ogni accentuazione caricata. Anche il mare, privato di ogni alone di sublime romantico, è una trappola mortale. Nei quadri di Friedrich i personaggi lo contemplano dandoci le spalle. Qui, dalla spiaggia o dalla barca, tutti lo scrutano in attesa del Male assoluto. Contemplare e scrutare sono operazioni che mettono in moto attitudini e sentimenti diversi. Nel passaggio dall’una all’altra si consuma lo svuotamento di quel mito della frontiera dentro cui la cultura americana di Whitman o dei pittori dell’Hudson River School aveva raccolto e rilanciato il Romanticismo europeo. Il mare è fondale ostile. Impossibile surfarci come in «Un mercoledì da leoni» di John Milius (1978). Meglio stare alla larga e non al largo. Certo dopo Spielberg, farsi una bella nuotata sarebbe diventato più difficile. Ma già da un decennio i tuffi migliori si facevano nelle piscine di David Hockney. California dreaming.
[Stefano Causa]

Steven Spielberg dietro le quinte di «Jaws» (1975)
Altri articoli dell'autore
Divagazioni ferragostane longhiane di Stefano Causa e Arabella Cifani
Viaggi inconsueti dentro, sotto e di lato alla storia dell’arte attraverso le «robes de chambre», intrapresi da Arabella Cifani e Stefano Causa
I rapporti tra la copertina di «Oro, incenso & birra» del cantautore reggiano e l’arte antica felsinea, visti da Stefano Causa e Arabella Cifani
Nuovi nessi tra antico, contemporaneo e cultura popolare scovati in libri, dischi e film e raccontati da Stefano (Causa) e Arabella (Cifani)