
Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Bartolomeo Pietromarchi
Leggi i suoi articoliDai modi gentili e pacati, Thomas Ruff (Zell, Germania, 1958) è l’immagine stessa della discrezione. Come lui stesso ammette, la sua riservatezza nasce da una profonda timidezza. Eppure, dietro questo temperamento quieto, si nasconde uno dei protagonisti più coerenti e longevi della fotografia d’arte contemporanea. All’avvicinarsi dei settant’anni, Ruff rappresenta un monumento alla persistenza dell’immagine fotografica nella sua forma più essenziale: un laboratorio in continua evoluzione di tecniche, strumenti e linguaggi che appartengono alla storia del medium e che oggi appaiono quasi artigianali, come incisione o cesellatura. Nella sua pratica, la fotografia non è mai semplice rappresentazione: è un terreno di indagine, una superficie critica in cui il visibile incontra la riflessione teorica sullo sguardo. Con un equilibrio raro tra disciplina e poesia, Ruff ci ricorda che l’immagine (pur mutando supporti, processi e velocità) resta una materia di luce, capace di riflettere come poche la complessità del nostro modo di percepire il reale e oltre.
Formatosi negli anni ’70 alla Scuola di Düsseldorf, sotto la guida di Bernd Becher, Ruff appartiene alla generazione che ha ereditato il metodo analitico e l’ascetismo visivo dei maestri, discendenti diretti della Neue Sachlichkeit (Nuova Oggettività) degli anni ’20. I Becher sono noti per il loro linguaggio neutro e sistematico, applicato agli archetipi industriali (torri d’acqua, impianti minerari, silos di carbone...) che hanno definito un paradigma di osservazione e di rigore. Ruff, insieme ad Andreas Gursky, Candida Höfer, Axel Hütte e Thomas Struth, ne ha reinterpretato l’eredità introducendo nuove possibilità tecniche e una sensibilità pienamente contemporanea, senza mai tradire il principio documentario che fondava la loro ricerca. Lo incontriamo a Milano, in occasione della sua personale alla Galleria Lia Rumma (fino al 10 gennaio 2026).
Il suo lavoro è profondamente legato alla natura stessa dell’immagine, così come altri artisti lo sono alla materia. Fin dalla fine degli anni ’80 era chiaro che il suo percorso non era «fotografico» in senso stretto. Ricordo che in quegli anni Germano Celant coniò il termine Inespressionismo, in reazione alla Transavanguardia. La sua generazione sembrava riconoscersi in quella prospettiva analitica e antiromantica: rinunciare all’originalità come mito per affermarsi nel simulacro, nella copia della copia, all’interno della logica della ripetizione mediatica. La pratica artistica diventava un processo controllato, tecnico, fondato su calcolo, precisione e coscienza dell’artificio più che su spontaneità o intuizione.
In un certo senso sì. Abbiamo iniziato alla fine degli anni ’70. All’accademia i nostri eroi erano i minimalisti e i concettuali, ma nel mondo dell’arte dominava la pittura espressionista, in Germania, in Italia, negli Stati Uniti... Quando abbiamo cominciato non c’era alcun interesse per il nostro lavoro. Abbiamo semplicemente continuato. Poi, quando l’interesse per la pittura espressionista è calato, l’attenzione si è spostata su scultori come Thomas Schütte o Juan Muñoz, già più oggettivi, più «inespressivi». Dopo gli scultori è arrivata la fotografia, qualcosa di ancora più distaccato. All’epoca lavoravamo in piccolo formato e nessuno si stupiva. Tutto cambiò con il primo ritratto che feci in grande formato, nel 1986 da Philip Nelson: la scala e la precisione offrivano qualcosa che nessun altro medium poteva dare. Anche i collezionisti più refrattari alla fotografia non potevano ignorarlo. Era davvero nuovo.

Thomas Ruff, «press++32.51», 2016. Courtesy dell’artista e Galleria Lia Rumma Milano/Napoli
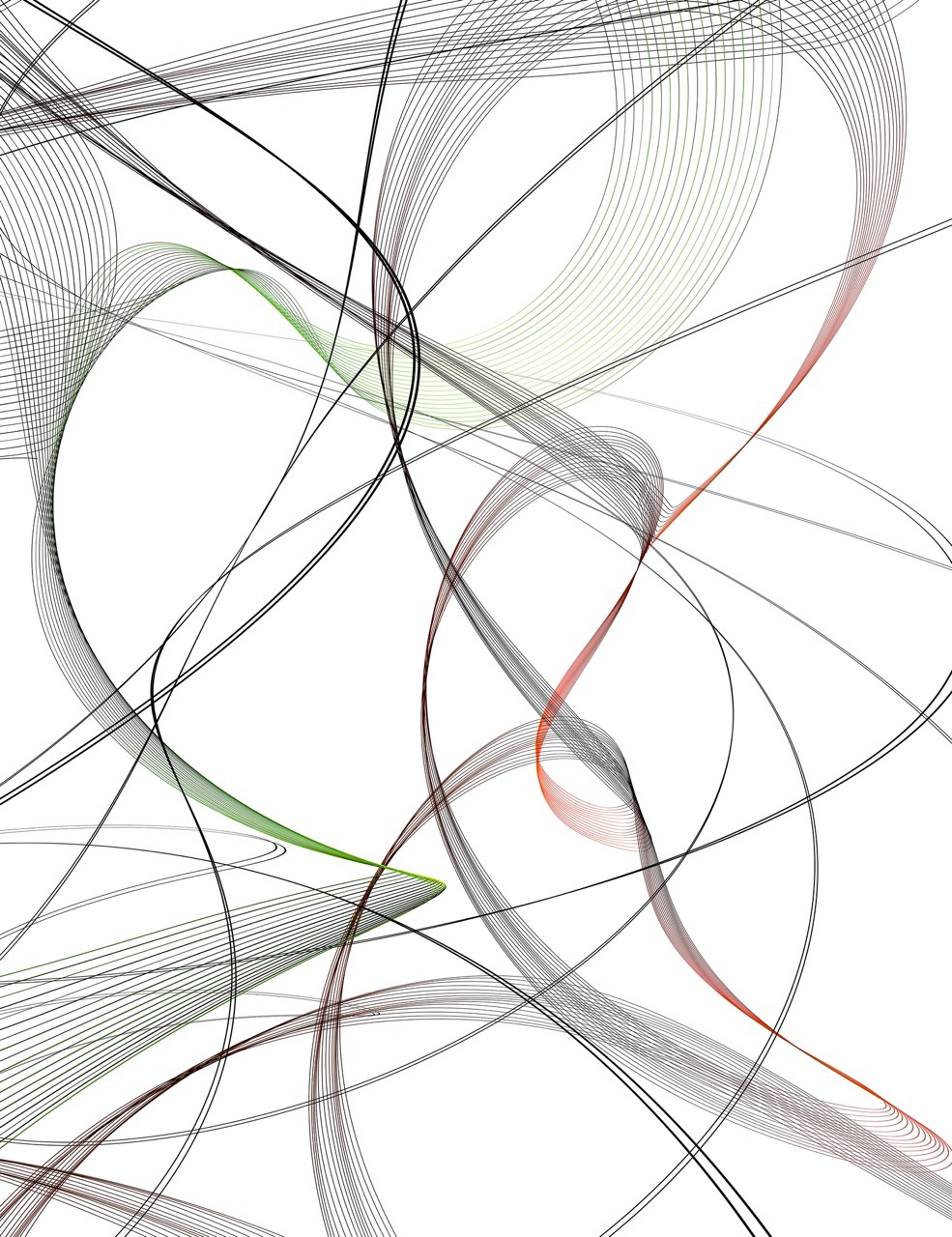
Thomas Ruff, «zycles 3085», 2009. Courtesy dell’artista e Galleria Lia Rumma Milano/Napoli
Le opere più recenti, «Expérience Lumineuse» e gli «Untitled» presentati in mostra, sembrano proporre una resistenza attiva alla produzione e alla circolazione compulsiva dell’immagine contemporanea. Una sorta di «ecologia dello sguardo», un ritorno a una pratica lenta e alla fisicità del processo. Non a caso il titolo francese sottolinea il primato dell’esperienza: l’enfasi è sullo studio, sulla luce, sul contatto diretto con la materia visiva.
Questi lavori sono un viaggio a ritroso nel tempo, dentro tecniche scomparse che continuo a esplorare con curiosità. Con «Expérience Lumineuse» volevo tornare al punto zero della fotografia. Che cos’è la fotografia? Luce. Vetro. Se lasci passare la luce attraverso il vetro ottieni rifrazione; con un piccolo specchio ottieni riflessione. Tutto parte da lì. Ho un’affinità profonda con astronomia, fisica e scienza, quindi non è un caso se ho scelto un esperimento di luce così semplice. L’idea era tornare alle basi dell’atto fotografico.
In un’epoca in cui non siamo più certi di vedere ciò che crediamo di vedere, questa scelta sembra un’affermazione di principio sul rapporto tra vero e falso.
Il vero e il falso sono sempre stati parte della fotografia, fin dall’inizio. Il medium è stato usato in modi diversi: c’è chi sfrutta la verità fotografica e chi, al contrario, il suo potenziale inganno, per convincere le persone a credere a ciò che vedono, e dunque a ciò che pensano. Nel mio caso uso la bellezza come forma di seduzione: immagini molto attraenti che, tuttavia, richiedono attenzione. Cerco sempre di far riflettere lo spettatore su ciò che sta guardando. È un gioco. Alcuni lavori sono di una bellezza quasi sublime: se non li osservi con attenzione, non li capisci. E se non presti attenzione, ti perdi molto della vita.
Questa strategia di seduzione si intreccia spesso con riferimenti alla storia dell’arte: dai «Rotoreliefs» di Duchamp ai rayogrammi di Man Ray, dal Costruttivismo russo alle esperienze percettive e psichedeliche degli anni ’70, fino ai generi classici del ritratto, del nudo e dell’astrazione.
Mi sono formato in un’accademia di belle arti e ho sempre invidiato i miei compagni che studiavano pittura o scultura, mentre noi di fotografia eravamo più limitati. Non mi sono mai considerato semplicemente un fotografo. I miei riferimenti sono sempre stati quelli di chi riflette sull’immagine, sulla visione, sulla possibilità di trasformare un esperimento tecnico in un’esperienza estetica e mentale.
Questa tensione tra scientificità e percezione, tra tecnica e memoria, è una costante nel suo lavoro. Accanto all’inclinazione «scientifica», coltiva un’altra ossessione: l’archivio e il recupero dell’immagine. Già nelle prime raccolte di ritagli di giornale (migliaia di frammenti selezionati e ingranditi) rileggeva il flusso visivo dei media come un deposito da smontare e ricomporre. Decontestualizzate e accostate, le immagini diventavano un commento silenzioso e a tratti inquieto sul nostro tempo.
Sì, ho sempre avuto anche questo interesse. Le opere «Press++», ad esempio, nascono da una collezione di fotografie astronomiche e spaziali. Ho comprato alcune immagini online. Quando arrivarono, voltandole scoprii che il retro era interessante quanto il fronte: timbri, didascalie, appunti, frammenti di informazione. A un certo punto ho pensato che fosse necessario unire fronte e retro, anche a costo di distruggere la composizione, per creare un nuovo livello di lettura. Mi interessava indagare non solo la tecnica, ma anche la sua distribuzione. Una fotografia, isolata dal testo, perde significato. Normalmente una foto di stampa arriva con una didascalia: è il testo a contenere l’informazione, l’immagine ne è l’illustrazione. Se separi i due elementi, non capisci più nulla. Anche la serie «JPEG» nasce da questa riflessione: esplorare la distribuzione delle immagini sul web, chiedersi cosa vediamo davvero, quanto riconosciamo e quale nuova struttura il digitale imponga. Il pixel è il nuovo dettaglio, non più la grana analogica. Ed è lì, in questa nuova materia visiva, che continuo a cercare.
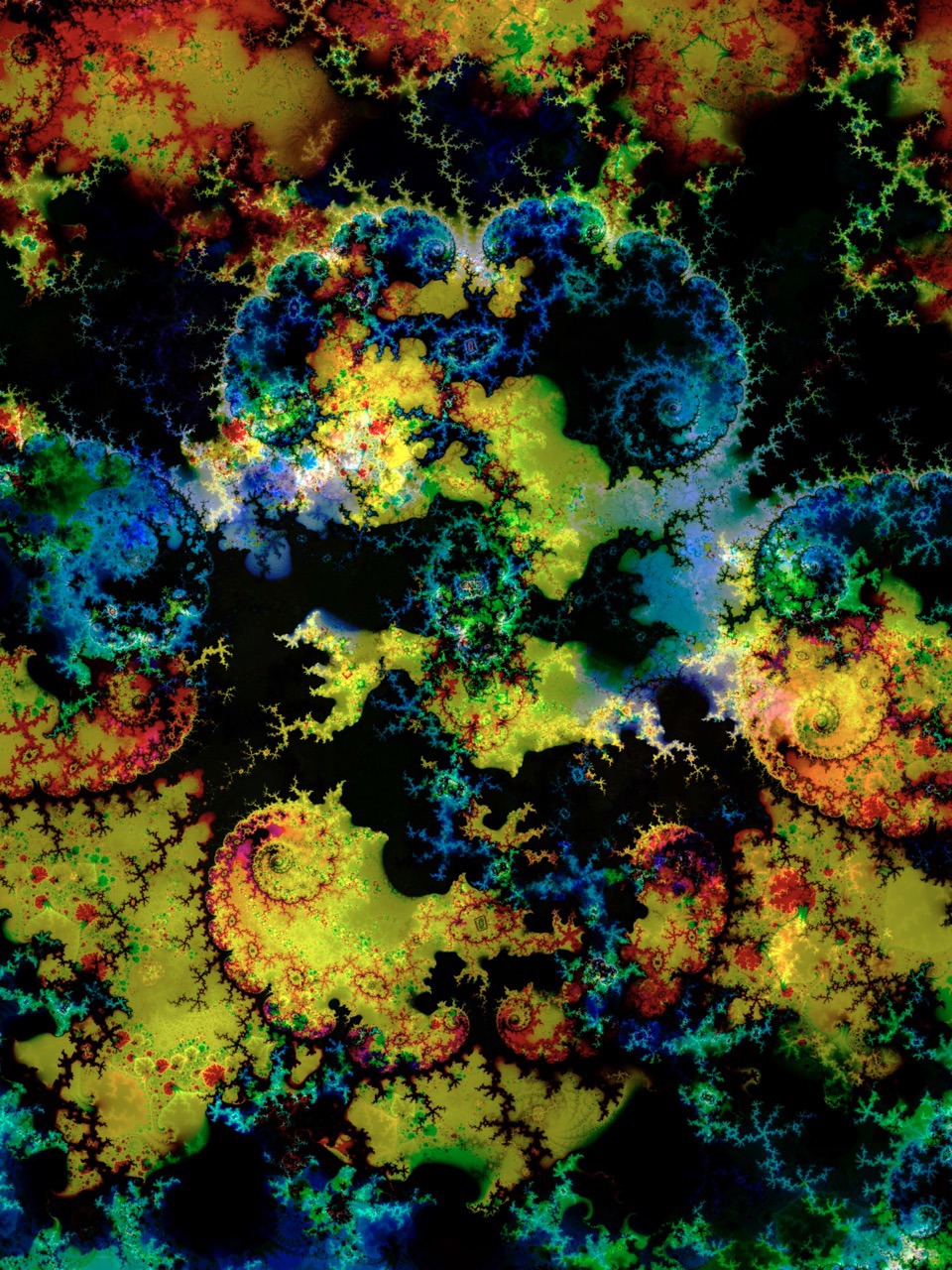
Thomas Ruff, «d.o.pe.15», 2023. Courtesy dell’artista e Galleria Lia Rumma Milano/Napoli
Altri articoli dell'autore
«In Iran si è formato un campo culturale radicale che vive fuori dalle istituzioni e dal mercato», spiega l’artista. «Social e spazi informali (case, strade, caffè, parchi...) diventano archivi alternativi, dove l’esperienza è registrata e condivisa in tempo reale»
Il racconto degli artisti tra censura e diaspora. Intanto fuori dal Paese l’interesse cresce in musei, biennali, mercato. Ma c’è un rischio: incorniciare l’arte iraniana in narrazioni preconfezionate di crisi e trauma, in storie «consumabili» di sofferenza
L’artista austriaca, protagonista con Ketty La Rocca della mostra in corso da Thaddaeus Ropac, racconta della sua «lotta» ancora necessaria, tra arte, linguaggio e politica
Dopo decenni di aperture globali e spettacolarità sopra le righe, prende piede una dimensione più intima e personale, introspettiva e autoriflessiva




















