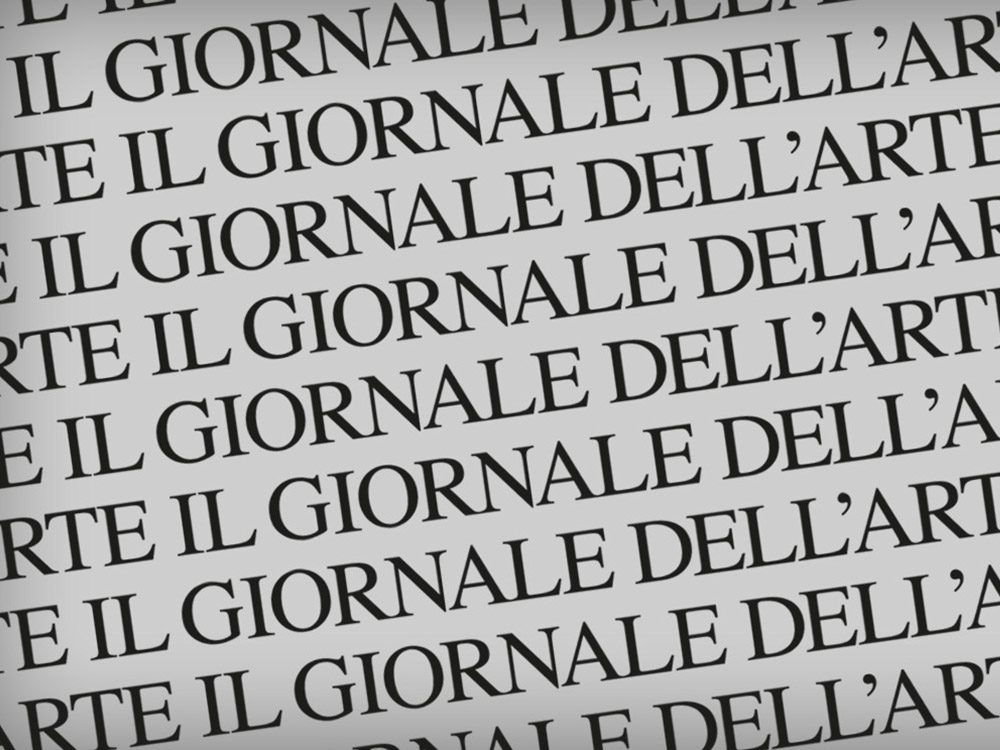Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Redazione GDA
Leggi i suoi articoliSi inaugura il 13 ottobre la grande esposizione «La Reggia di Venaria e i Savoia. Arte, magnificenza e storia di una corte europea»: non una semplice mostra temporanea, ma piuttosto un percorso lungo più di un chilometro e mezzo nelle sale della reggia di Venaria Reale, finalmente allestita dopo otto anni di restauri e 200 milioni di euro investiti. Il tutto grazie a un forte sostegno delle istituzioni locali e nazionali, a partire da quel giorno del 1996 quando Walter Veltroni, allora ministro, visitò per la prima volta le sale disastrate della Reggia abbandonata da decenni.
Raccontano a «Il Giornale dell’Arte» la storia recente, le vicende di quello che è stato indicato come «il più vasto cantiere in Europa» e le prospettive del complesso (Reggia, giardini e molto altro, tutto per la gran parte finalmente accessibile) Alberto Vanelli, responsabile regionale per la Struttura Flessibile La Venaria Reale e altri Beni Culturali, e Francesco Pernice, soprintendente ai Beni architettonici e al Paesaggio e guida operativa del cantiere.
L'inaugurazione della mostra è anche un'occasione per presentare per la prima volta il cantiere che ha salvato la Venaria Reale dall’abbandono, quando sembrava impossibile reperire le risorse per un’operazione così colossale. La svolta si associa al ruolo dell’allora ministro per i Beni culturali Walter Veltroni.
A.V. Già nell’84 con i Fondi Fio la Soprintendenza dispose di una ventina di miliardi di lire con cui risistemò i tetti e realizzò urgenti interventi di salvataggio e manutenzione. Poi venne restaurata la Galleria di Diana. Nel ’95 l’interesse per la Venaria fu rilanciato dal convegno «Salvare la Venaria» organizzato dalla Soprintendenza per i Beni architettonici del Piemonte. Così sono state create le condizioni per tutto ciò che è venuto in seguito.
Certo è che la storia vera del restauro della Venaria Reale nasce poco prima delle elezioni del ’96, quando Piero Fassino, che per 26 anni ha avuto il suo collegio elettorale proprio a Venaria, tiene un comizio in città insieme a Veltroni. Alla fine del comizio Gianfranco Falzoni, presidente dell’Associazione Venariese Tutela Ambiente, accompagna Veltroni e Fassino a visitare la Reggia di Venaria alle 23.30, alla luce delle torce. Fu un colpo di fulmine. Di lì a poco, Prodi vince le elezioni politiche e Veltroni diventa Ministro dei Beni culturali. Nell’estate va in televisione ospite di Bruno Vespa a «Porta a porta», inaspettatamente racconta di aver visto, durante la campagna elettorale, in un paese vicino a Torino di cui non ricordava il nome, un edificio straordinario, una Versailles abbandonata, e conclude affermando di voler caratterizzare il proprio Ministero, salvando questo straordinario edificio al Nord e un altro al Sud, da individuare (sarebbe poi stato scelto l’Albergo dei poveri a Napoli, il cui cantiere è stato attivato da poco).
Mentre guardavo la trasmissione mi chiama a casa Enzo Ghigo, l’allora presidente della Regione Piemonte, e mi chiede: «Cosa ne pensi se chiamo la trasmissione in diretta e dico “Sono il presidente della Regione Piemonte, voglio proporre al Ministro di restaurare Venaria metà per ciascuno”?». In realtà Ghigo non chiamò Veltroni quella sera, ma il giorno successivo gli chiese un appuntamento. All’incontro in Palazzo Chigi c’erano il direttore generale del Ministero Mario Serio, il soprintendente per i Beni architettonici del Piemonte Pasquale Malara ed io.
Qual era la previsione di spesa?
A.V. In quell'occasione venne fatto un calcolo approssimativo a metro quadro. La Reggia con Citroniera e Scuderia misura 80mila metri quadriat; con i giardini (80 ettari) bisognava considerare a grandi linee di dover recuperare un milione di metri quadrati a due milioni di lire al metro quadrato, dunque duecento miliardi di lire! Veltroni accettò e disse a Ghigo: 100 li metto io, 100 tu con i Fondi europei. Dopodiché abbiamo istituito una Commissione tecnica, che doveva studiare la fattibilità dell'idea, e un Comitato politico.
È a questo punto che entra in gioco il Lotto. È dunque nato con il progetto Venaria?
A.V. Praticamente sì. Veltroni intendeva lanciare l’idea delle estrazioni del Lotto per salvare i beni culturali. Per trovare i 100 miliardi di lire per cui si era impegnato, ha dirottato su Venaria tutti i proventi del mercoledì del primo anno di estrazioni, ricavandone 85, 45 dei quali vennero messi a disposizione subito (nel 1997) e gli altri tre anni dopo. Forte di ciò la Regione si è rivolta all'Unione Europea.
È con i 45 miliardi del Lotto che sono partiti i lavori in Sant’Uberto?
F.P. No, la chiesa è stata restaurata con 3 miliardi dell’otto per mille dell’Irpef. Il cantiere di Sant’Uberto, partito nel ’98, è indipendente da quello dal complesso della Reggia.
Come è stata coinvolta l’Unione Europea?
A.V. L’Unione Europea era perplessa sull'erogare per il restauro di un bene culturale fondi destinati allo sviluppo economico, alla lotta al declino industriale e a investimenti produttivi. Di fronte alle nostre insistenze ci è stato richiesto di presentare entro tre mesi uno studio di fattibilità che evidenziasse i parametri economico-finanziari, la redditività dell'investimento, gli effetti occupazionali, gli aspetti economici del progetto. Una volta ottenuta anche la valutazione di impatto ambientale, Bruxelles ha approvato il progetto.
La Regione Piemonte ha svolto un ruolo di coordinamento generale?
A.V. Non è così. Il decreto con il quale Veltroni stanziò gli 85 miliardi prevedeva la stipulazione con la Regione di un Accordo di Programma Quadro che definì le rispettive responsabilità tra Regione e Ministero, istituì la commissione che dà la valutazione sulla qualità dei progetti e un’altra commissione tecnica che valuta la loro validazione, quindi i prezzi, gli oneri, i tempi, approva gli esecutivi e le varianti ecc. Operiamo da allora attuando quell’Accordo di Programma che definisce il quadro di riferimento di tutta l’organizzazione progettuale, prevede che alla Provincia spettano le infrastrutture e le strade, e al Comune il restauro del centro storico.
Fatto l’accordo di programma si procede all’affidamento dei lavori?
F.P. Nel ’98 escono sette bandi di gara per la Reggia, i giardini, gli impianti, il Borgo Castello, la Citroneria ecc. Nel frattempo arrivano i soldi dell’Unione Europea. Alla fine del ’98 erano stati compiuti tutti gli affidamenti.
Qual è il primo cantiere attivato?
F.P. Quello del corpo secentesco del Castellamonte nel ’99, poi i due lotti dei giardini, il Centro del restauro, la cascina Rubianetta (il Centro del Cavallo)... Vengono invece sospesi gli affidamenti di Citroniera e Scuderia.
Per lo spostamento del Museo Egizio?
A.V. Sì. Finché non veniva presa una decisione in merito allo spostamento dell’Egizio o a un’altra eventuale destinazione d’uso i progettisti non potevano lavorare. L’ipotesi dell'Egizio a Venaria era esplosa a seguito di un’intervista rilasciata da Federico Zeri a «La Stampa» in cui si dichiarava favorevole al trasferimento. Scoppia un finimondo! Regione e Città di Venaria si dicono favorevoli, Veltroni dà un assenso di massima ma esprime il desiderio di rimanere esterno alla decisione; del tutto contrari, invece, il Comune di Torino, la Compagnia di San Paolo, il soprintendente al Museo Egizio Anna Maria Donadoni. L’idea sembra quindi decadere.
Che tipo di interesse, politico e culturale, hanno avuto i Ministri successivi?
A.V. Giovanna Melandri, forse anche per una certa assonanza con Veltroni, si entusiasma e, guardando gli spazi colossali delle Scuderie, afferma: «Sono meravigliose, che cosa volete metterci? Sembrano perfette per l’Egizio». Apriti cielo: le polemiche si rinnovano... Ecco allora l’idea dello studio di fattibilità, finanziato dalla Compagnia di San Paolo (che già si era dichiarata contraria all’opzione) e commissionato a Paolo Leon del Cles. Secondo lo studio, con l’Egizio si sarebbero avuti «solo» 800-900mila visitatori, contro 1.113.000 visitatori con la cosiddetta «Macchina Reale». Inizialmente la Melandri rilancia, poi capisce che è una scelta politicamente non sostenibile, e l’idea dell’Egizio cade definitivamente. Viene bandito un restauro di tipo conservativo. Le Citroniere vengono destinate a giardino d’inverno, le Scuderie a ospitare grandi mostre.
E i Ministri dopo la Melandri?
A.V. Giuliano Urbani, molto amico di Ghigo, viene a Venaria subito dopo la sua nomina nel giugno 2001, insieme a Vittorio Sgarbi, allora suo sottosegretario. E anche lui rimane incantato dalla Reggia, nonostante una visita alquanto accidentata nel fango del cantiere. Nell’aprile 2005 arriva al Ministero Rocco Buttiglione: a Venaria non viene, ma comunque sostiene i lavori.
Infine, Rutelli.
A.V. Anche per lui Venaria è stata la meta del primo viaggio da Ministro. Il cantiere ha sempre goduto dell’appoggio totale delle istituzioni, a livello sia nazionale sia locale, prima con Ghigo, poi con Mercedes Bresso in Regione, con il suo successore Antonio Saitta in Provincia, con Catania e Pollari al Comune di Venaria. Qualche problema iniziale l’abbiamo avuto con l’Unione Europea che non voleva darci i soldi perché andavano spesi entro il 31 dicembre 2001: avendo appaltato i lavori nel 1999, era del tutto evidente che non avremmo potuto spendere 140 miliardi di vecchie lire in soli due anni, anche se i lavori erano a buon punto, con due soli lotti su otto in ritardo. Ma la «fortuna», se così si può dire, ci è venuta in soccorso. Nella forma di una colossale alluvione che, nel luglio 2001, ha ricoperto giardini e cantiere come in un immenso mare: una visione impressionante. Abbiamo inviato a Bruxelles la documentazione, con le immagini della Reggia che emergeva dall’acqua. Nel giro di cinque giorni l’acqua era defluita, ma l’Ue ci ha concesso qualche mese di proroga, e a dicembre 2002 tutto era concluso come da accordi. Abbiamo quindi potuto accedere a ulteriori finanziamenti tra cui il finanziamento europeo 2001-08 con 50 milioni di euro, disponibili dal 2003, per l’intero ambito delle Residenze Sabaude, di cui Venaria vuole essere il fulcro. Nel complesso Venaria ha ricevuto finanziamenti per 200 milioni di euro, tra Stato, Regione, Unione Europea e sostenitori privati.
Molti di questi soldi sono stati spesi, e molto è stato già inaugurato, compresa parte dei giardini. Che cosa vedrà il pubblico a Venaria il 13 ottobre?
F.P. Troverà 18mila metri quadrati di architettura restaurata e allestita. E non si tratterà di una mostra, ma piuttosto dell’allestimento di un vasto e complesso percorso di visita, suddiviso concettualmente in quattro linguaggi di comunicazione. Il primo è l’«architettura che racconta»: esistono all’interno del percorso almeno quattro o cinque punti di bellezza così clamorosi che possono essere proposti come tali, nella loro semplice essenza. Sono la Sala di Diana, dove vengono riallestiti i cicli pittorici delle Cacce di Jean Miel, e dei ritratti delle principesse a cavallo. Poi, la Grande Galleria, allestita da Juvarra, i cui stucchi sono tutti dedicati alle glorie di Carlo Emanuele III e alle sue vittorie militari nel ’700; la Chiesa di Sant’Uberto, sempre di Juvarra, e la Galleria di Benedetto Alfieri, con il rondò del belvedere, in cui sono state ricollocate le sculture originali. Anche la cucina nel piano inferiore sarà davvero suggestiva...
Una parte importante dell’allestimento è stata affidata a Peter Greenaway.
A.V. Il regista inglese è intervenuto in cinque punti del percorso, due nel «piano basso», che è quello storicamente destinato ai «servizi». Nella cucina, ad esempio, mette in scena la preparazione di un banchetto, mentre al piano nobile illustra la vita privata del duca, l’uscita per la caccia e una festa di corte con una lunga processione.
Quali altri interventi sono stati realizzati lungo il percorso?
A.V. È previsto un apparato multimediale di supporto che spiega la storia della Venaria Reale e quella della dinastia sabauda. E poi ci sono gli oggetti esposti nella mostra «La Reggia di Venaria e i Savoia. Arte, magnificenza e storia di una corte europea» (catalogo in due volumi Umberto Allemandi & C.), che sono di tre tipi. Quelli che appartengono a Venaria, tra cui il ciclo di dipinti della Sala di Diana e numerose sculture, che vi hanno fatto ritorno e che vi resteranno per sempre. Altri appartengono a collezioni appositamente acquisite dalla Regione o dalla Compagnia di San Paolo, oppure di proprietà ministeriale: in questo caso, si tratterà di depositi lunghi, nell’ordine di dieci o quindici anni, che trovano nel nuovo allestimento un proprio inserimento coerente. Alcuni depositi di medio periodo, tre o quattro anni, provengono da altre residenze sabaude. Il terzo tipo di oggetti costituisce l’esposizione temporanea vera e propria in quanto si tratta di prestiti da grandi musei italiani e internazionali oltre che da privati, come la fondazione Umberto II e Maria José di Savoia (un centinaio di opere su complessive 470). Queste opere a fine mostra torneranno ai rispettivi musei, con cui però abbiamo già accordi, in via di perfezionamento, per futuri nuovi prestiti. L'idea è che la Reggia sia destinata ad allestire esposizioni sul tema della vita, della storia e della cultura delle corti e degli stati europei dal 1500 al 1800.
C’è poi la mostra sul restauro della Reggia, curata dalla Soprintendenza.
F.P. Sarà la fabbrica del restauro, come ci sono le fabbriche del Duomo... Raccoglieremo i materiali utilizzati in cantiere, come le 180 dime usate nella Chiesa di Sant’Uberto... La mostra spiegherà come si esegue il restauro di un muro, quello dei balaustrini, dei gessi. Esporremo le sagome realizzate durante i restauri compiuti dal soprintendente Umberto Chierici del 1960. Sarà una mostra didattica permanente.
Qual è il costo dell’allestimento?
A.V. La Regione Piemonte ha trasferito 5 milioni di euro per tutta la direzione, la produzione e la messa in scena, compreso un milione di euro, che è il costo della produzione di Greenaway, e un milione e mezzo per l’allestimento delle strutture di supporto (vetrine, illuminotecnica, grafica...).
Proviamo a fare un po’ di conti sui cantieri conclusi e in via di conclusione.
F.P. Le superfici piane restaurate nell’ambito di tutto il progetto Venaria ammontano a 240mila metri quadrati: oltre alla Reggia in senso stretto, Sant’Uberto, le Scuderie alfieriane in cui ha sede il Centro per la Conservazione e restauro già operante, il Castelvecchio, le Scuderie e Citroniere juvarriane, il Borgo Castello della Mandria, la Cascina Rubianetta, la Cascina Medici del Vascello e la Villa dei Laghi.
Che cosa inaugurerà prossimamente?
A.V. Tra un anno saranno pronti altri 20 ettari di giardini oltre ai 25 inaugurati il 10 giugno. Per il 2009 dovremmo inaugurare il Centro del paesaggio nel Castello della Mandria, che abbiamo appaltato il 22 di settembre. A quella data saranno pronti anche il Borgo Castello e due alberghi, uno dentro il Castello e uno nella Villa ai Laghi. Il museo della Mandria dedicato agli antichi mestieri verrà anch'esso ultimato entro il 2009. Diciamo che tutto sarà pronto e fruibile per il 150mo anniversario dell’Unità d'Italia nel 2011. Per la fine del prossimo anno, al massimo nella primavera del 2009, saranno pronte anche la Citroniera, la Scuderia (12mila metri quadrati su due livelli: uno spazio grandi mostre al piano terra e un grande bar, un ristorante e una sala convegni al piano superiore) e i piani superiori del corpo monumentale della Reggia destinati a uffici, biblioteca, archivi, centro di documentazione. E la gran sorpresa, per il pubblico, del teatro di corte barocco, con le sue magnifiche vetrate sui giardini.
C’è qualche orientamento per le mostre nelle Scuderie? Saranno mostre di archeologia o di arte antica o di contemporaneo?
A.V. L’arte contemporanea a Venaria è rappresentata dagli interventi nei giardini: quello di Penone e altri in programma. Al limite possiamo fare qualcosa con il Castello di Rivoli. Si pensa piuttosto all’archeologia; il tema di fondo sarà il rapporto uomo-ambiente nella civiltà antica. Ora faccio dell’ideologia: chi andava nelle grandi corti europee vi trovava il meglio della cultura, della letteratura, della musica, dell’arte. Oggi non è più la corte sabauda ma è il popolo chiamato a rappresentare e a esporre il meglio della storia, della ricerca, della cultura, dell'arte, della musica, della moda, del design...
Proviamo a fornire un'idea delle dimensioni di Venaria attraverso qualche numero significativo.
F.P. Dal 13 ottobre saranno visitabili 240mila metri quadrati, 11 km di cornici e stucchi, 62mila metri quadrati di intonaci, 3mila tonnellate di pietre, 26mila metri quadrati di pavimenti, 6mila metri quadrati di affreschi, migliaia di chilometri di tubazioni (circa 70 solo nella Grande Galleria), 7mila metri quadrati di coperture, 800 persone al al lavoro al giorno per tutti questi 8 anni, 90 imprese.
Quali sono state i criteri e le linee scelte per il restauro?
F.P. Criterio di restauro conservativo, ma integrato, nel senso che si è voluto dare al visitatore un’immagine di finito, sia nella parte degli apparati decorativi che negli stucchi, ma facendo vedere qual è la parte nuova e la parte originale.
Ciò è avvenuto in tutte le porzioni del restauro, anche quando la filosofia del restauro era diversa?
F.P. Nelle sale seicentesche del padiglione Garove ovest gli stucchi erano stati restaurati negli anni Ottanta secondo il criterio archeologico. Volevo conservarle per documentare la filosofia di restauro di quegli anni, ma poi abbiamo pensato che la gente non avrebbe potuto comprendere perché solo in quelle stanze c’erano lacune così evidenti.
Il restauro di Venaria è stato realizzato con metodologie all’avanguardia e prodotti studiati ad hoc: ciò ha comportato maggiori costi?
A.V. Al contrario, li abbiamo abbattuti. Basta dividere 200 milioni di euro per 200mila metri quadrati: fa meno di mille euro al metro quadrato.
Com’è stato possibile?
F.P. Già nel ’94, quando divenni direttore della Reggia, iniziai a sperimentare nuove tecniche e nuovi materiali da applicare al restauro, attraverso una grande campagna diagnostica per individuare i materiale usati da Juvarra, Alfieri e Castellamonte. Dopodiché in laboratorio abbiamo ricreato, in collaborazione con varie ditte, le malte di calce, il marmorino sabaudo, il cotto e altri prodotti originali che abbiamo poi fatto certificare a norma europea. Oggi si trovano in commercio e i restauratori non possono più applicare tariffe salate per le loro «pozioni».
Avete anche recuperato antichi mestieri?
F.P. Abbiamo riaffidato il mestiere agli artigiani specializzati che erano scomparsi comportando il passaggio di alcune loro lavorazioni nelle mani dei restauratori, il che aveva fatto salire i prezzi. Abbiamo dunque ricreato una professionalità ridimensionando i costi. È il cosiddetto «metodo Venaria» che sta facendo scuola in tutt’Europa.
Sembra che non ci sia stato per i giardini lo stesso obiettivo di riproposizione «filologica» seguito per altre parti della Reggia.
A.V. Ci si è basati su quattro criteri. Prima di tutto, una veduta aerea a raggi infrarossi ha rivelato il disegno dei giardini antichi, con la maglia, gli assi, gli alloggiamenti, tanto da consentire anche il recupero di oggetti di arredo puntiforme, ormai scomparsi. Ma il problema principale era quello di decidere quali giardini recuperare: se quelli del Seicento o quelli ricostruiti da Juvarra nel Settecento, senza contare che alcune parti della prima fase dei giardini erano già state distrutte dallo stesso Castellamonte a vent’anni dalla loro realizzazione. Il criterio generale è stato quindi di proporre il disegno seicentesco nel Parco basso, con la peschiera e i quadrati ora occupati dal «Giardino delle sculture fluide» di Giuseppe Penone, e il disegno juvarriano nel Parco alto. Parallelamente, sono state condotte analisi storiche e botaniche per individuare le piantumazioni antiche. Il progetto, ovviamente, si è preso qualche piccola libertà: d’altra parte, oggi abbiamo a disposizione molte più varietà arboree e floreali. Terzo criterio: conservare e riproporre in forma archeologica tutto ciò che di interessante fosse affiorato. Quarto criterio: invece di riproporre falsi (scelta che peraltro è stata compiuta in non pochi parchi storici, soprattutto all’estero), affidare la «decorazione» a grandi artisti internazionale chiamati, uno alla volta, ad arricchire i giardini con fontane, sculture e interventi puntuali. Dopo Penone, Giulio Paolini sta lavorando nell’area della Peschiera. C’è anche l’ipotesi di Ettore Spalletti per il lungo asse. Il tutto grazie a finanziamenti ministeriali e, per le opere degli artisti contemporanei, della Compagnia di San Paolo (1,5 milioni per Penone).
Quando tutto il complesso sarà operativo, quali sono i costi di gestione previsti?
A.V. Uno studio dell’'Ires li ha previsti nell’ordine di 15 milioni di euro. Vi lavoreranno 450 persone, 150 delle quali interne. Quasi due milioni all’anno saranno destinati alla comunicazione e fino a cinque per realizzare ogni grande mostra. Con una gestione molto attenta (quale abbiamo mantenuto fino ad ora) dovrebbero essere sufficienti 10-12 milioni annui.
Si è già previsto il passivo annuo? Quanto è disposta a stanziare la Regione?
A.V. C'è un protocollo d'intesa che verrà presto sottoscritto. Si pensa che 6 milioni possano essere coperti dagli incassi prevedendo 6-700 mila visitatori annui. Il deficit annuo di 9 milioni verrebbe diviso in parti uguali tra Ministero, Regione e Compagnia di San Paolo.
A che punto siete con la definizione dell’ente di gestione?
Si sta lavorando all’ipotesi fondazione e a quella comitato, privo di un fondo da gestire, ma con l’impegno dei soci a finanziare.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
130 anni di costruzione, 157 di declino e abbandono
a cura di Barbara Antonetto
1658-1679 Prima fase costruttiva
- 1658 Il duca Carlo Emanuele II di Savoia commissiona all’ingegnere ducale Amedeo di Castellamonte (1613-1683) l’edificazione, nel territorio di Altessano che ospitava le cacce reali fin dal 1632, di un moderno «Palazzo di piacere e di caccia», da inserirsi nella «corona di delizie», il sistema di residenze intorno alla capitale impostato da Emanuele Filiberto nel Cinquecento e ampliato nel Settecento dai suoi successori. Denominata la Venaria Reale, viene concepita come espressione architettonica delle ambizioni dello Stato Sabaudo, in competizione con le grandi regge europee: non un semplice palazzo, ma un complesso in grande scala che prevede un centro urbano sviluppato lungo un asse che conduce al fulcro, la Reggia per la corte, e prosegue verso ponente con allee, giardini all’italiana, fontane e campi ove esercitare l’arte venatoria estesi fino ai primi rilievi alpini.
- 1659 Amedeo di Castellamonte avvia i lavori.
- 1663 Si conclude l’edificazione del corpo principale: la Reggia di Diana articolata intorno alla grande Sala di Diana decorata da principesse a cavallo e fantasie venatorie dipinte da Miel, Dauphin, Caravoglia, Recchi e Casella entro partiti di stucchi modellati da Bernardino Quadri e Giovan Battista Muttoni. La costruzione della Venaria Castellamontiana procede con l’edificazione dei padiglioni laterali (1669), i «paviglionetti» che formano il cortile a tenaglia (1672), il Tempio di Diana (1673) e la Citroniera (1679).
- 1679 Amedeo di Castellamonte dà alle stampe il volume Venaria Reale, Palazzo di Piacere e di Caccia, ideato dall'Altezza Reale di Carlo Emanuele II, Duca di Savoia, re di Cipro, ecc. Disegnato e descritto dal Conte Amedeo di Castellamonte l'Anno 1672. In Torino, per Bartolomeo Zappata, 1674 (ma 1679): Amedeo di Castellamonte immagina di condurre il cavalier Bernini in visita alla celebre «delizia» di Venaria. Innanzitutto l’architetto spiega la volontà di Carlo Emanuele II di legare il suo nome a un grande palazzo, come i suoi antenati, e ricorda il Castello di Rivoli e il Regio Parco per Carlo Emanuele I, Mirafiori per Emanuele Filiberto, il Valentino per Vittorio Amedeo I, Moncalieri e la Vigna di Madama Reale per Madama Cristina, residenze disposte intorno alla città «a poco più di tre miglia italiane per uguali intervalli» per completare «il viaggio di una giusta giornata fra magnificenze di fabbriche, fra amenità di fontane, di allee e di giardini; cosa veramente rara e forse da V.S. non osservata in altri paesi d’Italia». L’unità originaria, architettonica e funzionale, tra Reggia e Borgo, viene fatta rilevare dallo stesso Bernini non appena la carrozza si inoltra nel lungo rettilineo in asse al castello e attraversa la piazza con le due chiese gemelle e le due colonne sormontate dall’Angelo Annunziante e dalla Vergine Annunziata simboli dell’ordine cavalleresco di Casa Savoia, il collare dell’Annunziata.
- 1693 La Reggia subisce danneggiamenti ad opera dei francesi di Catinat in guerra con Vittorio Amedeo II.
1699-1713 Seconda fase costruttiva
Il duca Vittorio Amedeo II richiede all’ingegnere Michelangelo Garove (1648-1713) di riprogettare la Venaria Reale che, a confronto con le grandi residenze europee, risulta troppo contenuta nelle dimensioni e poco aggiornata nel gusto. Garove appronta un progetto di spiccata influenza stilistica francese che viene sottoposto alla supervisione dell’architetto del Re Sole Robert de Cotte (politicamente in quegli anni il Ducato è soggetto alla tutela dei francesi).
- 1699 Si apre il cantiere che avrebbe dovuto realizzare due lunghe ali simmetriche ortogonali alla Reggia di Diana castellamontiana. L’ala destra avrebbe dovuto terminare con un teatro, l’ala sinistra con una cappella. Anche i giardini vengono ripensati alla francese e cambiano radicalmente secondo i disegni del De Marne, collaboratore di Le Nôtre, e sotto la guida dell’intendente Duparc (il Tempio di Diana viene eliminato).
- 1706 La Reggia di Venaria subisce danni durante l’assedio di Torino da parte dei francesi.
- 1713 Il cantiere si blocca per la morte di Garove e il progetto rimane incompiuto: è realizzata solo l’ala sinistra costituita, alla francese, da due padiglioni (il Garove ovest e il Garove est) collegati da una galleria, la Grande Galleria, impropriamente ma più comunemente detta Galleria di Diana. La costruzione dell’ala garoviana aveva comportato l’abbattimento degli edifici di servizio castellamontiani, fra i quali la Scuderia e la Citroniera.
1714-1730 Terza fase costruttiva
- 1714 L'architetto messinese Filippo Juvarra (1678-1736), regista del neonato Regno di Sardegna (era terminato il protettorato politico della Francia e nel 1713 Vittorio Amedeo II era stato insignito del titolo regio), schizza un disegno con quattro idee per gli ornati della Grande Galleria.
- 1716 Juvarra apre il cantiere a Venaria e in due anni trasforma la Grande Galleria (80 metri di lunghezza, 12 di larghezza, 14 di altezza) in uno straordinario spazio di luce, aprendo archi nelle pareti e ovali nell’attacco della volta.
- 1717 - 1728 Juvarra realizza la Cappella di Sant’Uberto, capolavoro in cui la luce assume una funzione architettonica.
- 1722 - 1729 Viene costruito l’edificio che contiene la Scuderia e la Citroniera. Le dimensioni (i due ambienti contigui sono lunghi 146 metri, larghi rispettivamente 12,40 e 14 metri e alti 14,50 e 16), l’articolazione e la ricchezza compositiva concorrono a un effetto di maestosità ed eleganza sorprendente rispetto alla destinazione d’uso. Gli impresari, protestando per il lievitare dei costi, scrissero: «Ci hanno fatto fare una fabrica di una alzata straordinaria...fabrica piuttosto di un magnifico tempio che di una schuderia e citroniera...e se ci avessero mostrato il disegno come si doveva dell’alzata et ornamenti... non si sarebbe nemmeno fatta detta fabrica». Juvarra porta a compimento i giardini della Reggia (circa 87 ettari delimitati dal terrazzamento che si affaccia sul Parco Basso), in cui vengono allestiti gli Appartamenti verdi («camere» con pareti e volte di vegetazione) e, a sud dei Giardini della Reggia, il Parco dei Quadrati, 240 ettari di spazi agricoli suddivisi da lunghi viali alberati e boschetti.
1739-1765 Quarta fase costruttiva
- 1739 Benedetto Alfieri (1699-1767), primo architetto di Carlo Emanuele III, demolisce la Torre dell'orologio e realizza la corte principale.
- 1751 Alfieri dà inizio a una serie di lavori a Venaria che porterà il complesso alla sua massima estensione edilizia (il sistema verde raggiunge i 40 ettari tra Giardini della Reggia, Parco Basso e Parco dei Quadrati). Viene abbandonato il progetto di Garove e, privilegiando l’aspetto funzionale, viene realizzata una manica ad «L» che ha il suo snodo in una Torre-belvedere e che consente al re di raggiungere, dai suo appartamenti collocati nel padiglione Garove ovest, la Chiesa di Sant’Uberto, la Scuderia e la Citroniera stando sempre al coperto (uno dei due lati della «L», quello che collega la Torre-belvedere a Scuderia e Citroniera, è detto Piccola Galleria o Galleria Alfieriana). Nei giardini viene demolita la Fontana d’Ercole, ultimo ricordo del parco castellamontiano: le statue e gli altri elementi decorativi vengono riutilizzati in altre residenze dei Savoia o di esponenti dell’aristocrazia.
- 1754 Alfieri costruisce due nuove Scuderie ortogonali a quella juvarriana.
- 1757 Alfieri edifica le rimesse per carrozze.
- 1760 Alfieri realizza il galoppatoio.
- 1768 - 1772 Su disegno di Juvarra gli stuccatori Bolina, Sanbartolomeo e Papa realizzano l’apparato di stucchi della Grande Galleria.
1788 Quinta fase costruttiva
- 1788 In occasione delle nozze dei duchi d’Aosta, Giuseppe Battista Piacenza (1735-1818) e Carlo Randoni (1755-1831) decorano e arredano gli appartamenti al primo piano del padiglione Garove ovest in pieno stile neoclassico con l’intervento di Giuseppe Bonzanigo, uno dei protagonisti dell’ebanisteria piemontese. Nell’angolo sud-ovest della corte realizzano anche uno scalone che porta agli appartamenti.
1797-1954 Il declino
- 1797 Carlo Emanuele IV sopprime l’Azienda economica della Venaria Reale, ormai fallimentare per i danni subiti durante la guerra.
- 9 dicembre 1798 Il re e la corte lasciano Torino, caduta nelle mani dei francesi, alla volta della Sardegna. Venaria, come le altre residenze sabaude, viene sigillata e gli arredi vengono venduti all’asta o riutilizzati in altre sedi, in particolare in Palazzo Reale, divenuto sede imperiale (nei suoi giardini vengono collocati 14 vasi di marmo degli scultori Ignazio e Filippo Collino e le statue delle Quattro Stagioni di Simone Martinez; la Galleria Beaumont, attuale Armeria Reale, viene pavimentata con i marmi bianchi e verdi della Galleria di Diana di Venaria). Il parco viene deforestato a vantaggio di coltivazioni.
- 1804 La Reggia di Venaria, danneggiata dalle truppe francesi, è descritta in piena rovina.
- 1814 Il ritorno dei Savoia non comporta la rinascita di Venaria che, non più utilizzata dalla corte, viene spogliata degli ultimi arredi fissi spostati in altre residenze. Si inizia a porre il problema di come utilizzare il contenitore vuoto.
- 1818 Vi si installa la Regia Scuola di Veterinaria.
- 1823 Trova collocazione a Venaria la Regia Scuola di Equitazione.
- 1832 -1943 Il complesso passa al Regio Demanio Militare e vi si acquartierano l’Artiglieria e la Cavallerizza. L’insediamento di una caserma garantisce la sopravvivenza dell’edificio, seppur a costo di trasformazioni e degrado delle decorazioni. Il parco viene utilizzato come campo di esercitazioni e poligono di tiro.
- 1943 -1945 Nel corso della seconda guerra mondiale il complesso, abbandonato dall’esercito, diventa oggetto di atti di vandalismo e spogliazioni che lo riducono in uno stato disastroso, un rudere privo degli infissi.
1954-2007 Dai primi restauri al grande recupero
- 1954 -1960 Il complesso, passato dai militari al Ministero dei Beni culturali (allora dell’Istruzione) è oggetto dei primi interventi conservativi con fondi ordinari della Soprintendenza ai Monumenti.
- 1961 Nell’ambito delle celebrazioni per l’Unità d’Italia Venaria riceve uno stanziamento di 50 milioni di lire utilizzato principalmente per la Grande Galleria, il salone della Reggia di Diana, gli stucchi delle sale del padiglione Garove ovest.
- 1977 - 1982 Si realizzano una serie di interventi, in particolare sulle coperture, per un miliardo e 270 milioni di lire, ma le risorse continuano a essere insufficienti per pensare a un restauro complessivo.
- 1984 Il Progetto Fio prevede 35 miliardi per il risanamento radicale di Venaria e la destinazione museale di 18mila metri quadrati: ne vengono approvati 11 ed erogati il 60%. Si realizza 1/6 del previsto.
- 1998 - 2007 La svolta: fondi europei, statali e regionali consentono finalmente di affrontare il restauro complessivo (cfr. articolo).
Altri articoli dell'autore
L’Associazione archeologi del Pubblico Impiego (Api-MiBact) ha inviato una nota al Ministero della Cultura e a quello della Funzione Pubblica, nonché ai membri delle Commissioni cultura di Camera e Senato, per esprimere il proprio dissenso per il bando per 75 posti nell’area dell’elevate professionalità (Ep), le cui domande di partecipazione vanno presentate entro il 26 giugno
Il premio Nobel e il direttore del Museo Egizio si sono incontrati per parlare di musei e romanzi: «Sono simili: sono i “luoghi” in cui avviene l’interpretazione del significato della nostra vita, nei quali riflettere su sé stessi»
Anche quest’anno Tag Art Night, la Notte delle Arti Contemporanee, propone un palinsesto di mostre diffuse sul territorio cittadino
Rimodulate le competenze e modificato la struttura organizzativa: dal Segretariato generale al modello dipartimentale