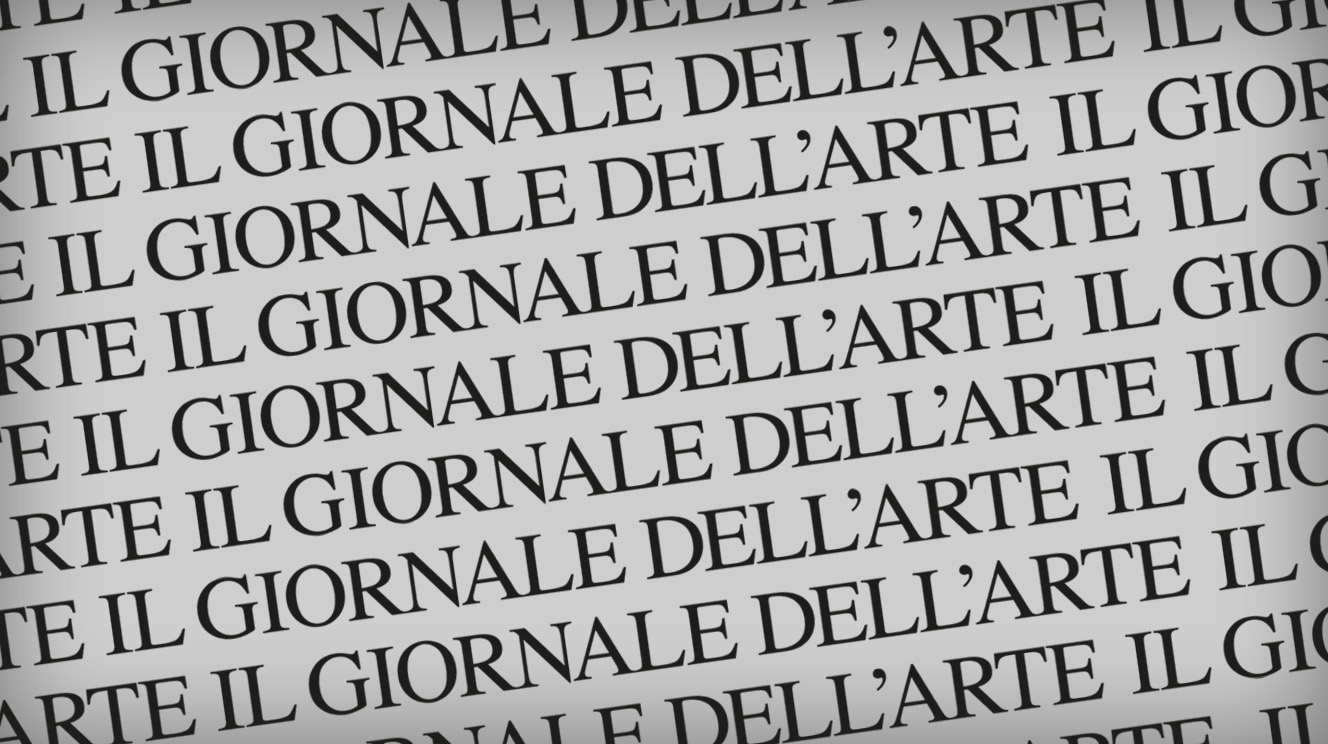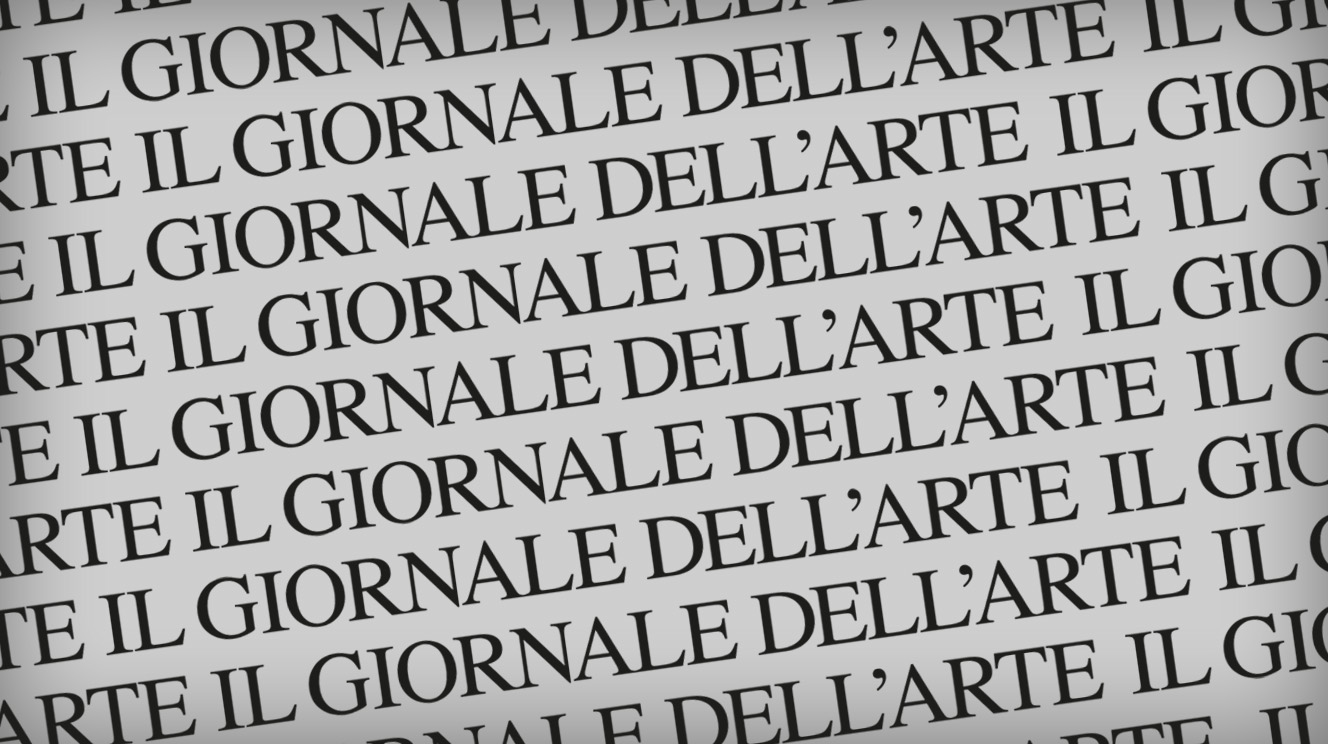Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Susanna Paparatti
Leggi i suoi articoliSono programmate durante il fine settimana le visite guidate che dal prossimo mese di giugno faranno conoscere al pubblico le meraviglie architettoniche, gli affreschi, i dipinti e gli arredi dell’attuale sede dell’Università di Padova, la seconda per antichità in Italia, fondata nel 1222 (per prenotare le visite: www.unipd.it). Il complesso monumentale che la compone, noto ai più quale Palazzo del Bo, narra una storia affascinante che attraversando i secoli ci ha consegnato la viva testimonianza dell’operato di architetti e artisti illustri, di accorpamenti, donazioni e ampliamenti che di fatto hanno sancito l’esistenza, oramai più formale che sostanziale, di un Bo storico e originale, seppur con i numerosi interventi che ne hanno modificato l’aspetto, e un altro nuovo: «Nella percezione del turista, ma anche del padovano, il Bo è solo quello storico, ovvero il comparto più antico del Palazzo concentrato intorno al Cortile Antico, spiega il rettore professor Giuseppe Zaccaria; il resto, volumetricamente ben più rilevante, è un qualche cosa di indefinito, quasi si trattasse di una aggiunta posticcia e trascurabile della parte nobile». In realtà la particolarità dell’insieme è proprio questo racchiudere contesti ed epoche così distanti fra loro; basti pensare che il cuore del Bo era un nucleo di costruzioni duecentesche. Il nome trae origine dal termine «bove», scelto probabilmente per la vicinanza con la contrada Bechariarum, dei macellai, ed era quello di una locanda menzionata in un documento del 1364, citato quale «Hospitium Bovis». L’Aula Magna adibita allo scopo nel 1856 era invece citata nel 1399 in veste di «sala magna» della locanda: divenuta poi sede della Scuola Grande dei Legisti che eccezionalmente accolse Galileo Galilei e dove, nel 1921, Albert Einstein tenne la sua celebre conferenza. Una lunga serie di passaggi di proprietà e coincidenze condussero nel 1539 all’acquisizione del palazzo da parte dell’Università, sino ad allora divisa in tre sedi. Un secolo ricco di novità per il Bo, che vedrà l’intervento dell’architetto Andrea Moroni per la costruzione del corpo centrale e il cortile monumentale; nel 1595 la realizzazione del primo teatro anatomico stabile nel mondo voluto dal patologo Girolamo Fabrici d’Acquapendente, citato nel De humani corporis fabrica di Andrea Vesalio e utilizzato sino al 1872. Oggi le visite organizzate all’ateneo concedono di toccare dal vivo la storia evolutiva del Bo dalle sue origini, giungendo alle ultime trasformazioni del ’900 quando il rettore Carlo Anti, in carica dal 1932 al 1943, chiamò attorno a sé i più grandi esponenti dell’architettura e dell’arte dell’epoca per ridisegnare l’ateneo. Da Gio Ponti ed Ettore Fagiuoli a cui si deve il Cortile Nuovo, ad Arturo Martini, Marcello Mascherini, Carlo Scarpa, Massimo Campigli, Ettore Fornasetti, Gino Severini, Filippo De Pisis, Achille Funi. Il percorso nell’ateneo che nel 1678 consacrò la prima donna laureata al mondo, Elena Lucrezia Comaro Piscopia, della quale si trova effigie, è dunque articolato iniziando dal rinascimentale Cortile Antico per poi salire al Teatro Anatomico, alla Sala dei Quaranta arredata con mobili disegnati da Gio Ponti, che conserva la cattedra che fu di Galileo e i ritratti degli studenti stranieri eseguiti nel 1942 da Gian Giacomo Dal Forno; l’Aula Magna, il cui aspetto attuale risale alla metà dell’800, ha il soffitto dipinto da Giulio Carlini, mentre nel 1942 Gio Ponti rifece i banchi del Senato e del podio. Dalla vicina Sala detta Basilica, così detta per la presenza delle 12 colonne rivestite in stucco rosso disegnate assieme al soffitto e agli arredi da Gio Ponti, si accede al Bo novecentesco. Qui nell’Archivio antico si trovano le scaffalature in palissandro, bosso, quercia di Svezia e pero realizzate fra il 1697 e il 1704 dal fiammingo Michael Bertens, risistemate nel 1940 sempre da Ponti. Da questo spazio si prosegue nella Galleria del Rettorato, con decorazioni iniziate nel 1942 da Piero Fornasetti e ultimate nel 1956 da Fulvio Pendini. Tutti gli ambienti successivi sono perfettamente conservati, impreziositi dall’estro di Ponti che ne curò ogni minimo particolare, dai disegni dei pavimenti in graniglia alla mobilia, dai lampadari ai colori delle tinte parietali, dalle maniglie alle suppellettili in una perfetta sintonia fra l’estro e il design italiano del tempo. La Galleria del Rettorato, il Circolo dei Professori, la Sala di Lettura, quella da Pranzo e del Caminetto, la Sala di lauree della Facoltà di Giurisprudenza con affreschi di Gino Severini e quelle di Medicina con lavori di Funi, la Scala del Sapere decorata da un affresco eseguito da Ponti, Giovanni Dandolo e Fulvio Pendini, l’Atrio degli Eroi dove trova spazio «Palinuro», scultura di Arturo Martini, e infine il Cortile Nuovo con opere di Attilio Selva e Paolo Boldrin: qui sono conservate anche opere recenti come la stele in bronzo di Giò Pomodoro, commissionata nel 1992 in occasione dei 400 anni dalla chiamata di Galileo alla cattedra di matematica, e «Resistenza e Liberazione» del 1995 di Jannis Kounellis.

La Sala dei Quaranta con la cattedra di Galileo Galilei e i ritratti degli studenti stranieri realizzati da Gian Giacomo Dal Forno nel 1942,

Veduta notturna del Cortile Nuovo progettato da Ettore Fagiuoli.

La Sala di Lettura di Gio Ponti

Sala detta Basilica con le dodici colonne rivistite in stucco rosso disegnate, come il soffitto e gli arredi, da Gio Ponti

Il «Palinuro» (1947) di Arturo Martini