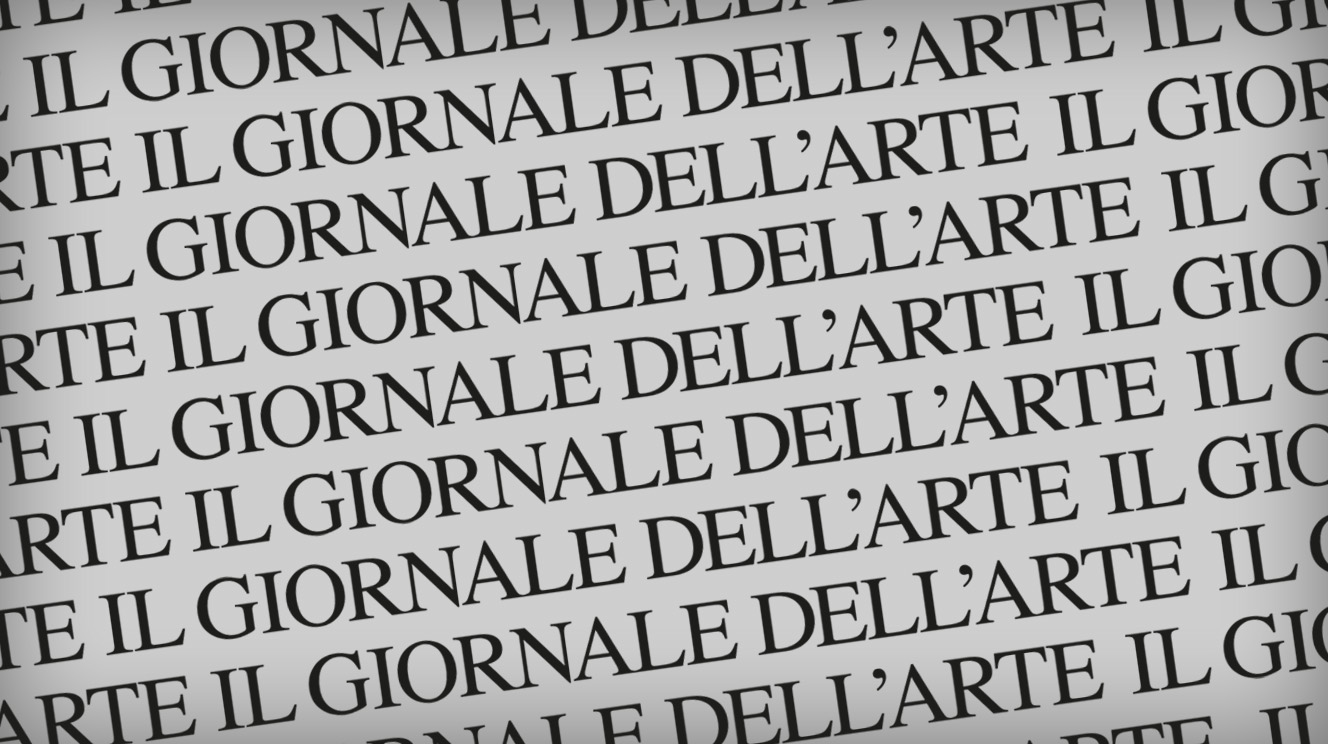Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Redazione GDA
Leggi i suoi articoliLondra. C’era di che eccitare l’immaginazione del pubblico tra il marzo e il luglio del 1815. I drammatici 100 giorni di Napoleone (tra la fine del suo esilio all’Isola d’Elba e la restaurazione della monarchia francese) e l’improvviso capovolgimento e la disfatta della sue armate a Waterloo, il 18 giugno 1815, diventarono anch’essi fonte di ispirazione delle arti per i decenni a venire. Nel decennio successivo a Waterloo, le esposizioni alla Royal Academy of Arts di Londra furono sempre più piene di dipinti con soggetti tratti dalla storia contemporanea che il pubblico si accalcava a vedere. «I pensionati di Chelsea che leggono la gazzetta della battaglia di Waterloo» di David Wilkie, ad esempio, ora al Wellington Museum nella londinese Apsley House, dovette essere protetto dalle folle con una barriera durante la «Summer Exhibition» del 1822. «Il campo di battaglia di Waterloo» (1818) e «La Guerra. L’Esilio e la Rocca Patella» (1842), entrambi alla Tate, sono tra i dipinti storici più evocativi di J.M.W. Turner. Persino l’architettura rispose in stile commemorativo nella Waterloo Chamber nel castello di Windsor, con la grande serie di ritratti dei protagonisti, opera di Thomas Lawrence, e con la Waterloo Gallery per il Duca di Wellington dell’architetto Benjamin Dean Wyatt ad Apsley House, che comprende dipinti di Velázquez e Goya sequestrati a Giuseppe Bonaparte, fratello maggiore di Napoleone. I poeti, in particolare George Byron, e i romanzieri da William Makepeace Thackeray in poi risposero ai drammatici eventi e li inserirono nelle loro trame (come si può dimenticare Becky Sharp al ballo della Duchessa di Richmond nel romanzo La fiera delle vanità di Thackeray del 1847?). Ancora nel XX secolo, le appassionate storie d’amore della scrittrice inglese Georgette Heyer sono ambientate in quegli anni cruciali del secolo precedente di cui descrivono accuratamente tutti i dettagli necessari per appassionare i giovani futuri storici e curatori di costume e di moda. La storia del ritorno delle spoglie belliche francesi, ormai 200 anni fa, è di per sé stessa materia letteraria. Le armate di Napoleone erano state accompagnate ovunque da antiquari e studiosi con la missione di selezionare opere d’arte in ogni Stato sottomesso. Queste ultime vennero spedite in Francia per costituire il Musée Napoleon, come le sempre crescenti collezioni del Louvre vennero chiamate nel 1803. Tra le prede di guerra c’erano la «Madonna con Bambino» di Michelangelo (1501-04), proveniente da Bruges, e l’ampio ritratto equestre di Carlo V di Tiziano (1548 ca), dalle collezioni reali spagnole di Madrid.
In Italia, a causa della molteplicità delle sue Città Stato, Napoleone ebbe inizialmente un diverso approccio. Nel 1797 firmò il Trattato di Tolentino secondo il quale lo Stato Pontificio non avrebbe dovuto essere sottomesso, ma il Vaticano, Roma, Firenze, Venezia, Bologna e Napoli avrebbero dovuto consegnare i loro grandi tesori d’arte: i Cavalli della Basilica di San Marco a Venezia, la Venere Medici da Firenze, l’Apollo del Belvedere del Vaticano e il grande dipinto della «Trasfigurazione» di Raffaello, insieme a molti, molti altri. Alcuni effettivamente «partirono», come il sarcofago egizio di Nectanebo II, già in partenza per la Francia nel porto di Alessandria, e la Stele di Rosetta, che venne scoperta nel bagaglio dello sconfitto generale francese. Questi vennero rimossi nottetempo per paura di scatenare la reazione dei soldati francesi nel porto, e caricati su una fregata britannica immediatamente dopo la Battaglia del Nilo del 1798. Loro nuova destinazione: il British Museum.
Trattati di pace sotto esame
L’importanza per Napoleone di queste acquisizioni è magnificamente dimostrata in un gruppo di medaglie con la classicheggiante testa dell’imperatore di profilo sul recto. Una, regalata a Napoleone nel 1803 dal direttore del Musée Napoleon, Dominique Vivant-Denon, riproduce sul verso la Venere Medici. Altre due vennero consegnate all’imperatore all’inaugurazione delle sale di Apollo e Laocoonte del museo nel dicembre del 1804. I versi, tutti con l’iscrizione «Musée Napoleon», documentano con precisione certosina l’esposizione di antiche sculture.
Il Trattato di Tolentino e il Trattato di Parigi del 1814 vennero messi in discussione nei giorni successivi alla Battaglia di Waterloo. Tolentino, si sostenne, fu imposto in modo coercitivo, e venne reso nullo dall’invasione dello Stato Pontificio da parte delle Armate Rivoluzionarie francesi nel 1799 e dall’esilio e successiva morte di papa Pio VI. Il primo Trattato di Parigi, nel tentativo di restaurare la monarchia borbonica con Luigi XVIII, voleva evitare di ferire l’orgoglio francese, e aveva lasciato intatte le gallerie del Louvre (rinominato Musée Royal), «una delle meraviglie del mondo, e un potente simbolo di orgoglio nazionale». Dopo Waterloo e la seconda resa di Napoleone gli alleati non furono così concilianti. Alla conferenza militare che precedette l’occupazione di Parigi agli inizi di luglio, Wellington, alle prese con l’implacabile atteggiamento tanto dei prussiani quanto dei francesi, escluse fermamente il patrimonio culturale dagli accordi.
Il campo di battaglia di Waterloo era divenuto una destinazione turistica e la gente accorreva a Parigi per ammirare la più grande mostra di opere d’arte europee riunita in solo posto. La città era gremita di visitatori militari, diplomatici e civili da tutta Europa che si godevano l’arte di giorno e i caffè, la musica e la danza la sera. Il miniaturista scozzese Andrew Robertson riferì di avere incontrato i colleghi artisti Thomas Lawrence, William Beechey, Thomas Stothard e Francis Leggatt Chantrey tra la folla del Louvre. Nelle Lettere di Paolo alla sua famiglia, la diretta testimonianza di Walter Scott pubblicata sei mesi dopo Waterloo, lo scrittore scozzese descriveva i fuochi di avvistamento dei britannici accampati sugli Champs-Elysées per la prima volta dal 1436 e si meravigliava della grandeur della Parigi occupata. Scott osservava con acume come «l’attaccamento dei francesi a questi dipinti e statue, o piuttosto alla gloria nazionale che si ritiene illustrino, è eccessiva come se Apollo e Venere fossero ancora oggetto di effettiva adorazione».
In tutto questo si inserì il più grande scultore dell’epoca, Antonio Canova, in una missione diplomatica in rappresentanza della Santa Sede e della città-stato di Roma alla conferenza di pace di Parigi. L’artista recava lettere di papa Pio VII ai sovrani alleati. Al suo arrivo il 28 agosto, la sua prima mossa fu consegnare una lettera a Wilhelm von Humboldt, il ministro di Stato prussiano.
I prussiani erano irremovibili sul fatto che le opere d’arte dovessere essere restituite, e si poteva presumere che avrebbero simpatizzato con la causa italiana. Scrivendo successivamente al cardinale Consalvi, segretario di Stato vaticano, Canova riferì che, fino al suo arrivo, la questione della restituzione non era ancora stata sollevata. Due giorni dopo, Canova spedì una lettera simile al segretario britannico agli Affari esteri, Robert Stewart, Lord Castlereagh, sostenendo la tesi dell’annullamento di Tolentino, e quella secondo cui Roma fosse «luogo d’arte, antichità e storia», e città privilegiata per la formazione per gli artisti. Ciò andava nel senso dell’attaccamento britannico alla cultura italiana creato da generazioni di viaggiatori del Grand Tour, e di quegli artisti, come John Flaxman, che avevano vissuto a Roma. Il giorno precedente, Canova ebbe un colpo di fortuna imbattendosi in William Richard Hamilton, il sottosegretario di Stato nel Ministero di Castlereagh, oltre che attivo partecipante alle trattative diplomatiche del congresso. Hamilton, che aveva sequestrato la Stele di Rosetta ad Alessandria, aveva anche prestato servizio a Costantinopoli sotto Lord Elgin ed era ritornato a Londra con i Marmi del Partenone (la Grecia era allora sotto il dominio ottomano).
I verbali lasciano intendere che sarebbe stato istituito un apposito ufficio a Parigi sotto l’egida di Hamilton per perseguire la causa italiana per via diplomatica. Castlereagh, Wellington e Charles Long, in qualità di finanziatore generale, sembrano avere mostrato simpatia per le richieste degli italiani e di altre Nazioni per la restituzione di ciò che veniva visto come patrimonio nazionale. Essi avrebbero in seguito fornito due convogli, una fregata britannica e 35mila sterline per ridurre i costi di imballaggio e trasporto degli impoveriti Stati italiani.
La svolta diplomatica
La svolta diplomatica giunse quando Luigi XVIII ricevette Canova il 10 settembre, rendendogli l’onore di parlargli in italiano e di commissionargli un ritratto. Il giorno seguente egli fece recapitare un formale comunicato ai rappresentati diplomatici dei sovrani alleati che metteva in discussione la validità del Trattato di Tolentino e chiedeva che le opere sequestrate a seguito del trattato venissero restituite al Popolo di Roma, per «l’utilità e il vantaggio di tutte le nazioni civilizzate d’Europa». Il sostegno di Castelreagh su questo punto fu cruciale. In una serie di domande retoriche mise l’accento sulla necessità per le potenze alleate di rendere giustizia. In tal modo, egli riconobbe l’enorme potere simbolico rivestito da «questi trofei». Il «principio di proprietà», un principio di «virtù, conciliazione e pace», era «la più sicura e unica guida alla giustizia» che avrebbe «riconciliato l’opinione pubblica d’Europa». Le successive sei settimane procedettero lentamente perché prima il papato e successivamente i britannici furono sospettati di siglare un accordo che avrebbe comportato la vendita di antichità dall’uno agli altri. Queste voci vennero messe a tacere da Castlereagh, che dichiarò che il principe reggente avrebbe pagato i costi di restituzione delle opere ai loro «templi e gallerie». Intanto, i russi, sotto Karl Robert Nesselrode, rifiutarono di prendere in considerazione qualsiasi progetto di rimpatrio, mentre singole città italiane, Perugia e Bologna tra le altre, annusando la vittoria, chiesero a Canova di agire per loro conto. Quindi venne l’azione: Wellington, in qualità di comandante in capo dell’armata olandese, annunciò che se il primo ministro francese Charles Maurice de Talleyrand-Périgord e «Monsieur DeNon», riferendosi a Dominique Vivant-Denon, avessero continuato in uno spirito di non collaborazione, egli avrebbe fatto rimuovere dalle truppe i dipinti appartenenti al re d’Olanda, in particolare quelli di Rubens e di grandissime dimensioni, a mezzogiorno del 20 settembre. Ciò che seguì fu ovviamente piuttosto confuso in presenza del risentimento francese e di un conflitto di autorità tra Wellington e il governatore prussiano di Parigi, Friedrich Karl Ferdinand von Müffling. Il Louvre venne inizialmente chiuso e successivamente riaperto con un reggimento britannico dislocato nelle gallerie mentre proseguiva lo smantellamento. L’artista Andrew Robertson riferì del «popolo in collera», e che la rivista di Wellington all’intera armata il 22 settembre fu «una misura molto prudente»; un richiamo al momento opportuno della forza degli alleati. Quando i Cavalli di San Marco furono staccati dall’arco trionfale al Carrousel, tutte le avenue che convergono verso le Tuileries furono sbarrate da dragoni austriaci. Vivant-Denon rassegnò le dimissioni, e Robertson riferì che «il Louvre è veramente triste da vedere adesso, tutte le statue più belle sono andate, e metà delle altre; i locali sono pieni di polvere, funi e verricelli». Il collega artista Thomas Lawrence si lamentò dello «smembramento di una collezione in una collocazione così centrale in Europa, dove tutto era accessibile al pubblico con un grado di liberalità altrove sconosciuto». Non fu il solo: studiosi prussiani avevano suggerito che, invece di restituire le opera ai singoli Stati, si sarebbe dovuto istituire un museo paneuropeo per contenere queste opere contestate, in un luogo centrale e semineutrale, possibilmente Strasburgo.
Sotto Napoleone, le grandi opere d’arte e i musei diventarono simboli di potenza e di gloria nazionale, e ciò non andò perduto né in Francia, né tra i suoi conquistatori. Non è una coincidenza che in una serie di medaglie nazionali commissionate da James Mudie nel 1820, quella che commemora Wellington e l’ingresso dell’armata britannica a Parigi il 7 luglio 1815 mostri la testa del duca in profilo classico sul recto e il colonnato del Louvre sul verso. A maggior riprova della comprensione del potere delle grandi opere d’arte fu l’istituzione di collezioni nazionali aperte al pubblico. In Spagna, il Museo Nacional del Prado di Madrid venne inaugurato da Ferdinando VII nel 1819, e non ci sono dubbi sul fatto che l’istituzione della National Gallery di Londra, in quella che sarebbe diventata Trafalgar Square negli anni 1820, sia stata agevolat dagli eventi del 1815 e dalla visita di Canova a Londra verso la fine di quell’anno. Oltre che, ovviamente, dall’acquisto dei Marmi del Partenone. Ma questa, naturalmente, è un’altra storia.
Altri articoli dell'autore
L’Associazione archeologi del Pubblico Impiego (Api-MiBact) ha inviato una nota al Ministero della Cultura e a quello della Funzione Pubblica, nonché ai membri delle Commissioni cultura di Camera e Senato, per esprimere il proprio dissenso per il bando per 75 posti nell’area dell’elevate professionalità (Ep), le cui domande di partecipazione vanno presentate entro il 26 giugno
Il premio Nobel e il direttore del Museo Egizio si sono incontrati per parlare di musei e romanzi: «Sono simili: sono i “luoghi” in cui avviene l’interpretazione del significato della nostra vita, nei quali riflettere su sé stessi»
Anche quest’anno Tag Art Night, la Notte delle Arti Contemporanee, propone un palinsesto di mostre diffuse sul territorio cittadino
Rimodulate le competenze e modificato la struttura organizzativa: dal Segretariato generale al modello dipartimentale