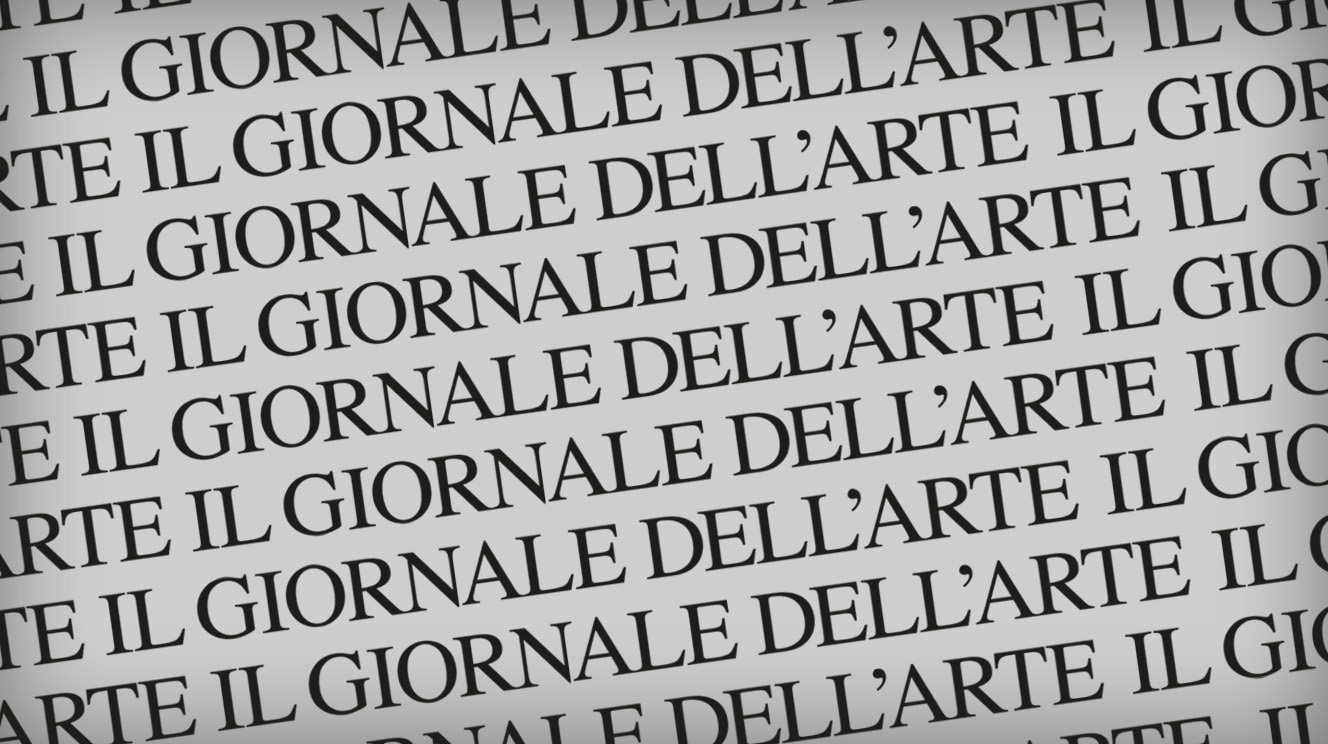Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Redazione GDA
Leggi i suoi articoliAbbiamo chiesto a Carlo Lippolis di raccontare la vita quotidiana di un archeologo a Kut sul fiume Tigri
Il 3 ottobre è il giorno della partenza da Torino. Ci ritorneremo dopo un mese. La destinazione è prima Baghdad e poi Kut, entrambe sul Tigri ma profondamente diverse. Commovente Baghdad con i suoi vecchi caffè (o meglio «chaihane», locali per il tè e il narghilè) e i suoi mercati sfregiati dalle guerre, sonnacchiosa e bruttina la Kut che fu teatro di due celebri battaglie tra ottomani e inglesi nel 1915-16 e tra americani e iracheni nel 2003.
A Baghdad dobbiamo ultimare l’organizzazione della missione archeologica programmata per questo autunno, a Kut ci fermeremo per un mese circa con l’intento di riprendere le ricerche in un sito nelle sue vicinanze, cominciate nel 2013 e poi interrotte temporaneamente per l’avanzata e la minaccia del Daesh (o Isis se vogliamo dirlo all’occidentale).
Escluse alcune sacche ancora instabili, a sud di Baghdad l’Iraq scita è oggi un Paese relativamente tranquillo, per quanto Kut si trovi in una zona ancora troppo distante da quelle regioni del Golfo che sono più al sicuro dalle minacce estremiste dei pirati del Califfato. Qui, di fatto, siamo a meno di 200 km in linea d’aria da loro. E attentati o atti di violenza a volte capitano ancora.
Dal 2000 a oggi sono stato in Iraq decine di volte, per progetti di ricerca, catalogazione, scavo e per il riallestimento del Museo di Baghdad, la riorganizzazione degli Istituti italo-iracheni di archeologia e conservazione (che presto riapriranno); progetti che il Centro Scavi di Torino oramai da oltre cinquant’anni intraprende in quella che è la culla della civiltà. Senza retorica e banalità: la ricchezza del patrimonio archeologico di questo Paese, oggi devastato dalla barbarie e dall’indifferenza (ma anche dall’occidentale appetito per le antichità trafugate), è immensa.
Ho vissuto l’Iraq dell’embargo, quello della preparazione alla guerra, quello della seconda guerra del Golfo (ho condiviso una caravan con un marine americano per dieci giorni), quello della speranza del postconflitto e quello del precipizio nel conflitto sunniti-sciti prima e Califfato poi. Non posso nascondere che ogni volta che mi reco in questo Paese c’è timore. Non posso nascondere che ogni volta che mi reco in Iraq c’è, però, anche entusiasmo e amore per un popolo lacerato da quarant’anni di guerre.
Le colline delle mucche
Quest’anno sono con me Angelo ed Eleonora, archeologo e dottoranda rispettivamente, che mi aiuteranno nel lavoro di ricognizione sul terreno e nello scavo. La missione italiana del Centro Scavi Torino, cofinanziata dal nostro Ministero degli Affari esteri (Maeci), ha come obiettivo la ripresa delle attività in un’area archeologica poco a sud di Kut il cui nome è Tulul al Baqarat: la poco poetica, seppure bucolica, traduzione italiana è «le colline delle mucche» (dove Tulul, plurale di tell, indica quei bassi rilievi artificiali formatisi dall’accumulo e dal dilavamento, ovvero le caratteristiche collinette del mondo vicino orientale che nascondono antichi insediamenti e città).A dispetto del nome, però, gli scavi qui condotti dagli archeologi iracheni tra 2008 e 2010 hanno rivelato la presenza di un importante tempio di epoca neobabilonese (VI secolo a.C.), costruito o meglio ri-costruito da Nabucodonosor e Nabonide. Le informazioni al riguardo sono ancora parziali, in quanto i lavori iracheni sono terminati e nulla è stato pubblicato. Da quanto ho potuto constatare sul terreno, è assai verosimile che il tempio riportato alla luce dagli iracheni si imposti, secondo una tradizione tipicamente mesopotamica, sui resti di più antichi edifici sacri, le cui fasi cronologiche potrebbero risalire fino al III millennio a.C.
Lo dimostrano, del resto, anche alcuni pregevoli manufatti emersi dagli scavi iracheni che ho potuto vedere in foto. Oltre a questo complesso, però, che sorge alto sulla collina centrale dell’area archeologica, il territorio presenta molti altri settori di estremo interesse. Le nostre indagini, condotte nel 2013 e quest’anno, sono state in grado di identificare con una certa precisione aree di insediamento databili su di un arco di tempo che va dal IV millennio a.C. almeno fino all’epoca islamica. Una continuità di fasi culturali eccezionale: ognuna delle grandi fasi storiche della Mesopotamia sembra qui presente.
Scavatori clandestini
Questi i motivi che ci hanno attratto a Baqarat, assieme alla preoccupazione di scavi clandestini che hanno in passato parzialmente devastato il sito e che, ahimè, a oggi non sono ancora stati fermati del tutto. Per essere precisi, parevano essersi fermati un paio di anni fa, ma l’effetto delle distruzioni perpetrate dal Daesh in altre zone dell’Iraq ha purtroppo avuto un rimbalzo negativo anche tra coloro che sono nemici dichiarati del Califfato.Temo che l’indifferenza per la salvaguardia del proprio passato e la considerazione delle antichità in chiave esclusivamente economica (oggetti da rivendere) si stia insinuando nelle viscere di quelle parti più povere della popolazione che si sentono ora nuovamente legittimate a scovare piccoli tesori per rivenderli sul mercato (dietro al quale, lo ripeto, ci siamo anche noi occidentali).
Le forze di polizia locale, costantemente impegnate al fronte contro il Daesh e nell’interno per garantire la sicurezza dei loro concittadini, non possono pattugliare capillarmente i siti e la piaga dello scavo clandestino (questa volta non più perpetrato da bande organizzate venute anche da fuori, ma dagli stessi contadini che abitano presso i siti) può continuare quasi indisturbata.
Talora la presenza continuativa di équipe di archeologi, locali o stranieri, può servire ad arginare il problema. Apparentemente potrebbe sembrare il contrario (dove scavano gli archeologi è ovvio che sotto c’è qualcosa...) e sicuramente non si tratta di un’impresa semplice e rapida. Tuttavia, bisogna considerare che la paga che un operaio prende per due-tre mesi di lavoro durante una missione archeologica vale più di quanto lui possa ricavare scavando centinaia di buche clandestine. I reperti archeologici rinvenuti da questi maldestri scavatori vengono infatti quasi sempre rivenduti a mediatori per pochi dollari ciascuno (è solo dopo vari passaggi che essi acquisiscono il valore di mercato). Inoltre, lo scavo di una buca nel terreno, seppure in siti ricchi di materiali come quelli mesopotamici, non sempre restituisce qualcosa di rivendibile.
Infine, la presenza di una missione implica un controllo e un monitoraggio costanti da parte degli archeologi, della polizia locale e un diretto coinvolgimento di persone locali che vengono assunte all’uopo come «guardie del sito». Non è un sistema infallibile, ma al momento è quanto di meglio possiamo fare.
Archeologi e operai
Ma torniamo brevemente ai nostri lavori sul terreno. Per quest’anno saremo ancora alloggiati in un piccolo albergo di Kut, modesto ed economico ma con acqua corrente e luce. Al momento è la sistemazione migliore e la più sicura, ma per missioni operative più lunghe, come prevediamo di fare per il futuro, un hotel non è adatto, sia per i costi elevati sia per mancanza di spazi adeguati per il lavoro sui materiali dallo scavo.La costruzione di una casa della missione sul sito sembra l’unica soluzione e probabilmente dovremo costruirla nei prossimi anni, con non pochi sacrifici visti i fondi limitati di cui disponiamo. Potrei vantarmi del fatto che costruiremo una casa ecosostenibile ed ecocompatibile, ma preferisco ammettere che sarà un modesto edificio in argilla cruda seccata con il tetto di legni di palma, stuoie e fango. Niente di più tradizionale, economico e soprattutto fresco (l’argilla è un ottimo isolante) per un posto in cui ancora a inizio ottobre si registravano 46 gradi. Ci si sveglia infatti alle 5, per sfruttare le ore meno torride e ci si reca sul sito dopo aver acquistato casse d’acqua e frutta per la pausa di metà mattinata.
Lungo la strada, tappa obbligata diventa presto un omino che, spuntato dal nulla, scopriamo vendere blocchi di ghiaccio (dove lo prende?). Un preziosissimo conforto che si affianca presto all’acquisto di una borsa frigo per conservare l’acqua a temperature accettabili.
Tra operai e archeologi (italiani e iracheni) siamo in 13, più i 4 ragazzi della polizia archeologica che quest’anno ci scortano in abiti civili, per mantenere un profilo basso e passare il più possibile inosservati. Sono anche loro appassionati di antichità e sentono forte il dovere di proteggere, in una lotta impari, il loro patrimonio storico. Sono ragazzi giovani con i quali, in poco tempo, si instaura un bel rapporto. Condividono da subito il cibo che le loro mogli preparano per la pausa e assistono curiosi alle operazioni di scavo. Ogni tanto si assentano, sentiamo sparare e li vediamo tornare con un bottino di caccia (poveri uccellini che di carne ne hanno ben poca). Meglio così, vuol dire che sono rilassati.
Le operazioni di scavo consistono nella ricognizione (survey) di un’area archeologica di 7-8 ettari e databile al IV millennio a.C. sulla base della ceramica che si ritrova sparsa ovunque sulla superficie (questa viene raccolta sistematicamente, schedata e disegnata). Si aprono anche tre piccoli sondaggi che riportano alla luce lacerti di strutture antiche, verosimilmente di epoca Uruk (la cultura che portò alla nascita della città e dello Stato, nel IV millennio) ma tagliate da livelli più tardi di epoca neobabilonese (I millennio a.C.). Quest’ultima è attestata dalla presenza di frammenti di mattone con stampi regali, verosimilmente da attribuire a Nabucodonosor e/o al successore Nabonide. Le iscrizioni sono oramai poco leggibili, ma si distingue ancora la titolatura «re di Babilonia».
Le operazioni di scavo sono un processo molto complesso che richiede tempi lunghi prima di acquisire dati certi, ma dopo le prime due ricognizioni effettuate, e grazie anche ai precedenti scavi iracheni, possediamo oggi un quadro attendibile dell’intera area in questione. Sicuramente si tratta di un importante centro religioso, il cui complesso sacro venne più volte ricostruito da alcuni dei più importanti sovrani mesopotamici tra il III e il I millennio a.C. Oltre al tempio dovrebbero sussistere, da qualche parte ancora da individuare, i resti di un palazzo. L’area è dunque luogo di un insediamento antichissimo che probabilmente continuò a esistere fino alle epoche più recenti (sasanide prima e islamica poi), forse migrando di volta in volta in relazione al mutato corso dei principali canali d’irrigazione. Baqarat è un sito che può aiutare a ricomporre un importante tassello della storia dell’umanità e che, considerata la presenza di bolli e iscrizioni reali, potrebbe restituire materiali di straordinaria importanza storico-artistica per gli archeologi.
In risposta alla distruzione e all’oblio che qualcuno sta cercando di imporre, cerchiamo di riportare luce sulla storia del passato di un’unica umanità. Mai come oggi, vale la pena di lottare.
Altri articoli dell'autore
L’Associazione archeologi del Pubblico Impiego (Api-MiBact) ha inviato una nota al Ministero della Cultura e a quello della Funzione Pubblica, nonché ai membri delle Commissioni cultura di Camera e Senato, per esprimere il proprio dissenso per il bando per 75 posti nell’area dell’elevate professionalità (Ep), le cui domande di partecipazione vanno presentate entro il 26 giugno
Il premio Nobel e il direttore del Museo Egizio si sono incontrati per parlare di musei e romanzi: «Sono simili: sono i “luoghi” in cui avviene l’interpretazione del significato della nostra vita, nei quali riflettere su sé stessi»
Anche quest’anno Tag Art Night, la Notte delle Arti Contemporanee, propone un palinsesto di mostre diffuse sul territorio cittadino
Rimodulate le competenze e modificato la struttura organizzativa: dal Segretariato generale al modello dipartimentale