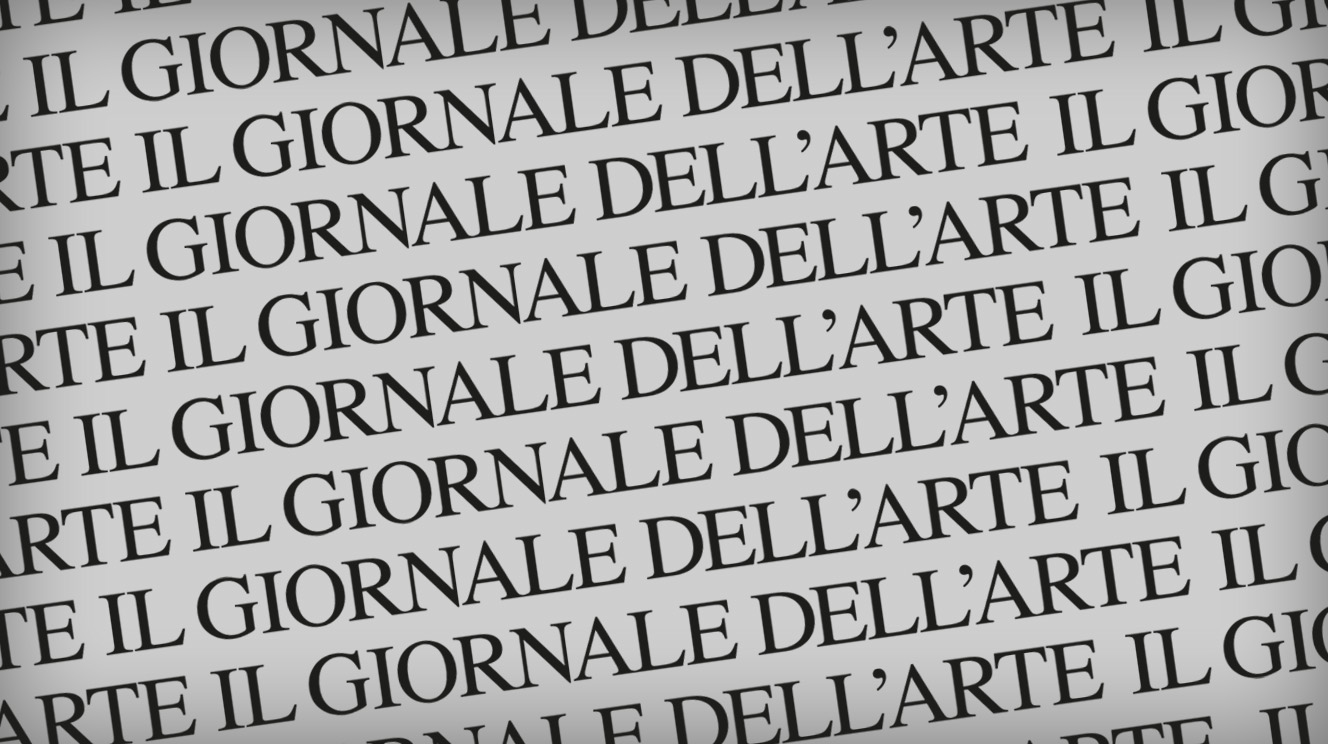Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Redazione GDA
Leggi i suoi articoliBiella è spesso ricordata come capoluogo laniero (le cui gloriose memorie passate poco leniscono la drammatica regressione economica presente). Tuttavia, alla città, adagiata ai piedi dello straordinario anfiteatro montuoso rappresentato dall’omonima catena alpina, molto deve anche la storia dell’alpinismo. Al territorio biellese è infatti legata la biografia dei Sella, dinastia familiare d’imprenditori lanieri, poi banchieri, grandi appassionati di montagna e di fotografia. Quintino (1827-84), ingegnere idraulico e minerario nonché per tre volte ministro delle Finanze del Regno d’Italia tra il 1862 e il 1873, è l’anima della costituzione del Club Alpino Italiano, il 23 ottobre 1863 di ritorno dalla prima salita tutta italiana al Monviso. Al fratello Giuseppe Venanzio (1823-76) si deve il Plico del fotografo, primo manuale di fotografia in lingua italiana uscito nel 1856. Ma è sulla scia di un altro biellese, Vittorio Besso (1828-95), fotografo specializzato di architettura e tra i primi in Italia a dedicarsi alla fotografia di montagna, che si forma Vittorio Sella (1859-1943), figlio di Venanzio, il quale nel suo prolifico impegno documentaristico e nell’attività alpinistica consacrerà una vera e propria scuola biellese che assurge a rilevanza internazionale.
Dal 1980 la Fondazione Sella onlus, con sede nell’ex lanificio Maurizio Sella, si occupa di conservare l’archivio, composto da oltre 14mila negativi originali, in lastre e pellicole, e dalle relative stampe, insieme ai suoi documenti personali, lettere e diari. Ora, per mano della direttrice Angelica Sella, è uscito un volume (Vittorio Sella. Mountain Photographs 1879-1909, Idea Books, 264 pp., € 59) che raccoglie una selezione di quasi 200 scatti da vari viaggi tra Alpi, Caucaso, Alaska, Sikkim, Ruwenzori (Africa) e Karakorum: non solo ambienti montani estremi ma anche natura selvaggia a bassa quota e straordinari soggetti etnografici. Incontriamo Lodovico Sella, classe 1929, pronipote di Vittorio, presidente della Fondazione di famiglia.
Come opera la Fondazione al fine di valorizzare il patrimonio fotografico di Vittorio Sella?
La Fondazione è occupata su molti fronti: essa conserva anche memorie di persone, istituzioni, enti e industrie locali. Certo, il patrimonio fotografico (non solo di famiglia; ad esempio, conserviamo l’archivio dello studio Rossetti: 100 anni di fotografia su commissione) è il corpus principale, perché la fotografia nella storia del XX secolo gioca un ruolo fondamentale.
Di Vittorio conserviamo anche il laboratorio fotografico, le sue attrezzature. Ovviamente, la nostra azione intende spingersi oltre la mera conservazione. Puntiamo soprattutto a comprendere la figura di Vittorio nel suo insieme: infatti, ricordandolo come documentarista (per la scienza, soprattutto), si è spesso dimenticato il suo impegno complessivo. Lui da giovane fu pittore, e considerava la singola immagine come un’opera d’arte: teneva insieme l’aspetto strutturale della composizione scenica dell’immagine, semplificando la complessa tettonica alpina, senza tuttavia tralasciare l’aspetto documentaristico a fini geologici e alpinistici. Purtroppo in Italia la fotografia di paesaggio è poco considerata.
Vittorio, pur partendo da un’altra cultura e formazione, ha seguito la via dei primi fotografi americani che si cimentano coi grandi paesaggi. Egli ci tiene a umanizzare il documento con la presenza delle persone, che restituiscono l’aspetto emotivo, nonché la scala dimensionale dell’ambiente maestoso. Egli ha così dato vita a un complesso di documentazione e di arte la cui efficacia non dipende certo dal caso, bensì dalla sua forte determinazione. Pur non provenendo da studi umanistici, dopo aver abbandonato il suo lavoro in tintoria, verso la fine della sua vita è diventato un umanista, un «philosophe»: attraverso i suoi viaggi, le frequentazioni con le persone che gli derivavano dall’esperienza di montagna. Vittorio adotta anche tecniche sottilissime: la sua ricerca di realismo gli permette di tollerare, anzi di auspicare le naturali posture o i piccoli movimenti delle persone. Egli sosteneva che «la fotografia deve ritrarre solamente la severa realtà».
Nessuna maschera, quindi; bensì il tentativo di cavare il bello dal vero: cosa non così facile. Ed era molto sicuro di sé: ad esempio, durante la salita della Regina Margherita al rifugio-osservatorio che porterà il suo nome, sulla Punta Gnifetti del Monte Rosa (4.559 m), egli esegue solo 5 scatti in tutto, con un’unica foto di rito in vetta, in cui la regina è leggermente sfuocata perché sta muovendo un po’ la testa.
Non pensa che il patrimonio di Vittorio Sella possa diventare il nucleo di un centro internazionale dedicato alla fotografia di montagna che vede Biella come sede naturale?
È vero, la questione mi punge nel vivo, tanto più che possediamo materiali di grande qualità, appartenenti anche a fotografi francesi. Tuttavia abbiamo troppa carne al fuoco. Riceviamo molte richieste anche a seguito del 150mo anno di fondazione del Cai. Cercando di assecondare le iniziative altrui, non riusciamo a organizzarne di nostre. Però il volume appena uscito intende mostrare l’impegno a tutto campo di Vittorio, andando oltre gli straordinari paesaggi alpini: è una sorta di zibaldone, di antologia del suo lavoro. Certo, il problema è anche che, da buoni biellesi, siamo spesso un po’ troppo gelosi delle nostre cose...
Che cosa vi ha tramesso, a livello di passione per la montagna, l’eredità alpinistica di famiglia?
Sia la conoscenza delle tecniche, sia l’abitudine a salire le montagne con qualunque tempo e con i propri mezzi. Non siamo mai assurti a livelli di alpinismo specializzato; ad esempio, abbiamo sempre vissuto lo scialpinismo come mezzo per andare in montagna e non come performance sportiva fine a se stessa. Quanto al rapporto col Biellese, ci tengo a dire che ci troviamo in una terra di grande spiritualità. Mia moglie, che è della bassa vercellese, dice che è stufa di questi biellesi che lavorano solo e sempre e poi... vanno in montagna, invece di occuparsi di tante altre belle cose, come ad esempio d’arte. Tuttavia, il poter salire anche solo su una delle nostre vette circostanti e da lì vedersi dischiudere il vasto panorama sul Monte Rosa, è meraviglioso.
Altri articoli dell'autore
L’Associazione archeologi del Pubblico Impiego (Api-MiBact) ha inviato una nota al Ministero della Cultura e a quello della Funzione Pubblica, nonché ai membri delle Commissioni cultura di Camera e Senato, per esprimere il proprio dissenso per il bando per 75 posti nell’area dell’elevate professionalità (Ep), le cui domande di partecipazione vanno presentate entro il 26 giugno
Il premio Nobel e il direttore del Museo Egizio si sono incontrati per parlare di musei e romanzi: «Sono simili: sono i “luoghi” in cui avviene l’interpretazione del significato della nostra vita, nei quali riflettere su sé stessi»
Anche quest’anno Tag Art Night, la Notte delle Arti Contemporanee, propone un palinsesto di mostre diffuse sul territorio cittadino
Rimodulate le competenze e modificato la struttura organizzativa: dal Segretariato generale al modello dipartimentale