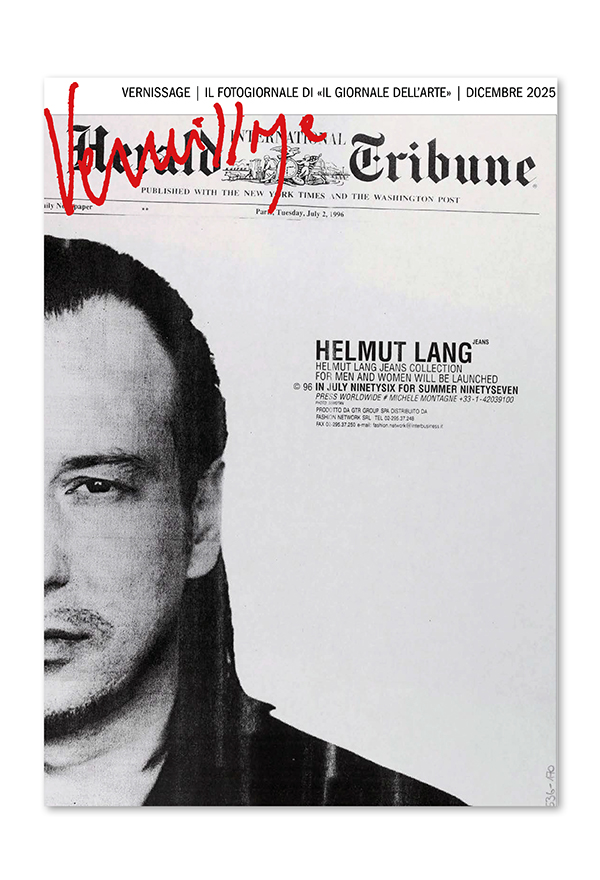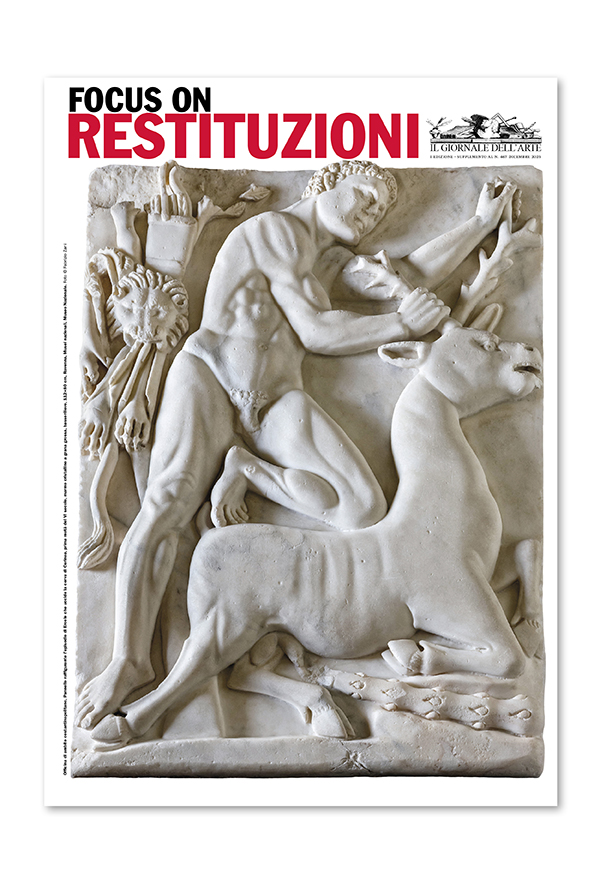Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Angela Vettese
Leggi i suoi articoliCon i suoi 127 anni di vita, persino mentre l’atmosfera fisica e metaforica è attraversata da missili, la Biennale di Venezia si ritrova a essere ancora una piattaforma di diplomazia culturale, un luogo in cui popolazioni in lotta riconoscono reciprocamente il valore delle loro culture. Si fa «politica con altri mezzi», come ha notato la storica Caroline Jones, ma si fa anche un’altra politica: quella che riconosce nelle arti un terreno di scambio che resta fertile anche in guerra.
Per anni si è ritenuto che la presenza in essa dei Padiglioni Nazionali, nonché di un chiaro protagonismo dell’Occidente, ne facessero un’istituzione arretrata e attestata su di una geopolitica ottocentesca oramai inefficace. Si è pensato lungamente che la mossa che l’ha riportata in auge sia stata la riforma del 1998, che l’ha resa più agile nell’attirare sponsor e che, grazie alla presidenza di Paolo Baratta, ha rafforzato la mostra internazionale centrale, affidandola a curatori indipendenti e non più a intellettuali italiani con affiliazioni politiche.
Ora dovremmo chiederci, però, se non sia stata anche la dilatazione dei padiglioni nazionali a fare la nuova fortuna della Biennale, e questo per due motivi solo apparentemente opposti: da una parte, dal 1948 ma con crescente intensità negli anni Duemila, i padiglioni sono aumentati di numero e di provenienze geografiche. Questo è stato un frutto della globalizzazione e di una diffusione mondiale di un’idea di arte dalle radici occidentali, ma che è andata ibridandosi con le tradizioni locali; un aspetto che alla Biennale è arrivato dopo mostre come «Magiciens de la Terre» (Parigi 1989) o le Documenta di Kassel del 1992, 1997 e 2001.
D’altro canto, la globalizzazione non è avvenuta senza un contributo delle nazioni medesime, adattatesi a dialoghi fluidi quali quelli richiesti dalle tecnologie senza frontiere (o quasi) e da un commercio che tende a disconoscere le bandiere. In effetti, i recenti conflitti nel mondo portano a riconoscere che le nazioni sono ancora entità significative, con aspetti identitari che non dovrebbero essere sottovalutati.
L’avventura della Biennale, del resto, è nata nel segno della politica, intesa come posizionamento nel mondo di un’Italia unitaria appena nata. Malgrado non esista ancora un volume con una storia affidabile della manifestazione, da almeno quindici anni gli studi stanno ricostruendo la sua genesi e il suo sviluppo. E anche questo è significativo: si sente l’urgenza di capire come una manifestazione di apparente intrattenimento abbia potuto durare tanto a lungo. Qualche cosa l’ha resa necessaria e, senza dubbio, rimane l’unica struttura italiana dedicata alle arti contemporanee che abbia una credibilità indiscussa.
Nata dal sindaco Riccardo Selvatico e da un gruppo di amici tra cui Antonio Fradeletto e Giovanni Bordiga, la mostra nacque insieme a molte altre concepite dal Regno d’Italia per farne rivivere i centri urbani, bellissimi ma assopiti; dopo una sorta di prova generale negli anni Ottanta dell’Ottocento, la manifestazione veneziana si riformulò non come un momento di divertimento, ma come una manifestazione periodica dedicata all’arte visiva internazionale: l’obiettivo era portare un pubblico popolare, ma anche il novero degli specialisti, sulla scorta degli Expo internazionali e dei Salon parigini, con un cocktail ricostruito dallo studioso Bruce Altshuler (From Salon to Bennials, Phaidon 2011).
La prima edizione, tenutasi nel 1895 nel padiglione costruito ai Giardini di Castello che è tutt’ora il suo centro, non fu eccezionale per i contenuti, ma ebbe un’ottima campagna d’informazione. Inaugurata dalla coppia reale e dall’alta società europea, la mostra fu caratterizzata anche dal primo scandalo: il quadro di Giacomo Grosso intitolato «Il supremo convegno», in cui il cadavere di Don Giovanni nella bara eccita uno stuolo di donne discinte e necrofile: destò una tale attenzione da suscitare file tra i visitatori e da essere poi letteralmente condotto in tournée per il mondo. Affogò con la nave che lo trasportava e non ne abbiamo che qualche fotografia.
Dal 1907 iniziarono a nascere i piccoli edifici dedicati ai singoli Stati, a partire da quello del Belgio: le costruzioni strutturarono anche i Giardini, che videro nascere viali e percorsi monumentali dove prima giocavano i bambini. Il suolo era comunale, ma la gestione e la manutenzione era e resta appaltata ai singoli Stati, così che il budget messo a disposizione dallo Stato italiano (mai alto) viene esteso in modo non calcolabile da tutti i Paesi partecipanti. I nuovi edifici rispettavano i rapporti tra le Nazioni e, naturalmente, i Paesi più forti come la Francia, la Germania, l’Inghilterra e gli Stati Uniti non mancarono di costruire tempietti dotati di colonne e timpani, spesso rivisitati nello stile prima di giungere alla forma che vediamo oggi.
L’importanza che venne data a queste piccole ambasciate si riflesse nei nomi di alcuni architetti, come Josef Hoffmann (Austria), Alvar Aalto (Finlandia), Sverre Fehn (Paesi Nordici), Carlo Scarpa (Venezuela) e altri, che rivediamo in un bel volume fotografico di Gabriele Basilico (Contrasto, Roma 2013). Ci sono stati momenti in cui questa pressante presenza delle nazioni ha costituito un vero limite, come nell’edizione del 1942: per riempire i padiglioni, lasciati vuoti dalle rappresentanze dei Paesi schierati in Guerra contro l’Italia fascista, li si riempì con le rappresentanze dei corpi d’armata. La manifestazione poi chiuse i battenti fino al 1948, pronta per mostrare al mondo la nuova supremazia dell’arte americana: Peggy Guggenheim si incaricò di portare un’ampia rappresentanza delle nuove correnti statunitensi presso lo spazio vacante del Padiglione greco.
La struttura multicellulare della Biennale, come l’ha definita il critico Lawrence Alloway, ha permesso queste incursioni di novità, iniezioni di esperimenti che forse non sarebbero state possibili in una mostra monolitica. Per esempio, nonostante il tentativo continuo di «occidentalizzare l’altro» (Beat Wiss), è stato possibile vedere spazi dati a nazioni senza Stato come la Palestina, oppure a Stati senza un’autonomia, come la Catalogna, il Galles, la Scozia e l’Africa post-coloniale sparpagliata in nazioni diverse; Stati giovani come la Lituania o culture diasporiche come quella Armena hanno potuto avere riconoscimenti importanti. Così la Biennale rimane un luogo della conservazione e spesso della celebrazione di Stati di fatto molto ufficiali, ma anche un posto adatto a dimostrare l’emergere di problemi nuovi. E non solamente in termini geopolitici.
Anno dopo anno la Biennale ha ospitato dibattiti molto attuali, quasi a sancire e talvolta anticipare alcune delle tendenze maggiori non soltanto dell’arte ma anche del comportamento e del pensiero. È vero che la mostra nacque poco propensa a mostrare le novità francesi, fissa com’era sull’asse Austria-Germania: Picasso venne esibito solo nel 1948 e cosa fosse il Futurismo lo si seppe soltanto perché era un movimento italiano e per di più filofascista. Ma il Dadaismo, il Surrealismo, l’Astrattismo impiegarono molto a venire accettati, complice anche l’ostracismo che alcuni artisti e critici italiani, implicati nei comitati di selezione, non esitavano a esercitare su tendenze che l’Italia non coltivava. Al tempo in cui si scambiavano lettere Roberto Longhi, Rodolfo Pallucchini e spesso anche Giorgio Morandi, le scelte erano prudenti e il Padiglione Centrale era quasi tutto dedicato a pittori italiani. E sarà bene ricordare che non era nato così: la scritta ITALIA a caratteri maiuscoli era stata una scelta mussoliniana; giustamente ora sovrasta l’ingresso il più discreto minuscolo de «la biennale» (e il Padiglione italiano ha un’enormità di metri quadri all’Arsenale).
Però con la fine della seconda guerra mondiale il tradizionalismo si è stemperato, mentre le revisioni della facciata del Padiglione Centrale rendevano conto anche in termini fisici di un travaglio interiore. Il quale agì su molti piani, arrivando alla contestazione del 1968, quando molti artisti si rifiutarono di aprire le loro sale e la polizia ne trattò alcuni come ribelli, e fin agli anni Settanta, quando il presidente Carlo Ripa di Meana cercò di riformarne lo statuto.
Questo travaglio non impedì alcuni momenti salienti. Fu qui che, nel 1964, vennero laureati al contempo sia il consumismo come stile di vita sia le prime tendenze critiche, con un premio assegnato tra mille polemiche a Robert Rauschenberg. Nel 1972 la manifestazione fu aperta dalla liberazione di milioni di insetti in piazza san Marco, indice dell’attenzione alla performance e al tema dell’opera effimera, spesso alleata della natura, venata da temi ecologisti. Nel 1976 una sezione dedicata al rapporto tra Arte e Ambiente, a cura di Germano Celant, mostrò la continuità con cui da Kandinskij a Mario Merz, da Lazlo Moholy-Nagy a James Turrell, la pittura si era dilatata negli ambienti non per diventare decorazione d’interni ma per riprendere quella tridimensionalità che aveva avuto al tempo dei grandi cicli di affreschi.
Nel 1980 Paolo Portoghesi presentò il pensiero postmoderno alle Corderie dell’Arsenale, inaugurate come spazio espositivo per la sua «Strada Novissima» nella prima edizione della Biennale Architettura: la serie di facciate di ogni stile che occupò il colonnato di archeologia industriale mostrò una libertà stilistica e filosofica che tagliava la testa al concetto di avanguardia, all’era delle grandi narrazioni ideologiche e al rispetto della cronologia storica; nello stesso anno Harald Szeemann e Achille Bonito Oliva inventarono quella sezione Aperto che, dedicata alle nuove tendenze, diede spazio al concetto di nuove proposte, nata con l’importanza data alla categoria dei giovani, che circolava da tempo nella società oltre che nell’arte. Nel 1993, con l’ultima edizione di Aperto curata da Helena Kontova, si mise l’accento su una corporeità disposta a farsi organismo bio-cibernetico.
La mostra centrale è andata testimoniando, nel frattempo, gli sviluppi dell’idea di curatela: nel 1993 Achille Bonito Oliva decise di spargere la manifestazione in giro per tutta la città, scaraventandola fuori dal suo recinto diventato ormai asfittico e condividendo con un centinaio di altri curatori la sua prerogativa di autore. Nel 1999 Harald Szeemann usò una grande parte dell’Arsenale, che il Comune incominciò a destinare alla Biennale in pianta stabile, generando un allestimento che sembrava il montaggio di un film: sala dopo sala l’atmosfera cambiava, il racconto piegava verso direzioni emotive diverse e ci si ritrovava a navigare tra Cina, Cuba, Americhe diverse e un’Europa sempre più marginale.
Nel 2003 Francesco Bonami ha condiviso di nuovo la curatela con altri, incluso un artista come Rirkrit Tiravanija che ha declinato la sua poetica della partecipazione in una «Stazione Utopia» piena di tavoli rotondi, concepiti con Hans-Ulrich Obrist e Molly Nesbitt, dove intervennero Yoko Ono, Bruno Latour e altri cento tra artisti e intellettuali. Riprendendo un simile filo, nel 2015 Okwui Enwezor volle creare un’arena al centro del Padiglione Centrale, uno spazio rosso che era al contempo piazza e teatro, dove ogni giorno avevano luogo letture del Capitale di Marx, performance, proiezioni di film ed eventi che completavano la parte rigida della mostra, allestita in maniera tradizionale.
È vero che molte di queste novità erano già state sperimentate altrove: la gemmazione delle mostre d’arte contemporanea nel secondo Novecento è stata costante ed esponenziale, con la nascita di organismi più agili, sperimentali e talvolta itineranti, come «Manifesta», oppure concepiti per gli spazi esterni come «Project Sculptur» a Muenster. In termini di pubblico Venezia non ha i numeri delle mostre di Kassel o di Sydney, che viaggiano intorno al milione di visitatori, e quanto alla produzione di opere in situ paga un bel dazio sia alla difficoltà di agire sul suolo cittadino, iperprotetto dalla Soprintendenza, sia ai costi dei trasporti e del lavoro, sia infine alla difficoltà di conservare appropriatamente delle opere fragili in un contesto così umido.
Non per nulla, i molti tentativi di trasformare i Giardini in un museo dall’attività permanente, non chiuso alla città ma nuovamente godibile per la cittadinanza, sono falliti: si dovrebbe costruire un’architettura a prova di salsedine e si dovrebbero organizzare misure di sorveglianza che il bilancio della città non può permettersi. Resta il rammarico di una certa estraneità tra la popolazione cittadina e la mostra, amata perché porta denaro e il cosiddetto turismo di qualità, ma detestata per il suo carattere chiuso. A poco sono valse operazioni di sconfinamento e coinvolgimento, come quelle compiute dagi artist Fluxus nel 1990 o da Dora Garcia, quando nel 2011 ebbe un Padiglione spagnolo che trasformò in una base per attività cittadine.
Tuttavia non si capirebbe come quasi nessun curatore abbia rinunciato all’incarico di guidare la Biennale veneziana se questa non fosse un centro propulsore. A farla grande è stata anche l’intuizione di trasformarla nell’unica istituzione interdisciplinare al mondo, con i suoi rami dedicati al cinema, all’architettura, al teatro, alla danza e alla musica, nonché la sua capacità di dare una nuova lettura del rapporto tra heritage e contemporaneità: nel suo dilatarsi è riuscita a giungere a prendersi cura dei palazzi storici a cui paga affitti notevoli e di una visione diversa della città, conducendo il visitatore al di fuori del tubo turistico che porta dalla stazione a Rialto e a San Marco.
Inoltre, ha saputo determinare un effetto di trascinamento per il quale, data la sua presenza e il ridefinirsi di Venezia come centro per le arti contemporanee, sono nate una serie di istituzioni permanenti che fanno parte integrante della geografia cittadina; la prima a nascere fu l’Opera Bevilacqua La Masa a Ca’ Pesaro, ma se esiste una Collezione Peggy Guggenheim a Dorsoduro, se a San Samuele si incontra Palazzo Grassi che è stato della Fiat prima che di François Pianult, se la splendida biblioteca Querini Stampalia ha un programma di mostre d’arte contemporanea, se la Fondazione Prada ha restaurato e occupato un palazzo a San Stae, se sono fioriti centri non profit come lo Spazio Punch alla Giudecca o il S.a.l.e Docks agli Incurabili, è perché esiste quella locomotiva.
Né dobbiamo dimenticare che le grandi produzioni dei musei civici o delle Gallerie dell’Accademia sono, durante la Biennale, frutto del desiderio di grandi artisti di essere presenti in città durante la manifestazione. Le loro gallerie sono dispostissime a mettere a disposizione grandi budget per la produzione di personali gigantesche, come quella allestita nel 2022 da Anselm Kiefer a Palazzo Ducale con l’aiuto della galleria Gagosian.
E questo apre un capitolo controverso, perché le gallerie in effetti si occupano della produzione di opere anche dentro alla Biennale. Le scelte dei curatori restano indipendenti, ma la maggiore o minore capacità di espressione da parte di un artista dipende da quanto viene appoggiato dall’economia di un mercante. Sì, se siamo convinti che le relazioni tra arte e mercato siano troppo intense possiamo alzare il sopracciglio: la Biennale trasforma Venezia anche in una fiera di alto livello, dove si produce, si promuove, si pongono le basi per compravendite spesso milionarie. Se fino ai primi anni Settanta questo aspetto non faceva scandalo, dal momento che esisteva un ufficio vendite proprio dentro alla Biennale stessa, gestito dal sapiente Ettore Gianferrari, oggi a mettere un po’ di angoscia sono le cifre da capogiro che circolano e anche il fatto che tutto questo non avvenga più alla luce del sole.
Oggi gallerie del calibro di Hauser & Wirth, Zwirner o la già menzionata Gagosian non lascerebbero i propri artisti in mano a un altro. E la tendenza non diminuirà, o così dovremmo sperare: soltanto le loro grandi disponibilità potranno garantire che la mostra sia ancora un dei centri mondiali dell’arte nuova. Che piaccia o meno, il denaro messo in palio dalle nazioni, a incominciare dall’Italia, da solo non ce la fa.
BIENNALE DI VENEZIA

«Hope-Hippo» (2005) di Allora e Calzadilla, alla Biennale di venezia di Okwui Enwezor nel 2015, Cortesia dell’artista e di Lisson Gallery

Peggy Guggenheim alla Biennale di Venezia del 1948

«Magiciens de la terre», 1989, Centre Pompidou Parigi