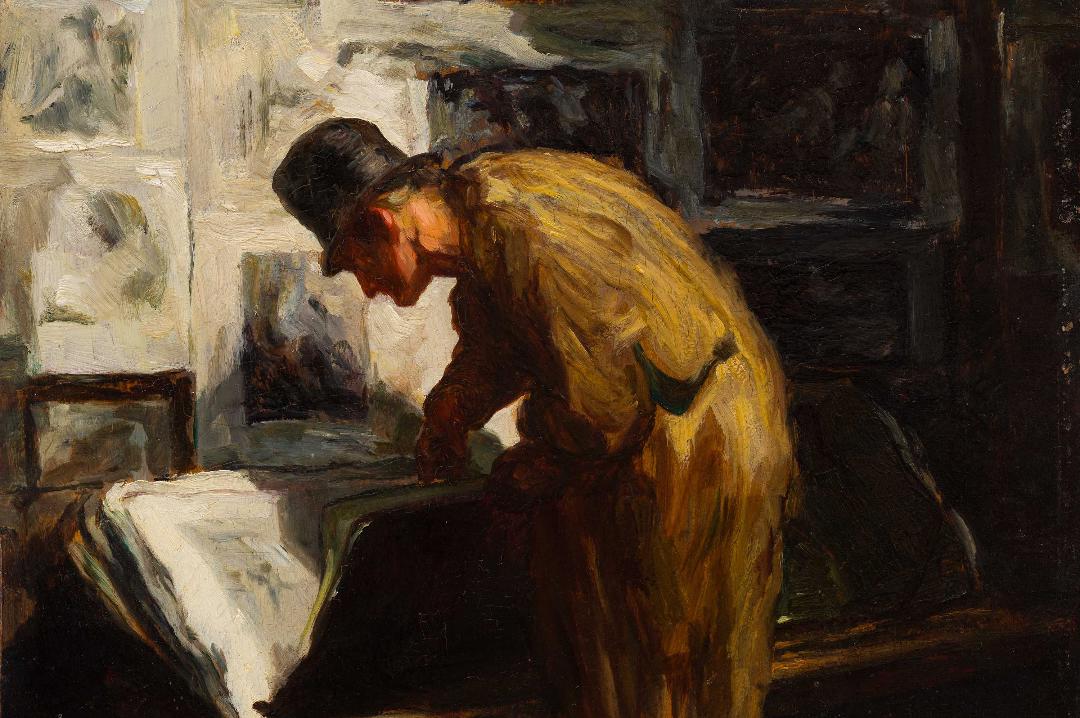Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Flavia Foradini
Leggi i suoi articoliNell’ultimo paio d’anni era calato un po’ il silenzio sul vulcanico Daniel Spoerri. Anche l’attività della sua galleria a Hadersdorf am Kamp, che aveva aperto nel 2009 a un’ora di auto da Vienna, non lo aveva visto più come vivace protagonista di mostre o serate dedicate all’arte del cibo. Mercoledì si è spento nella capitale austriaca all’età di 94 anni e si è aperto un grande vuoto nel mondo dell’arte.
La sua poliedrica personalità si esprimeva esuberante ogni volta che parlavi con lui. Era uno spumeggiante affabulatore, un narratore di infiniti, gustosi aneddoti su quel paesaggio artistico che cavalcava dagli anni Cinquanta, in cordata con uno stuolo di sodali cui rimase legato tutta la vita e che invitava a esporre sia nel Giardino che aveva creato a Seggiano, in Toscana, negli anni Novanta, sia a Hadersdorf: «Io non sono un curatore, io espongo solo quello che mi piace. La semplice verità è che questi spazi li ho creati per i miei amici, Jean Tinguely, Niki de Saint Phalle, Yves Klein, Arman, Pol Bury o Soto, Eva Aeppli, Bernhard Lüginbühl», diceva.
A Jean Tinguely lo legava un’amicizia fraterna e in occasione di una mostra a lui dedicata a Hadersdorf, mi aveva raccontato di quel sodalizio, nato quando i due erano ancora molto giovani: «Tinguely era come un fratello più grande, aveva cinque anni più di me e infatti voleva sempre darmi ordini. Lavorava come vetrinista e creava cose molto belle col filo metallico, che usava per così dire come strumento per disegnare, e aveva una passione per il movimento. Ha cominciato collegando piccole ruotine e a poco a poco ha sviluppato il movimento come mezzo artistico e di quel periodo ho un ricordo preciso: io allora ero ballerino e una volta lui mi disse: “Devi darmi dei soldi perché voglio comprarmi un motorino elettrico”. Io replicai: “E io poi di cosa vivo?”. E lui rispose: “Anch’io vivo di niente. Devo avere il motorino”. Sono cominciate così le sue sculture cinetiche».
Rumeno di nascita (1930), svizzero di adozione a causa delle persecuzioni naziste, aveva un rapporto speciale con l’Italia e con l’Austria, dove si era trasferito nel 2007. La sua prima personale la rese possibile Arturo Schwarz nel 1961 a Milano. Anche con la Galleria Mudima ha intessuto un rapporto privilegiato, e le sue mostre milanesi erano tuffi nel Nouveau Réalisme e nel suo fantasioso approccio all’arte, mentre i sedici ettari a Seggiano, disseminati di oltre cento sculture, sono un prezioso spaccato dell’evoluzione di quella forma d’arte.
Indimenticabili restano la sua idea di mostre «da sette minuti, il tempo cioè di cuocere un uovo sodo», le sue Edizioni Mat (Multiplication d’art transformable), con cui a partire dalla fine degli anni Cinquanta affermò la trasformabilità delle creazioni artistiche, con opere ideate in edizioni limitate al massimo a 100 esemplari, però sempre un po’ diversi dall’originale: «Un’opera originale costa molto e invece noi volevamo mettere in atto una democratizzazione, per rendere l’arte accessibile a tutti. Chiunque avrebbe potuto permettersi quelle opere. Noi eravamo entusiasti all’idea di creare arte per tutti, ma nessuno la voleva, mi aveva raccontato. Per cui ho smesso: nonostante il prezzo contenuto di 200 franchi francesi non ebbero il successo sperato. Riuscivo a venderne solo abbastanza per poter sopravvivere». Oggi quelle serie sono parte della storia dell’arte del secondo Novecento, come del resto il suo «Déjeuner sous l’herbe» per un’ottantina di commensali a Jouy-en-Josas, che sotterrò nel 1983 e fece dissotterrare nel 2010 con metodi scientifici, o i suoi celeberrimi «Quadri trappola» con cui coglieva l’attimo di momenti conviviali, che fissava per sempre incollando stoviglie e resti di cibo al piano del tavolo, e poi appendeva alla parete.
La sua quieta casa viennese vicino al mercato delle pulci, dove talvolta lo si poteva vedere aggirarsi fra le bancarelle, gli assomigliava: ovunque c’erano cesti e scatole piene degli oggetti più disparati, a cui lui attingeva per i suoi assemblages: «Sono sempre indaffarato, ma non lo chiamo lavoro, a me piace fare quello che faccio, mi aveva detto qualche tempo fa, sostenendo di non pensare minimamente alla morte. In passato sono stato molto triste e disperato, ma sono riuscito a uscire da quel ginepraio. Nel frattempo, quanto più mi avvicino al punto finale (chiamiamolo così) tanto più la vita è gradevole. Non fisicamente. Fisicamente è un disastro, ma la testa! In testa in realtà diventa tutto più chiaro, e più semplice, e più divertente».

Installazione di Daniel Spoerri nel giardino di Seggiano, in Toscana. © Edoardo Conte
Altri articoli dell'autore
Tra il centinaio di dipinti e le 20 stampe esposti anche la sua, forse più famosa, tela con «L’origine del mondo», che non mancherà di attrarre file di curiosi visitatori
All’Albertina, da cui mancava dal 1936, 200 opere mettono in luce la versatilità dell’artista conosciuto soprattutto per la sua vena satirica
Dal 1940 al 1945, a pochi chilometri da Mauthausen in Alta Austria, si effettuavano ricerche nel terreno sotto la guida del gruppo nazista «Kommando Spilberg», ora ricostruite da un team di studiosi
All’Albertina sono riunite una settantina di opere che coprono tutta l’attività dell’artista giapponese, creatrice del termine «Motherscape»